 Affrontare una relazione sulla rappresentazione dello spazio nel postmoderno o nel cinema postmoderno, equivale un po’ a tuffarsi al centro di un oceano, senza poter scorgere rive o approdi, salvo incappare fatalmente in un orizzonte posticcio, come capita al povero Carrey di Truman Show, uno dei film che citeremo a proposito del concetto di spazio urbano messo in scena dal cinema contemporaneo. In verità, si può scegliere un buon numero di approcci, e di qui selezionare alcune riflessioni privilegiate.
Affrontare una relazione sulla rappresentazione dello spazio nel postmoderno o nel cinema postmoderno, equivale un po’ a tuffarsi al centro di un oceano, senza poter scorgere rive o approdi, salvo incappare fatalmente in un orizzonte posticcio, come capita al povero Carrey di Truman Show, uno dei film che citeremo a proposito del concetto di spazio urbano messo in scena dal cinema contemporaneo. In verità, si può scegliere un buon numero di approcci, e di qui selezionare alcune riflessioni privilegiate.
Potremmo, ad esempio, affrontare polisemicamente i vari significati del termine “spazio cinematografico”; esiste, infatti, uno spazio filmico, determinato dal testo audiovisivo, creato cioè dalla percezione e dalla creazione di un regime plastico, che coinvolge aspetti estetici, narrativi, iconografici, architettonici, scenografici, produttivi e postproduttivi. C’è uno spazio tematizzato, determinato dalla scelta, da parte del singolo film, degli ambienti in cui esso si deve svolgere. E, infine, esiste quello che potremmo chiamare spazio dell’inquadratura, su cui ci soffermeremo subito, che interessa determinati momenti della storia del cinema, e che ha sollecitato le sistemazioni teoriche di alcuni dei più grandi studiosi della settima arte, oggi particolarmente suggestivo per i problemi posti dall’immagine elettronica e digitale applicata al cinema.
Quando parliamo di inquadratura ci troviamo di fronte a una specie di fantasma teorico, al di là dei significati tecnici o analitici di volta in volta rivestiti da questa stessa parola. Essa coinvolge aspetti di “composizione pittorica” (pensiamo alle pagine di Ejzenstein), di montaggio (interno ed esterno), di estetica, e di ontologia dell’immagine cinematografica. L’ontologia realista teorizzata da uno studioso storico come André Bazin, magari passata attraverso il filtro di Roland Barthes (non quello della semiologia eretica e creativa, ma quello della “Camera chiara”, che trova l’ontologia dell’immagine fotografia nel “qualcosa che è stato là” davanti all’obiettivo, con le notissime nozioni di studium e punctum), sembra essere, come molti critici hanno notato, messa in crisi dalla civiltà del digitale. Una cultura visiva che non ha più bisogno di un referente reale (caso mai di un modello scomponibile in dati numerici), e che quindi manda un po’ all’aria tutto il modello ontologico baziniano, il complesso della mummia e dell’imbalsamazione, degli anni ’50.
 Con Jurassic Park, Forrest Gump, Terminator 2 e decine di altri titoli si è avuta la ripresa e la riproduzione di qualcosa che “non è stato là”; questo ha significato, anche da un punto di vista tecnico, che l’unità di riferimento è l’inquadratura e che gli spazi cinematografici su cui ragionare (e da rivoluzionare) sono quelli minimi del fotogramma e del singolo stacco. L’inquadratura, quindi, torna ad essere una tela bianca da riempire secondo concetti pittorici di stampo quasi pre-cinematografico. Come sempre accade di fronte a una rivoluzione tecnologica (si pensi all’introduzione del sonoro, del colore, o del dolby stereo), la prima fase di assestamento è una fase di “involuzione”. In questi anni, dunque, il massiccio utilizzo di computer graphic è intervenuto sul singolo fotogramma e, di qui, sulla singola inquadratura, dapprima sguarnita e in seguito riempita di “meraviglie” secondo un’euforia che potremmo ribattezzare “mouse-stylo” che possiede i caratteri della “ludicità” tipica del postmoderno eccitazionista e della civiltà contemporanea che flirta con i concetti di gioco e quiz tanto cari alla cultura del sapere frammentato.
Con Jurassic Park, Forrest Gump, Terminator 2 e decine di altri titoli si è avuta la ripresa e la riproduzione di qualcosa che “non è stato là”; questo ha significato, anche da un punto di vista tecnico, che l’unità di riferimento è l’inquadratura e che gli spazi cinematografici su cui ragionare (e da rivoluzionare) sono quelli minimi del fotogramma e del singolo stacco. L’inquadratura, quindi, torna ad essere una tela bianca da riempire secondo concetti pittorici di stampo quasi pre-cinematografico. Come sempre accade di fronte a una rivoluzione tecnologica (si pensi all’introduzione del sonoro, del colore, o del dolby stereo), la prima fase di assestamento è una fase di “involuzione”. In questi anni, dunque, il massiccio utilizzo di computer graphic è intervenuto sul singolo fotogramma e, di qui, sulla singola inquadratura, dapprima sguarnita e in seguito riempita di “meraviglie” secondo un’euforia che potremmo ribattezzare “mouse-stylo” che possiede i caratteri della “ludicità” tipica del postmoderno eccitazionista e della civiltà contemporanea che flirta con i concetti di gioco e quiz tanto cari alla cultura del sapere frammentato.
Il cinema americano tecnologico, quindi, ha spesso rinunciato al movimento e alla fluidità del montaggio, allo scopo di mostrare i prodigi delle nuove tecnologie, e le “magie” della generazione digitale. Il corvo, Independence Day, Godzilla, Jumanji, Batman e Robin, Al di là dei sogni, Lost in Space e decine di altri titoli si propongono, più o meno valorosamente, come pionieri del nuovo effetto speciale digitale, alla ricerca di una nuova rappresentazione dello spazio diegetico che sia equidistante tanto dall’abortito tentativo di produrre tridimensionalità al cinema quanto dalla definitiva sistemazione di un nuovo orizzonte percettivo ancora oggi indeciso tra i vari modelli iconografici. Come scrissi su un numero monografico di Cineforum (1) dedicato proprio al concetto di inquadratura, “che senso avrebbe avuto per lo spettatore affamato di stupefazione vedere un film che dichiara il proprio uso euforico digitale e poi lo spreca con banali campi/controcampi?”. Aggiunge giustamente Manlio Brusatin (2): “L’isteria crescente di distinguere il falso e l’autentico in ogni produzione è ancora una colorata falsificazione del tutto necessaria: il falso si sta probabilmente collocando tra una eccessiva somiglianza e un mancato riconoscimento…”
 Ecco che, tornando alla nostra riflessione principale, l’inquadratura cinematografica diventa una vetrina, un’esposizione universale dei dolciumi digitali, in cui produrre una ricerca sensazionalistica sui colori (ad es. il recupero delle tonalità Technicolor di Titanic), sull’estetica del mostruoso e del teratomorfo (gli alieni anni ’90), sulla digitalizzazione del cinema animato (Disney, Pixar, DreamWorks, etc.), etc. Sembra quindi uno scenario in certo qual modo similare a quello di fine ‘800, durante il quale, alla fine di un lungo processo di sfibramento dell’esperienza artistica classica, si afferma una civiltà ottica, prestidigitatoria e magico-scientifica, con panorami, diorami, lanterne magiche, praxinoscopi e tutto quello che comunemente si definisce “pre-cinema”. Concetto caro a Philippe Hamon, questo che mette in relazione fine ‘800, in virtù delle caratteristiche culturali sopra esposte, e fine ‘900, scorcio di millennio altrettanto dominato da rivoluzionarie tecniche in grado di mutare per sempre la nostra percezione della realtà e i regimi scopici della vita quotidiana attraverso una complessa relazione intermediale tra i vari mezzi di comunicazione.
Ecco che, tornando alla nostra riflessione principale, l’inquadratura cinematografica diventa una vetrina, un’esposizione universale dei dolciumi digitali, in cui produrre una ricerca sensazionalistica sui colori (ad es. il recupero delle tonalità Technicolor di Titanic), sull’estetica del mostruoso e del teratomorfo (gli alieni anni ’90), sulla digitalizzazione del cinema animato (Disney, Pixar, DreamWorks, etc.), etc. Sembra quindi uno scenario in certo qual modo similare a quello di fine ‘800, durante il quale, alla fine di un lungo processo di sfibramento dell’esperienza artistica classica, si afferma una civiltà ottica, prestidigitatoria e magico-scientifica, con panorami, diorami, lanterne magiche, praxinoscopi e tutto quello che comunemente si definisce “pre-cinema”. Concetto caro a Philippe Hamon, questo che mette in relazione fine ‘800, in virtù delle caratteristiche culturali sopra esposte, e fine ‘900, scorcio di millennio altrettanto dominato da rivoluzionarie tecniche in grado di mutare per sempre la nostra percezione della realtà e i regimi scopici della vita quotidiana attraverso una complessa relazione intermediale tra i vari mezzi di comunicazione.
 Se, quindi, l’inquadratura diventa un dato “digitalizzabile”, ovvero uno spazio matematico, concettualmente iper-scomponibile e deterministicamente vuoto, potrebbero tornare utili alcune parole di Gilles Deleuze (3) che sembrava aver intuito in termini filosofici la portata della questione: “Se il quadro (inquadratura, nda) ha un analogo, esso ha più a che vedere con un sistema informatico che linguistico. Gli elementi sono dati a volte assai numerosi, a volte in numero ristretto. Il quadro è dunque inseparabile da due tendenze, verso la saturazione, o verso la rarefazione.” Un’operazione come il rilancio Star Wars vent’anni dopo, ci offre la possibilità di ricordare la pratica tutta postmoderna della riedizione aggiornata di un film (cui partecipa anche il concetto di director’s cut): il film di Lucas viene investito di una operazione di restyling estetico, un lifting digitale incaricato di revisionare il prodotto secondo i nuovi codici iconografici della fine degli anni ’90: nuovi alieni, nuovi sfondi, nuovi laser, più battaglie, più personaggi, più stupore. Ancora il concetto di vetrina e di esposizione.
Se, quindi, l’inquadratura diventa un dato “digitalizzabile”, ovvero uno spazio matematico, concettualmente iper-scomponibile e deterministicamente vuoto, potrebbero tornare utili alcune parole di Gilles Deleuze (3) che sembrava aver intuito in termini filosofici la portata della questione: “Se il quadro (inquadratura, nda) ha un analogo, esso ha più a che vedere con un sistema informatico che linguistico. Gli elementi sono dati a volte assai numerosi, a volte in numero ristretto. Il quadro è dunque inseparabile da due tendenze, verso la saturazione, o verso la rarefazione.” Un’operazione come il rilancio Star Wars vent’anni dopo, ci offre la possibilità di ricordare la pratica tutta postmoderna della riedizione aggiornata di un film (cui partecipa anche il concetto di director’s cut): il film di Lucas viene investito di una operazione di restyling estetico, un lifting digitale incaricato di revisionare il prodotto secondo i nuovi codici iconografici della fine degli anni ’90: nuovi alieni, nuovi sfondi, nuovi laser, più battaglie, più personaggi, più stupore. Ancora il concetto di vetrina e di esposizione.
Esposizione universale (Parigi 1900 come nascita del postmoderno e civiltà digitale come possibile, continuativa, prominenza post-postmoderna?), ma anche esposizione della scienza nelle sue immediate valenze epistemologiche. Ricordiamo le varie proposte di studiosi che considerano postmoderne tutte le pratiche scientifico-tecnologiche tese all’immediato sfruttamento pubblico e commerciale della propria utilità come unica “assicurazione” della propria esistenza e della propria appartenenza al novero delle scienze universali. In secondo luogo, spostandoci da un piano teorico-speculativo ad uno più squisitamente critico ed empirico, ci sembra che il cinema tecnologico contemporaneo abbia continuato, negli anni, a riempire ossessivamente i propri spazi con altri schermi, video, superfici riflettenti, inquadrature dentro le inquadrature, mise-en-abyme incaricate di dotare il cinema di iperspazialità, nel conflitto sempre più pesante con gli altri mezzi di comunicazione, specie quelli “simulativi” dei new media. Pensiamo a film come Fino alla fine del mondo, Nirvana, Strange Days, Johnny Mnemonico, Rivelazioni, Omicidio in diretta, Mission: Impossible, senza parlare del capostipite Blade Runner, da sedici-diciassette anni leader incontrastato per numero di studi, saggi, tesi, tesine, corsi accademici e quant’altro, oltre che oggetto privilegiato per gli specialisti di postmoderno (4).
Pensiamo a film come Fino alla fine del mondo, Nirvana, Strange Days, Johnny Mnemonico, Rivelazioni, Omicidio in diretta, Mission: Impossible, senza parlare del capostipite Blade Runner, da sedici-diciassette anni leader incontrastato per numero di studi, saggi, tesi, tesine, corsi accademici e quant’altro, oltre che oggetto privilegiato per gli specialisti di postmoderno (4).
In verità il rapporto tematizzato tra cinema e computer ha prodotto risultati francamente imbarazzanti. E non parliamo tanto della dubbia qualità di film come Tron, Il tagliaerbe, Johnny Mnemonico, Mortal Kombat, Viol@, etc., quanto piuttosto della pesante assenza di progettualità teorica e di urgenza espressiva quali si trovano, invece, nella letteratura cosiddetta cyberpunk.
In essa, infatti, oltre a una decina di intuizioni radicali, hanno trovato singolare espressione le trasfigurazioni simboliche più urgenti suggerite dal mutato rapporto tra io e mondo, io e comunicazione, io e corpo, corpo e percezione, corpo e realtà fenomenica, io, corpo e dato inorganico. In un recente e approfonditissimo saggio di Brian McHale (5), si riconosce a questa letteratura di anticipazione (6) un’approfondita elaborazione della civiltà digitale oltre che un momento determinante delle estetiche postmoderne (7).
 Riguardo al rapporto con la fantascienza classica, McHale dice “Nel cyberpunk la forma più caratteristica del mondo-inserto (della fantascienza classica, nda) è il cyberspazio (termine coniato da Gibson), lo spazio generato dal computer che viene sperimentato dagli operatori il cui sistema nervoso è direttamente interfacciato con il computer. (…) Più in generale il tema del cyberspazio nasce da una potente illusione, che tutti gli utenti di computer (io credo) hanno provato, a prescindere dalla loro maggiore o minore abilità tecnica: l’illusione di guardare in, o addirittura di muoversi dentro, uno spazio che in qualche modo sta “all’interno” o “al di là” dello schermo del monitor.” McHale ricorda, poi, i titoli letterari nei quali il punto di vista narrativo, durante il racconto delle “incursioni” nel ciberspazio, muta sino ad assumere un’indecidibilità di fondo tra uomo e donna, protagonista umano e interfaccia inorganica, io pensante e macchina intelligente.
Riguardo al rapporto con la fantascienza classica, McHale dice “Nel cyberpunk la forma più caratteristica del mondo-inserto (della fantascienza classica, nda) è il cyberspazio (termine coniato da Gibson), lo spazio generato dal computer che viene sperimentato dagli operatori il cui sistema nervoso è direttamente interfacciato con il computer. (…) Più in generale il tema del cyberspazio nasce da una potente illusione, che tutti gli utenti di computer (io credo) hanno provato, a prescindere dalla loro maggiore o minore abilità tecnica: l’illusione di guardare in, o addirittura di muoversi dentro, uno spazio che in qualche modo sta “all’interno” o “al di là” dello schermo del monitor.” McHale ricorda, poi, i titoli letterari nei quali il punto di vista narrativo, durante il racconto delle “incursioni” nel ciberspazio, muta sino ad assumere un’indecidibilità di fondo tra uomo e donna, protagonista umano e interfaccia inorganica, io pensante e macchina intelligente.
Questi micromondi o mondi-inserto del paraspazio computerizzato trovano scarsa applicazione nel cinema contemporaneo, così come le istanze più “scandalose” della revisione dei concetti di punto di vista antropomorfo (8), genere sessuale, focalizzazione interna ed esterna, etc. Insomma, a partire dalle nuove tecnologie, secondo il movimento (non solo letterario) cyberpunk, a mutare non sono solo le più superficiali manifestazioni della rappresentazione e dello “spettacolo quotidiano” della tecnologia espansa, ma anche nozioni tradizionali quali quelle di racconto, di produzione di testi, di attribuzione delle responsabilità politiche, e più in genere di autorità in senso lato (di qui l’interesse per questa letteratura da parte dei new feminist studies, dei gender studies, delle riviste che si occupano di postmoderno e mutazione della prospettiva epistemologica). Il film che sembra aver meglio di altri colto la straordinaria ricchezza di una tale impostazione è Strange Days di Kathryn Bigelow, durante il quale l’assassino si mette in contatto con la propria vittima trasferendole la “gioia” della violenza e determinando un pazzesco quanto vertiginoso conflitto esperienziale: vittima e carnefice partecipano delle stesse, doppie e contraddittorie, emozioni; la vittima muore nel terrore ma “sente” l’efferata eccitazione del maniaco omicida. Gode del proprio stesso insensato dolore.
 Hollywood, in verità, sembra ragionare preferibilmente sui concetti di audiovisivo imploso (Natural Born Killers, Da morire), di rappresentazione metalinguistica dell’effetto speciale (MIB, La morte ti fa bella) e, soprattutto, di riflessione sull’idea di “falso”. Pensiamo, infatti, ai casi più eclatanti di “falsificazione” della storia e del documento storico che si trovano in film come JFK, di Oliver Stone, nel quale il famoso filmato amatoriale di Zapruder viene letteralmente rigirato, raddoppiato, “copiato” e mescolato subliminalmente a quello vero. O ricordiamo anche Forrest Gump, straordinario esempio di interferenza finzionale nel corso della storia statunitense: Gump stringe la mano a Kennedy, Gump “abita” i documenti storici come l’intervista a Lennon, Gump entra direttamente nell’universo già storicizzato dei media universali. In verità un dato su cui ragionare ci sarebbe: non si dà “falso” nel cinema, o meglio non ci vengono a mente esempi di opera d’arte falsa come esistono nella pittura, nella scultura, nelle arti figurative o persino nella musica e nella letteratura.
Hollywood, in verità, sembra ragionare preferibilmente sui concetti di audiovisivo imploso (Natural Born Killers, Da morire), di rappresentazione metalinguistica dell’effetto speciale (MIB, La morte ti fa bella) e, soprattutto, di riflessione sull’idea di “falso”. Pensiamo, infatti, ai casi più eclatanti di “falsificazione” della storia e del documento storico che si trovano in film come JFK, di Oliver Stone, nel quale il famoso filmato amatoriale di Zapruder viene letteralmente rigirato, raddoppiato, “copiato” e mescolato subliminalmente a quello vero. O ricordiamo anche Forrest Gump, straordinario esempio di interferenza finzionale nel corso della storia statunitense: Gump stringe la mano a Kennedy, Gump “abita” i documenti storici come l’intervista a Lennon, Gump entra direttamente nell’universo già storicizzato dei media universali. In verità un dato su cui ragionare ci sarebbe: non si dà “falso” nel cinema, o meglio non ci vengono a mente esempi di opera d’arte falsa come esistono nella pittura, nella scultura, nelle arti figurative o persino nella musica e nella letteratura.
Due recentissimi casi di “falso” tematizzato, invece, hanno ottenuto l’attenzione di critici e studiosi. In Truman Show e Dark City i protagonisti vengono ingannati e rinchuisi in città immaginarie che sono, in verità, costruzioni realizzate da demiurghi capaci di controllare un intero mondo.
Truman crede, deterministicamente, di vivere una vita reale e invece abita un mondo fasullo, ma più vero del vero (come comprendiamo facilmente dal “controcampo” squallido del mondo reale, con il gruppo di spettatori-campione incollato davanti alla TV). I protagonisti di Dark City sono cavie prelevate dagli alieni e gettate con ricordi e sensazioni altrui in un mondo-città che muta continuamente, puro parto della fantasia riproduttiva degli extraterrestri in vena di sperimentazioni.
 Questa dialettica tra topografia e identità, derealizzazione degli spazi conosciuti e iperrealizzazione dell’esperienza comunitaria, offre poi una serie di spunti piuttosto interessanti per ciò che riguarda due fondamentali oggetti privilegiati del cinema contemporaneo: la città, appunto, e la frontiera. L’immaginario urbano, investito da sempre di importanza capitale (pensiamo al ruolo che riveste nel sistema dei generi della Hollywood classica, nel noir o nel melodramma), assume nel cinema postmoderno i caratteri di cumulatività e fumettizzazione che tutti abbiamo sotto gli occhi.
Questa dialettica tra topografia e identità, derealizzazione degli spazi conosciuti e iperrealizzazione dell’esperienza comunitaria, offre poi una serie di spunti piuttosto interessanti per ciò che riguarda due fondamentali oggetti privilegiati del cinema contemporaneo: la città, appunto, e la frontiera. L’immaginario urbano, investito da sempre di importanza capitale (pensiamo al ruolo che riveste nel sistema dei generi della Hollywood classica, nel noir o nel melodramma), assume nel cinema postmoderno i caratteri di cumulatività e fumettizzazione che tutti abbiamo sotto gli occhi.
I casi sono molteplici, tanto che si potrebbe azzardare una casistica.
1) la città della memoria o della nostalgia: concetto caro a postmodernisti come Jameson, che quando applicano il loro metodo postmarxista al cinema trovano qualche difficoltà, ovvero la ricostruzione di un passato euforicamente eccitante quanto pignolescamente ricostruito. Pensiamo a Twin Peaks, oggetto da mondo parallelo degli anni ’50 (e qui valgono le riflessioni fatte per il filone dello steampunk); a Edward mani di forbice, modellino di applicazione urbanistica, piccolo agglomerato di provincia verofalso, precipitato di memorie del passato tra moda, costume, cinema e Tv. La signora ammazzatutti di Waters, che trasforma Baltimora in un assurdo capolavoro di pop-art bloccata e riavvolta agli anni ’60 e ’70; le memorie del “noir”, dalla L.A. hard-boiled di L.A.Confidential (ma bisognerebbe portare sullo schermo I miei luoghi oscuri sempre di Ellroy, dove l’indicazione geografica della great L.A. diventa un sublime esercizio di letteratura urbanistica), alla L.A. del vicinissimo passato del Grande Lebowski, mondo di storie e oggetti inorganici, dove precipita stratificata l’intera storia della città.
Fino alla città finzionale per eccellenza, quella di Seven, che non viene nominata, dove piove ininterrottamente, e che diventa epitome della metropoli del vizio e della violenza contemporanea; essa ha caratteri iconografici piuttosto indistinti, e attraverso la quale si muove indisturbato l’assassino John Doe, che in Usa equivale a “Pinco Pallino”: nulla è più nominabile, la città non può essere controllata, l’assassino si consegna “dentro” alla stazione di polizia (una volta bastava piazzare delle bandierine sulla cartina della città e il gioco era fatto), le abitazioni non riescono più a trattenere la metropoli fagocitante fuori dalla città: basti ricordare che il detective protagonista deve dormire con un metronomo in funzione allo scopo di “organizzare” il caos sonoro che lo aggredisce, stimolando lontane memorie avanguardistiche di città sinfoniche).
2) La città senza più punti di riferimento. Come dice Kevin Lynch, nel suo Image of the City, essa ci sembra caratteristica acquisita dalla metropoli contemporanea, e esempio colto sublimemente da certo recentissimo cinema. Ci riferiamo a T2, nel quale l’inseguimento “orizzontale” che costituisce il vettore del film sembra tagliare fuori una dimensione metropolitana gerarchizzata e omologata.
A Strange Days (la città è talmente violenta e insopportabile che si preferisce di gran lunga l’esperienza e lo spazio della corteccia cerebrale); a The Game, città-gioco da attraversare come una gara a premi, buia e insensata, segnata dalle tappe di un enorme Monopoli; a Lola corre, videogioco in cui gli spazi cittadini sono schematici, colorati, reticolari, pura griglia di riferimento per la corsa della protagonista nel labirinto deciso dal creatore, fino alle due città per eccellenza, sopracitate: i falsi assoluti di Truman Show, e Dark City.
3) La città dei “non-luoghi”, per utilizzare una nozione cara a Marc Augé (9) (con le tante interpretazioni errate e fraintendimenti che essa ha determinato), presente in Crash, Kids, nei film a dominante spaziale unitaria: le figure del mall (10) (T2), del bowling (Il grande Lebowski), l’aeroporto (Die Hard II) o il centro convegni (The Peacemaker), lo stadio (Panico allo stadi o), Las Vegas…
4) La città, ancora solida, dell’accumulo architettonico, a partire da Blade Runner analizzato da decine di studi (e più profondamente da David Harvey), terminus a quo fondamentale : la città di sotto, la città di sopra (Il quinto elemento offre una città a piani), ma vanno ricordate almeno le città di Brazil, Fuga da New York, fino alle città plastiche desunte dalla cultura del fumetto, in cui convivono esperienze architettoniche verosimili ed universi “impossibili”: Burton, Il corvo, Darkman, etc.
In tutti questi casi, si assiste alla frammentazione dell’esperienza urbana e dell’identità comunitaria (oltre che dell’identità personale, erosa dalla civiltà post-tecnologica e discontinua del postmoderno). Inevitabilmente, come ricorda ancora Augé, la civiltà senza frontiere produce particolarismi residuali e ossessivi, insieme conseguenza e contraddizione della crisi di un’istituzione pienamente moderna come quella di stato. Chi non si accontenta di vivere in una civiltà simulacrale (e qui prendiamo a prestito alcuni termini di Baudrillard), reagisce in modo aberrante, e il cinema ha messo in scena sia la crisi che la reazione del concetto di frontiera. La seconda guerra civile americana di Joe Dante parla proprio di questo scacco e di questo paradosso della proliferazione dei particolarismi.
Ritornando quindi al titolo dell’intervento, ci sembra che con il recente trionfo del falso di fine secolo e attraverso la tematizzazione degli spazi irreali, si sia giunti a un punto di precipitazione delle spinte postmoderne verso la disgregazione di ogni spazio coerente e costituito del vivere comune. Questioni strettamente collegate all’identità del personaggio, alla revisione del corpo, e alla proliferazione dei mezzi di comunicazione e dei sistemi di rappresentazione presenti al cinema. Rimane da scoprire, magari nello spazio 2009, se il cinema avrà esso stesso proposto un nuovo concetto di spazio cinematografico che tenga conto sia delle nuove tecnologie ad esso applicate sia degli universi da esso rappresentati; che sappia raccogliere la sfida posta dalla letteratura contemporanea, e che entri in un’epoca in cui non si preoccupa solamente della sua legittimazione estetica in contrasto con gli altri intrusivi media, ma intraprende percorsi narrativi e iconografici anche solo simbolicamente in grado di trasferire nella forma-film l’incombenza delle nuove tecnologie sulla produzione artistica. Allora, forse, si potrà parlare di reale discontinuità con l’istanza pienamente “moderna” della macchina-cinema, e quindi nominare un vero e proprio cinema postmoderno, tale nella prassi e non solo nell’esuberanza dei materiali iconico-narrativi.

 1) la città della memoria o della nostalgia: concetto caro a postmodernisti come Jameson, che quando applicano il loro metodo postmarxista al cinema trovano qualche difficoltà, ovvero la ricostruzione di un passato euforicamente eccitante quanto pignolescamente ricostruito. Pensiamo a Twin Peaks, oggetto da mondo parallelo degli anni ’50 (e qui valgono le riflessioni fatte per il filone dello steampunk); a Edward mani di forbice, modellino di applicazione urbanistica, piccolo agglomerato di provincia verofalso, precipitato di memorie del passato tra moda, costume, cinema e Tv. La signora ammazzatutti di Waters, che trasforma Baltimora in un assurdo capolavoro di pop-art bloccata e riavvolta agli anni ’60 e ’70; le memorie del “noir”, dalla L.A. hard-boiled di L.A.Confidential (ma bisognerebbe portare sullo schermo I miei luoghi oscuri sempre di Ellroy, dove l’indicazione geografica della great L.A. diventa un sublime esercizio di letteratura urbanistica), alla L.A. del vicinissimo passato del Grande Lebowski, mondo di storie e oggetti inorganici, dove precipita stratificata l’intera storia della città.
1) la città della memoria o della nostalgia: concetto caro a postmodernisti come Jameson, che quando applicano il loro metodo postmarxista al cinema trovano qualche difficoltà, ovvero la ricostruzione di un passato euforicamente eccitante quanto pignolescamente ricostruito. Pensiamo a Twin Peaks, oggetto da mondo parallelo degli anni ’50 (e qui valgono le riflessioni fatte per il filone dello steampunk); a Edward mani di forbice, modellino di applicazione urbanistica, piccolo agglomerato di provincia verofalso, precipitato di memorie del passato tra moda, costume, cinema e Tv. La signora ammazzatutti di Waters, che trasforma Baltimora in un assurdo capolavoro di pop-art bloccata e riavvolta agli anni ’60 e ’70; le memorie del “noir”, dalla L.A. hard-boiled di L.A.Confidential (ma bisognerebbe portare sullo schermo I miei luoghi oscuri sempre di Ellroy, dove l’indicazione geografica della great L.A. diventa un sublime esercizio di letteratura urbanistica), alla L.A. del vicinissimo passato del Grande Lebowski, mondo di storie e oggetti inorganici, dove precipita stratificata l’intera storia della città.  Fino alla città finzionale per eccellenza, quella di Seven, che non viene nominata, dove piove ininterrottamente, e che diventa epitome della metropoli del vizio e della violenza contemporanea; essa ha caratteri iconografici piuttosto indistinti, e attraverso la quale si muove indisturbato l’assassino John Doe, che in Usa equivale a “Pinco Pallino”: nulla è più nominabile, la città non può essere controllata, l’assassino si consegna “dentro” alla stazione di polizia (una volta bastava piazzare delle bandierine sulla cartina della città e il gioco era fatto), le abitazioni non riescono più a trattenere la metropoli fagocitante fuori dalla città: basti ricordare che il detective protagonista deve dormire con un metronomo in funzione allo scopo di “organizzare” il caos sonoro che lo aggredisce, stimolando lontane memorie avanguardistiche di città sinfoniche).
Fino alla città finzionale per eccellenza, quella di Seven, che non viene nominata, dove piove ininterrottamente, e che diventa epitome della metropoli del vizio e della violenza contemporanea; essa ha caratteri iconografici piuttosto indistinti, e attraverso la quale si muove indisturbato l’assassino John Doe, che in Usa equivale a “Pinco Pallino”: nulla è più nominabile, la città non può essere controllata, l’assassino si consegna “dentro” alla stazione di polizia (una volta bastava piazzare delle bandierine sulla cartina della città e il gioco era fatto), le abitazioni non riescono più a trattenere la metropoli fagocitante fuori dalla città: basti ricordare che il detective protagonista deve dormire con un metronomo in funzione allo scopo di “organizzare” il caos sonoro che lo aggredisce, stimolando lontane memorie avanguardistiche di città sinfoniche). A Strange Days (la città è talmente violenta e insopportabile che si preferisce di gran lunga l’esperienza e lo spazio della corteccia cerebrale); a The Game, città-gioco da attraversare come una gara a premi, buia e insensata, segnata dalle tappe di un enorme Monopoli; a Lola corre, videogioco in cui gli spazi cittadini sono schematici, colorati, reticolari, pura griglia di riferimento per la corsa della protagonista nel labirinto deciso dal creatore, fino alle due città per eccellenza, sopracitate: i falsi assoluti di Truman Show, e Dark City.
A Strange Days (la città è talmente violenta e insopportabile che si preferisce di gran lunga l’esperienza e lo spazio della corteccia cerebrale); a The Game, città-gioco da attraversare come una gara a premi, buia e insensata, segnata dalle tappe di un enorme Monopoli; a Lola corre, videogioco in cui gli spazi cittadini sono schematici, colorati, reticolari, pura griglia di riferimento per la corsa della protagonista nel labirinto deciso dal creatore, fino alle due città per eccellenza, sopracitate: i falsi assoluti di Truman Show, e Dark City. 4) La città, ancora solida, dell’accumulo architettonico, a partire da Blade Runner analizzato da decine di studi (e più profondamente da David Harvey), terminus a quo fondamentale : la città di sotto, la città di sopra (Il quinto elemento offre una città a piani), ma vanno ricordate almeno le città di Brazil, Fuga da New York, fino alle città plastiche desunte dalla cultura del fumetto, in cui convivono esperienze architettoniche verosimili ed universi “impossibili”: Burton, Il corvo, Darkman, etc.
4) La città, ancora solida, dell’accumulo architettonico, a partire da Blade Runner analizzato da decine di studi (e più profondamente da David Harvey), terminus a quo fondamentale : la città di sotto, la città di sopra (Il quinto elemento offre una città a piani), ma vanno ricordate almeno le città di Brazil, Fuga da New York, fino alle città plastiche desunte dalla cultura del fumetto, in cui convivono esperienze architettoniche verosimili ed universi “impossibili”: Burton, Il corvo, Darkman, etc.










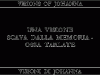

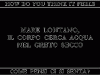





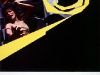
















Commenti
Non ci sono ancora commenti