
Ho pensato di offrirvi non solo le briciole di alcune ipotesi fatte sul cinema di questi ultimi vent’anni per il lavoro della mia Storia del cinema italiano, ma anche alcune considerazioni più pertinenti alle caratteristiche di questo film. Dillinger è morto è un film della fine degli anni Sessanta, che in maniera esemplare raccoglie vari tipi di meditazione sullo spettacolo, sulla condizione dell’uomo contemporaneo, varie riflessioni sui media, sulle relazioni interpersonali, sull’uso dei linguaggi ecc. Vi offro adesso come aperitivo almeno tre punti del discorso che intendo sviluppare.
Uno è un discorso sulle misure di scala, che il cinema italiano del dopoguerra affronta e trasforma. Che cosa vuol dire misure di scala? Le misure di scala sono rapporti che il cinema si propone di rappresentare ponendo come unità di misura la figura umana. La figura umana e il suo rapporto con la realtà che la circonda. A partire dal Neorealismo. Una delle caratteristiche che mi sembra aver individuato nel cinema neorealista, è che c’è proprio questo desiderio di ristabilire quelle misure di scala che erano state compromesse nel cinema precedente.
Il cinema durante il fascismo tendeva ad eliminare qualcosa: soggetti storici, eliminare degli spazi delle realtà, eliminare quelli che erano i rapporti interpersonali su base di misure di scala normalizzate. Il cinema del dopoguerra ci dà in maniera visibile (fisicamente e intellettualmente) e riutilizzabile, anche in senso didattico, il senso di riacquisiti rapporti tra le persone in uno spazio che è di nuovo uno spazio di tipo rinascimentale, in cui ogni rapporto è rapporto regolato da leggi prospettiche, da leggi naturali, da leggi di equilibrio di rapporti interni. L’uomo rimisura il suo spazio: questo è importante, proprio in rapporto al film che vediamo questa sera, perché nel film di Ferreri l’uomo non rimisura proprio nessuno spazio. Ci troviamo all’interno di uno spazio minimo: poche stanze di un appartamento in cui non esiste più nessuna misura di scala. Lo vedete subito dalle prime immagini, in cui addirittura non si può parlare di misure di scala, in quanto hai l’impressione che siano già immagini di rapporti stravolti, addirittura non hai più neanche un uomo davanti, ma hai di fronte un uomo mascherato, con una specie di maschera antigas, che si muove in riprese anche in piani molto ravvicinati, in una realtà con cui i termini di confronto, gli appigli sono quasi inesistenti. Questa condizione abnorme — che è quella del suo lavoro, e te lo spiega subito, te lo dà in modo evidente — viene poi trasferita anche nella sua realtà di gesti quotidiani all’interno di questo appartamento dove con ogni gesto si dà la misura della mancanza di rapporti funzionali con lo spazio che gli sta intorno.
 Quindi un elemento su cui si potrebbe discutere, è appunto quello di pensare un attimo a cosa ha significato per il cinema di questi ultimi vent’anni il rapporto fra la rappresentazione dell’individuo e degli individui e il loro spazio circostante. Queste misure di scala che lentamente, a partire dai primi anni ’60 (diciamo banalmente, perché tutti li conoscete, dai film di Antonioni, che sono quelli più facili, in cui viene stravolto, poco per volta, il taglio degli spazi; il rapporto degli individui, le relazioni tra l’uno e l’altro sono anormali) sono squilibrati in un certo senso, per cui si ha l’impressione che questo paesaggio, che faceva corpo con i personaggi, e assorbiva in modo naturale le loro relazioni, alle volte prevarichi su di loro, si umanizzi e le persone diventino cose. Questo è un problema che si sente anche in questo film: ci sono gli oggetti che hanno una presenza ossessiva, quasi totemica. Quindi questo è un primo punto che possiamo mettere nel nostro ordine del giorno.
Quindi un elemento su cui si potrebbe discutere, è appunto quello di pensare un attimo a cosa ha significato per il cinema di questi ultimi vent’anni il rapporto fra la rappresentazione dell’individuo e degli individui e il loro spazio circostante. Queste misure di scala che lentamente, a partire dai primi anni ’60 (diciamo banalmente, perché tutti li conoscete, dai film di Antonioni, che sono quelli più facili, in cui viene stravolto, poco per volta, il taglio degli spazi; il rapporto degli individui, le relazioni tra l’uno e l’altro sono anormali) sono squilibrati in un certo senso, per cui si ha l’impressione che questo paesaggio, che faceva corpo con i personaggi, e assorbiva in modo naturale le loro relazioni, alle volte prevarichi su di loro, si umanizzi e le persone diventino cose. Questo è un problema che si sente anche in questo film: ci sono gli oggetti che hanno una presenza ossessiva, quasi totemica. Quindi questo è un primo punto che possiamo mettere nel nostro ordine del giorno.
Un secondo punto che mi sembra altrettanto interessante è quello del disturbo, degli elementi di disturbo nella comunicazione. Questo film è praticamente un’opera in cui i messaggi verbali sono ridotti quasi a zero. È uno dei film meno parlati, in cui tutto il discorso avviene attraverso il rapporto funzionale o non funzionale con gli oggetti e con l’ambiente, una quantità di gesti comuni, a cui si conferisce un determinato valore, di gesti di apparenza disgregati, ma di fatto tutti rigorosamente funzionalizzati. È un film spietato nel suo meccanismo quasi matematico della dimostrazione: è un film che vuole dimostrare qualcosa e subito ti accorgi che ti porta inesorabilmente verso questa dimostrazione. E dentro a questo meccanismo matematico intervengono media esterni che agiscono come elementi di disturbo. E sono tanti, e fanno parte del senso di horror vacui del personaggio, della sensazione che ha di muoversi in uno spazio pneumatico, per cui ha bisogno di elementi esterni, di comunicazioni dall’esterno, che sono come dei surrogati di realtà: sono altre realtà, che surrogano sempre la realtà (guardate il filmino in superotto che è proprio il senso esatto del surrogato di realtà). Ma anche sono elementi di disturbo, che in qualche modo ritardano il senso di un meccanismo inesorabile, che va avanti verso una scadenza tutto sommato prevedibile, tutto sommato ad una sola scelta; non c’è quasi scelta in questo meccanismo narrativo.
 Terzo punto che mi sembrerebbe interessante da discutere è quello dell’itinerario linguistico dell’italiano, del profilo linguistico dei personaggi del cinema italiano, che in questo caso altrettanto giunge quasi a un livello zero: i personaggi qui parlano poco, ma hanno alle spalle una decina d’anni di riflessione sull’uso dei linguaggi, sul senso di disgregazione dei linguaggi, che viene dopo tutto un itinerario di mitologie che si sono variamente accavallate. Prima nel ripercorrere le mille e una Italia con mille e uno linguaggi dialettali; poi alla metà degli anni ’50con i film come Poveri ma belli, ecc. o i film di Pasolini, che hanno portato a una sorta di piginizzazione del romanesco, cioè a una lingua minima, parlata nelle borgate di Roma e Trastevere, che diventa un modello nazionale, e impone le sue forme di parlata sul piano nazionale (“Va ‘mmorì ammazzato” o forme così del linguaggio familiare molto colorate entrano normalmente nel lessico nazionale familiare e vengono imposte da questo importante fenomeno di piginizzazione, che si conosce benissimo in linguistica ma che non è stato mai studiato nella realtà cinematografica). E poi, dagli anni ’60, una serie di fenomeni nuovi, dati dall’uscita del mito delle microrealtà romanesche che possono imporre i loro modelli a livello nazionale e dalla scoperta che esistono dei linguaggi dei media, che impongono i loro modelli, unificano, omogenizzano, ecc. Quel discorso che verso la metà degli anni ’60 Pasolini aveva fatto con un famoso saggio edito su Rinascita (Nuove questioni linguistiche) in cui esordiva dicendo: “Io affermo che è nato l’italiano nazionale”. L’italiano nazionale è quello che parla la televisione, e che ci impone, con l’iterazione e l’accumulazione ipertrofica.
Terzo punto che mi sembrerebbe interessante da discutere è quello dell’itinerario linguistico dell’italiano, del profilo linguistico dei personaggi del cinema italiano, che in questo caso altrettanto giunge quasi a un livello zero: i personaggi qui parlano poco, ma hanno alle spalle una decina d’anni di riflessione sull’uso dei linguaggi, sul senso di disgregazione dei linguaggi, che viene dopo tutto un itinerario di mitologie che si sono variamente accavallate. Prima nel ripercorrere le mille e una Italia con mille e uno linguaggi dialettali; poi alla metà degli anni ’50con i film come Poveri ma belli, ecc. o i film di Pasolini, che hanno portato a una sorta di piginizzazione del romanesco, cioè a una lingua minima, parlata nelle borgate di Roma e Trastevere, che diventa un modello nazionale, e impone le sue forme di parlata sul piano nazionale (“Va ‘mmorì ammazzato” o forme così del linguaggio familiare molto colorate entrano normalmente nel lessico nazionale familiare e vengono imposte da questo importante fenomeno di piginizzazione, che si conosce benissimo in linguistica ma che non è stato mai studiato nella realtà cinematografica). E poi, dagli anni ’60, una serie di fenomeni nuovi, dati dall’uscita del mito delle microrealtà romanesche che possono imporre i loro modelli a livello nazionale e dalla scoperta che esistono dei linguaggi dei media, che impongono i loro modelli, unificano, omogenizzano, ecc. Quel discorso che verso la metà degli anni ’60 Pasolini aveva fatto con un famoso saggio edito su Rinascita (Nuove questioni linguistiche) in cui esordiva dicendo: “Io affermo che è nato l’italiano nazionale”. L’italiano nazionale è quello che parla la televisione, e che ci impone, con l’iterazione e l’accumulazione ipertrofica.

Di questo italiano nazionale in questo film trovate poche tracce. Trovate quelle tracce di discorsi fatici, di discorsi che non dicono niente, che non comunicano niente, che sono il vuoto della comunicazione, ma che sono passati attraverso una lunga gestazione nella cultura dei registi italiani, che si trovano di fronte a un impero dei mezzi di comunicazione di massa e sentono con terrore questo fatto, lo rifiutano, hanno col fenomeno una sorte di rapporto fobico insomma. Invece di cavalcare subito questo mondo e queste nuove tecnologie costruiscono un discorso di tipo umanistico appunto, di rifiuto di questi mostri della comunicazione.
E, a partire dalla prima metà degli anni ’60, proprio quando l’Italia muta il suo aspetto socio-economico, si abbandona il chiuso del borgo, si abbandona e si entra nella civiltà dei consumi, si verifica questa grossa trasformazione linguistica sulla quale il cinema medita, porta dei contributi tutt’altro che banali e tutt’altro che a livelli solo alti. La si riscopre nei film più diversi, dalla commedia all’italiana, che è un vero patrimonio, ma anche nei film con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Vengono contaminati un po’ tutti i livelli.
Con Dillinger siamo alla fine degli anni ’60, quando questo tipo di meditazione è giunta quasi a un livello di consumo estremo, e Ferreri, che ha questa caratteristica di immettere i suoi personaggi in una sorta di situazione di “fantascienza quotidiana” ha questo vantaggio, e anche forse questo limite, che è il limite della mentalità umanistica dei registi italiani di raccogliere questi fatti che vengono prima, di filtrarli, esasperarli, di portarli in una situazione catastrofica. Catastrofica nel senso proprio, sia nel senso di mutamento di modelli secondo le teorie di René Thom in una fase in cui mutano le strutture apparenti e non le strutture profonde e viceversa… Ferreri praticamente li porta al limite della catastrofe e dell’apocalisse e però questo film curiosamente alla fine dà anche una prospettiva positiva, a suo modo: è il frutto della vicinanza del ’68, è un momento di svolta? Questo fatto è anche curioso, perché l’epilogo di questo film, rispetto a quello che aveva fatto fino ad allora è abbastanza imprevedibile. Certo Dillinger apre un momento nuovo nella sua carriera, comunque un momento di svolta, un momento innovativo, ma a me pare che chiuda una fase di riflessione sui media, secondo, diciamo, un’idea di ciclo lungo, di mentalità stagnante dell’intellettuale cinematografico italiano sulla presenza di questi media nella società italiana, la porta al suo momento forse più drammatico e più rappresentativo, ma forse meno interessante per quello che potrebbe essere un discorso attuale, un uso attuale. Quindi è un film che ci permette di fare bilanci guardandoci alle spalle, ma anche spingendo lo sguardo in avanti verso mondi possibili.
Riprendiamo adesso il discorso sulle misure di scala, un elemento che a me pare molto interessante per addentrarci nell’insieme della storia del cinema italiano del dopoguerra. In Dillinger aquesto proposito troviamo un oggetto di esaltante evidenza. Proprio dalle primissime immagini e per tutto il film non c’è forse mai, per il protagonista, un rapporto normalizzato con le cose che gli stanno attorno, eppure in lui c’è uno sforzo suo costante di dare ordine, di dare una razionalità diversa da quella che gli è imposta dal suo lavoro, estremamente razionale, geometrico. Michel Piccoli nel film è un disegnatore, e la macchina da presa ha questo rapporto altrettanto sconvolto, altrettanto imprevedibile del rapporto del personaggio con la realtà. Ci sono pochissimi momenti in tutto il film, in cui la macchina da presa assume il punto di vista del personaggio.
Il film, praticamente, è tutto in terza persona: si segue il personaggio, i suoi gesti, i suoi comportamenti senza mai assumerne il punto di vista. Però ci sono due momenti in apparenza senza significato, in cui lui cerca delle cose: uno quando entra in camera della ragazza e l’altro quando cerca nella credenza della cucina. C’è anzitutto il suo muoversi confuso: lui non sa cosa deve fare in questo ambiente così pieno di oggetti in cui non trova niente, in cui ogni azione che compie è, in qualche modo, un’avventura nel cercare. La sua casa gli è tutta sconosciuta. Questo fatto è abbastanza sottolineato dai pochi discorsi nel film, in cui il protagonista chiede dov’è questo, dov’è quello, e ogni volta che apre un armadio, ogni volta che cerca una cosa, quella cosa non è proprio lì dove lui la vorrebbe.

Il disordine massimo probabilmente è in quel cassetto della moglie, che ci viene mostrato all’inizio, dove si trovano le pillole di sonnifero, la limetta da unghie, ma anche un serpentello tra una miriade di altri oggetti sparsi. E questo caos così esistenziale, d’ambiente, è in fondo l’unica cosa salutare che gli permette di ripartire quasi daccapo. Nel momento in cui lui stacca dal suo lavoro, entra a sua volta in una specie di camera di decompressione, quasi la continuazione di quel personaggio che vediamo all’inizio dentro alla camera con la maschera; solo che lui non ha la maschera, ma vive quasi senza fiato, in apnea costante. È molto significativo, che in una delle dieci battute del film, quando sale sulla nave, dica: “Che aria che si respira!”. C’è proprio questo bisogno di respirare, di ritrovare una condizione biologica tutta diversa, che è quasi soffocata, quasi sottratta dalle cose che gli stanno intorno, che incombono e gli rendono ancora più limitato, più oppressivo questo spazio. Però tutto il film segue il suo sforzo lucido e programmato, anche se sembra che si proceda verso il caos, per ripartire da zero, rifiutare programmaticamente tutto l’ordine che gli sta intorno (da quello del suo lavoro, all’ordine che gli è stato dato dalla moglie che gli mette una cena sui generis in tavola), riscoprire le regole di quello che si fa. Allora scende in cucina, riosserva gli oggetti che sono intorno, scopre la bottiglia con l’estragono dentro, guarda il libro di cucina (Il cucchiaio d’argento), ne vede le regole gastronomiche, e ritenta di costruirsi appunto da sé le azioni comuni, proprio il bisogno di ristabilire con la propria esistenza biologica, nel senso più modesto, un programma di limitatissimo orizzonte, un contatto materiale con le cose, di capirne le regole. È molto importante il suo osservare e riosservare tutto quanto gli viene in mano. E il suo film, da questo punto di vista, in questo senso delle misure di scala mi sembra assai utile in quanto ti dà una continua diversa misura di scala delle cose, le porta in primo piano, le fa vedere con evidenza inquietante. È una misura di scala (e anche questa è una scelta che arriva subito evidente nel momento in cui poi sono organizzati attorno tutti questi materiali dei mezzi di comunicazione di massa) che in uno spazio molto ristretto e in questa costante fluttuazione dei messaggi esterni che interferiscono nella sua esistenza elimina anche la nozione del tempo. Questo è un altro elemento che mi sembra abbastanza importante. A un certo momento c’è la scoperta del giornale di Chicago in casa, assolutamente gratuita, assolutamente futurista, assolutamente immotivata (uno che ha in casa un numero del “Chicago Tribune”…) che però è data anche come probabile, perché si è visto, in questo caos di giornali che si stendono al suolo, un gruppo di giornali americani, c ‘è “Time”, ecc.
 Questo è uno dei pochi ancoraggi temporali del film: una data del passato — il 1934 — ci viene data come un’informazione minima, mentre tutto il resto, tutti i dati ulteriori sono come ordinati in forma di paratassi. Non è che noi siamo in grado di identificarne la temporalità (Coppi riusciamo a collocarlo nel tempo, perché ci viene detto che è il ’50, ma le altre immagini, di guerra, di navi, non ancorano la nostra informazione al tempo). È come se in questo spazio il tempo lentamente si disfacesse nelle mani del protagonista, proprio perché si riparte da gesti comuni, elementari in cui il tempo si dilata, riacquista proprie leggi: per cui il film ha una durata quasi di tempo reale, però racconta tantissime storie, tantissimi fatti minimi che vengono accumulati, e si potrebbe anche dire che in fondo è un film d’azione, volendo usare un paradosso, è costituito da una serie enorme di azioni, evidentemente non drammatiche, ma assolutamente banali, che ti squilibrano la nozione di tempo.
Questo è uno dei pochi ancoraggi temporali del film: una data del passato — il 1934 — ci viene data come un’informazione minima, mentre tutto il resto, tutti i dati ulteriori sono come ordinati in forma di paratassi. Non è che noi siamo in grado di identificarne la temporalità (Coppi riusciamo a collocarlo nel tempo, perché ci viene detto che è il ’50, ma le altre immagini, di guerra, di navi, non ancorano la nostra informazione al tempo). È come se in questo spazio il tempo lentamente si disfacesse nelle mani del protagonista, proprio perché si riparte da gesti comuni, elementari in cui il tempo si dilata, riacquista proprie leggi: per cui il film ha una durata quasi di tempo reale, però racconta tantissime storie, tantissimi fatti minimi che vengono accumulati, e si potrebbe anche dire che in fondo è un film d’azione, volendo usare un paradosso, è costituito da una serie enorme di azioni, evidentemente non drammatiche, ma assolutamente banali, che ti squilibrano la nozione di tempo.
Se ci interrogassimo su quanto dura la cottura del brasato, e quanto dura l’amore che lui fa con la ragazza giocando col miele, o l’asciugatura della pistola, sono dei tempi nei cui confronti non ci vengono dati momenti di riferimento reali. È qualcosa di fluttuante, proprio perché all’inizio c’è stato questo gesto significativo di quest’uomo (per cui tutto è regolato da tempi): quando il collega di lavoro gli parla dell’alienazione, comincia un saggio sull’alienazione, lui tira fuori l’orologio e senza parlare gli dice che è finito il tempo del lavoro. I personaggi sono regolati quasi come automi in una esistenza tutta guidata dal di fuori. Questo tempo che lui riscopre nella sua casa appunto è il senso della distruzione di un tempo eterodiretto, potremmo dire con un termine caro ai sociologi degli anni ’50, e invece c’è in lui il bisogno di un tempo che sia riacquistato materialmente, scandito dal tempo dell’uomo che riacquista le misure del tempo e dello spazio attraverso le proprie azioni.
È questo un elemento che mi sembra interessante, al di là di una lettura di tipo contenutistico del film che forse è più banale e più ovvia: credo che tutti abbiate capito all’inizio questo riferimento (siamo nel ’69 insomma) esplicito, dato come citazione del libro “L’uomo ad una dimensione” di Marcuse, e il senso del distacco netto e programmatico nei confronti dell’alienazione. Viene ribadito tutto questo nella passeggiata lungo i corridoi, e la citazione non è di tipo verbale, ma di tipo figurativo, le immagini riprendono: temi dell’alienazione che i film di Antonioni, in particolare Deserto rosso, ci hanno raccontato attraverso determinate sequenze: lunghi corridoi con tante porte non comunicanti, e dei personaggi in fondo che a loro volta non comunicano. Questo potrebbe essere un film post-alienazione, postalienato praticamente, ma certo non della civiltà tecnologica. Quello che è successo nei tredici o quattordici anni che ci separano dal film, e quello alle cui soglie siamo, rende questa meditazione sui media per lo meno di tipo primitivo, molto elementare. C’è però questa sorta di sintesi di un processo che ha accompagnato il cinema italiano dagli anni ’60 per una decina d’anni, e che, al tempo stesso, ha ruotato nella cinematografia internazionale.
Dillinger è morto non si spiegherebbe senza gli antecedenti del cinema di Godard, senza gli antecedenti del cinema di Truffaut. Questo film respira, oltreché un clima culturale italiano di una ricerca su una determinata condizione dell’uomo, che ha determinati ancoraggi filosofici, anche un’idea di cinema di tipo internazionale. C’è anche un salto stilistico nello stile di Ferreri, che forse qui non c’interessa.
Questo quindi mi sembra un primo punto di discussione, un possibile piano d’interpretazione. In nessun momento del film, in nessun rapporto interpersonale si ha l’impressione che avvenga qualcosa che fa scattare una misura di scala paritetica tra i personaggi o tra i personaggi e l’ambiente. Lui guarda, apre la televisione ma non la segue. Le uniche cose che lo interessano molto, e fanno scattare in lui questa differenza dello sguardo tra una necessità di applicarsi ad un lavoro di cui riscopre la manualità e il gesto contro la civiltà tecnologica, sono i gusti, il tatto, i gusti delle necessità fisiologiche che, nel corso del film, soddisfa praticamente quasi tutte (e altre ci vengono prospettate), e questo interesse, questo senso delle scelte che i suoi sguardi ci comunicano, di volta in volta, tra uno sguardo incerto così e la decisione che lui sta varando un programma. Per tutti lo sguardo di lui che decide di uccidere la moglie: è proprio un momento anche di alta recitazione, è solo una minima variazione d’occhi, ma con questo senso della scelta.

Questo appunto un film neorealista non lo faceva, perché avrebbe fatto capire che anche tutto l’ambiente intorno sentiva questo dramma, non era una scelta solo tutta interna, con una carica di tensione interna, di cui in fondo possiamo anche non esserci accorti bene. Questo film poteva finire con una scena in cui andava a letto, ma a ben guardare in tutte le scene c’è un margine di imprevedibilità, di decisione che lui si riserva proprio per sottrarsi, per decidere di sottrarsi fino a che può alle regole che gli verrebbero imposte e che gli sono state evidentemente imposte fino a quel momento: un rapporto familiare assolutamente inesistente, una sessualità così insoddisfatta e però fisicamente molto presente, come ci è fatto capire dal modo in cui mangia ecc., e un bisogno di fare altro. Lui si chiude in casa e subito vediamo che professionalmente veste i panni del cuoco e lo fa con estrema professionalità, e quindi dà l’impressione di voler ripartire, di voler ristabilire lui delle regole del gioco che evidentemente sono affidate ad altri.

Quindi per quello dicevo che il film è estremamente consequenziale, in fondo le possibilità sono due nel finale, però in realtà si tratta di una sola. Di fatto, anche se è costellato di fatti imprevedibili, di piccoli gesti surrealisti, o di piccoli eventi che sfuggono al personaggio, che evidentemente vuole il controllo dei suoi gesti, il controllo dei meccanismi, questi fatti sono pochi e quasi tutti poi, visto che lui si muove con questa determinazione, volgono a suo favore. C’è un unico segno, verso il finale, che lo mette un attimo in crisi perché assolutamente imprevedibile, sfugge ai suoi ordini, quello del pomodoro spiaccicato sulla sua macchina tutta così ben lustra (perché è un personaggio ordinatissimo, ha ucciso la moglie, ma poi chiude le luci, come si è visto e si porta via anche un determinato oggetto). Cioè questo reale in fondo gli offre veramente pochi margini di curiosità, di cose che lo stimolano, per cui decide di ripartire da zero.
(fine prima parte)
Il presente articolo è tratto da CIN&MASSMEDIA, Storia, linguaggio e relazioni tra mezzi di comunicazione contemporanei.
Corso di storia del cinema per insegnanti. Trieste 23 novembre 1981-31 maggio 1982. ![]() A cura di Annamaria Percavassi e Stella Rasman
A cura di Annamaria Percavassi e Stella Rasman ![]() Edito da La Cappella Underground con il contributo della Provincia di Trieste (marzo 1983)
Edito da La Cappella Underground con il contributo della Provincia di Trieste (marzo 1983)


















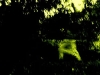



















Commenti
Non ci sono ancora commenti