Discorso d’apertura del Terzo “Festival Internazionale della Letteratura” di Berlino al “Berliner Ensemble”
Berlino, 10 settembre 2003
 Quando gli organizzatori del Festival internazionale della Letteratura mi chiesero di tenere questo discorso, mi proposero di parlare di qualcosa che potesse conciliare i miei due mondi: l’ONU e la letteratura. Mentre pensavo all’argomento da trattare, ho riflettuto sulle questioni che hanno caratterizzato maggiormente la mia vita all’ONU nell’ultimo periodo: le forze della globalizzazione, che stanno operando sul mondo una trasformazione inarrestabile; la natura dei mass media internazionali, che in qualità di funzionario ONU cerco di influenzare; e infine, i cambiamenti che l’era del terrorismo, o “9/11”, com’è chiamata in America, aveva prodotto in noi una volta che la sua ombra si era stagliata sulle menti impadronendosi della nostra immaginazione. La globalizzazione, i media, la nostra immaginazione… mi sono chiesto: nel mondo del dopo 11 settembre, esiste qualcosa che si possa definire immaginazione globale?
Quando gli organizzatori del Festival internazionale della Letteratura mi chiesero di tenere questo discorso, mi proposero di parlare di qualcosa che potesse conciliare i miei due mondi: l’ONU e la letteratura. Mentre pensavo all’argomento da trattare, ho riflettuto sulle questioni che hanno caratterizzato maggiormente la mia vita all’ONU nell’ultimo periodo: le forze della globalizzazione, che stanno operando sul mondo una trasformazione inarrestabile; la natura dei mass media internazionali, che in qualità di funzionario ONU cerco di influenzare; e infine, i cambiamenti che l’era del terrorismo, o “9/11”, com’è chiamata in America, aveva prodotto in noi una volta che la sua ombra si era stagliata sulle menti impadronendosi della nostra immaginazione. La globalizzazione, i media, la nostra immaginazione… mi sono chiesto: nel mondo del dopo 11 settembre, esiste qualcosa che si possa definire immaginazione globale?
In altre parole: la globalizzazione, che ha portato McDonald’s e Microsoft in ogni paese, è riuscita anche a raggiungere tutte le menti con Topolino e Nintendo, comprese quelle di Osama bin Laden e “Alì il chimico”?
Il quesito in realtà è più serio di quello che possa sembrare, soprattutto se si tiene conto della velocità della TV satellitare e via cavo. I media portano sulla tavola della nostra colazione e nei nostri salotti e sempre più spesso anche sui nostri computer e cellulari, stralci di eventi da ogni angolo del globo. Qualsiasi dubbio che mi fosse ancora rimasto riguardo alla portata e all’influenza delle comunicazioni di massa è stato spazzato via quando, trovandomi per caso a San Pietroburgo, in Russia, sono stato avvicinato da un monaco buddista tibetano che, indossando la sua tunica e cantando i suoi mantra al ritmo di un cembalo, ha cessato per un attimo il proprio canto per dire: “Ma io l’ho vista alla BBC!”. Le nuove tecnologie della comunicazione hanno fatto restringere il mondo, rendendolo effettivamente un’entità unica.
Ma dopo l’11 settembre 2001, la nozione di immaginazione globale si è caricata di una sfida diversa. Il 9/11, come ci hanno insegnato a chiamarlo gli americani, è nato il ventunesimo secolo. Se, come sosteneva lo storico Eric Hobsbawm, il ventesimo secolo cominciò in realtà con l’assassinio di Sarajevo che diede inizio alla Prima Guerra Mondiale, è giusto dire che, a giudicare dall’impatto che ha già avuto sulla configurazione della nostra epoca, il ventunesimo secolo è cominciato con il crollo del World Trade Centre, avvenuto due anni fa domani.
Cosa intendo dire con questo? La distruzione del World Trade Centre ha sferrato un colpo non solo alle istituzioni del capitalismo americano e mondiale, ma anche alle certezze che lo sostenevano; certezze di un sistema sociale e politico che, senza doverci pensare troppo, riteneva di aver trovato la risposta alle sfide della vita e di essere in grado di vincerle tutte. Naturalmente la ferita dell’11 settembre e la paura dell’antrace che è seguita hanno portato la desolante consapevolezza della vulnerabilità fisica in un paese che, pur avendo combattuto nel corso della sua storia una dozzina di guerre importanti, a memoria d’uomo non aveva mai subito un attacco diretto. Era il paese in cui uno studioso come Mark Twain aveva potuto asserire con grande compiacimento “la fine della storia”; adesso invece la storia ha proclamato che la notizia del suo decesso era azzardata. Nel mondo di oggi sempre più piccolo nemmeno la geografia ha saputo garantire protezione. Anche solo per aver sancito la fine dell’isolamento degli americani rispetto alle sofferenze che affliggono il resto del globo, l’11 settembre ha cambiato il mondo per sempre.
Ma i tragici eventi di quell’unica giornata sono emblematici del nostro nuovo secolo anche sotto un altro aspetto cruciale. I tratti distintivi del mondo di oggi sono le inesorabili forze della globalizzazione, la facilità di comunicazione e di spostamento, la riduzione dei confini, l’attraversamento del mondo di flussi di persone di tutte le nazionalità e colori, la rapidità delle transazioni finanziarie per mezzo di un tasto. L’aeroplano, il cellulare e il computer sono gli strumenti della nostra epoca. Queste stesse forze, che in una fase più benigna avrebbero potuto indirizzare il mondo verso il progresso e la prosperità, sono state usate invece dai terroristi come forze per la loro macabra danza di morte e distruzione. Hanno attraversato agevolmente le frontiere, coordinato i propri sforzi con precisione tecnologica, dirottato dei jet per farli abbattere contro gli obiettivi stabiliti (mentre le loro vittime designate telefonavano con il cellulare ai loro cari per un ultimo addio). Si è trattato di un reato da ventunesimo secolo e ha definito come nessun altra cosa i pericoli e il potenzialedella nostra epoca.
Ha anche provocato negli Stati Uniti una reazione che, a sua volta, lascerà un segno indelebile nel nuovo secolo. Il ventesimo secolo, com’è noto, è stato battezzato da Henry Luce del Time Magazine “il secolo americano”, ma gli albori del ventunesimo secolo vedono gli Stati Uniti in una condizione di predominio economico, politico, culturale e militare molto più forte di quella mai avuta da una potenza mondiale. Gli Stati Uniti godono di una supremazia militare relativa che non ha precedenti nella storia umana; neppure l’Impero Romano al suo apice si staccava dalla capacità militare del resto del mondo con la stessa nettezza degli Stati Uniti di oggi. Ma non è tutto. Quando l’ex Ministro degli Esteri francese, Hubert Vedrine, ha definito gli Stati Uniti una ”superpotenza” (“hyperpuissance”), non si riferiva solo alla supremazia militare americana, ma anche agli USA in quanto patria di Boeing e Intel, di Microsoft e MTV, di Hollywood e Disneyland, di McDonald’s e Kodak: in breve, della maggior parte dei prodotti che dominano la vita quotidiana in tutto il mondo.
E tuttavia, prima del 9/11, Washington era stata curiosamente ambigua nell’esercizio di tale supremazia, con diverse figure di spicco che parlavano e si comportavano come se il resto del pianeta fosse irrilevante per l’esistenza dell’America o per la sua favoleggiata ricerca della felicità. Dopo l’11 settembre non esiste più la possibilità di un facile rifugio nell’isolazionismo, né si può trovare conforto nell’illusione che i problemi del resto del mondo non devono necessariamente toccare gli Stati Uniti. Gli americani ora hanno capito visceralmente il vecchio cliché del villaggio globale, perché il 9/11 ha dimostrato che un incendio che si scatena in una remota capanna di paglia o in una tenda polverosa in un angolo di un villaggio può fondere le travi d’acciaio dei più alti grattacieli all’estremità opposta del villaggio globale.
Le sfide globali richiedono soluzioni globali, e sono davvero poche le situazioni in cui persino una superpotenza può agire completamente da sola. Questo truismo è stato nuovamente riconfermato in Iraq, dove gli Stati Uniti stanno scoprendo che da soli sono più bravi a vincere le guerre che a costruire la pace. I limiti della forza militare nella costituzione di una nazione sono più che evidenti; come affermò Talleyrand, l’unica cosa che non si può fare con una baionetta è sedercisi sopra. Ugualmente importante, tuttavia, è la necessità di legittimazione. Agire in nome del diritto internazionale, specialmente passando per le Nazioni Unite, è sempre preferibile che agire in nome della sicurezza nazionale, dato che, nel primo caso, tutti hanno un interesse. Dunque la multilateralità ha ancora un futuro a Washington.
Ciò è tanto più vero in quanto l’era del terrorismo costituisce una minaccia multilaterale. L’attacco terrorista del 9/11 è stato un assalto non solo a un paese ma, nella sua atroce indifferenza nei confronti della vita di innocenti di ottanta paesi di tutto il mondo, è stato anche un assalto agli stessi legami di umanità che uniscono tutti noi. Per rispondere efficacemente dobbiamo essere uniti. Il terrorismo non ha origine in un solo paese, chi lo esercita non ha la propria base in un solo paese, le sue vittime non si trovano in un solo paese, e dunque anche la risposta deve coinvolgere tutti i paesi.
Il terrorismo scaturisce dall’odio cieco per un Altro, che è a sua volta il prodotto di tre fattori: paura, rabbia e incomprensione. Paura di ciò che l’Altro può farti, rabbia per ciò che secondo te l’Altro ti ha fatto, e incomprensione riguardo a chi o cosa l’altro è realmente. Questi tre elementi si fondono innescando quella combustione letale che uccide e distrugge delle persone il cui unico peccato consiste nel non provare nessuno di questi sentimenti. Se vogliamo affrontare il terrorismo e porvi fine, dovremo occuparci di tutti e tre questi fattori attaccando l’ignoranza che li sottende. Dovremo conoscerci meglio a vicenda, imparare a vederci come ci vedono gli altri, imparare a riconoscere l’odio e a farci carico delle sue cause, imparare a dissipare la paura e soprattutto imparare gli uni dagli altri.
In un certo senso, i terroristi del 9/11 stavano attaccando la globalizzazione dell’immaginazione umana, la cultura empia, materialistica e promiscua dell’Occidente dominante, incarnata in una globalizzazione da cui le persone come loro si sentivano escluse. Di certo coloro che hanno acclamato la loro azione l’hanno fatto a causa del sentimento di esclusione. Se parliamo dell’immaginazione umana oggi, dobbiamo chiederci cosa porti un numero sorprendentemente alto di giovani a seguire la rotta disperata tracciata per loro dai fanatici e dagli ideologi. Un senso di oppressione, di esclusione, di emarginazione può dare origine all’estremismo. Quarant’anni fa, nel 1962, il mai dimenticato Segretario Generale delle Nazioni Unite U Thant avvertì che avrebbe potuto scatenarsi un’esplosione di violenza in seguito al senso d’ingiustizia provato da coloro che vivevano nella miseria e nella disperazione in un mondo di abbondanza. L’11 settembre sono morte circa 2.600 persone al World Trade Centre. Ma l’11 settembre sono morte anche circa 26.000 persone in tutto il mondo a causa della fame, dell’acqua inquinata e di malattie che possono essere prevenute. Non possiamo permetterci di escluderle dalla nostra immaginazione globale.
Ma naturalmente, non è tutto. Se uno Stato non è nemmeno in grado di offrire al suo popolo la speranza di una vita migliore per i suoi figli garantendo l’accesso all’istruzione di base, come possiamo aspettarci che quel popolo o quei figli resistano alle lusinghe del terrore? Non dovrebbe essere una sorpresa scoprire che i Talebani hanno reclutato la loro fanteria nelle scuole religiose o nelle madrase che costituivano l’unica fonte di formazione e “istruzione” per i tanti bambini che non avevano a disposizione altra fonte di conoscenza, che non imparavano in queste scuole scienze, matematica o informatica, bensì il credo del Corano e del Kalashnikov: il Corano interpretato grossolanamente, il Kalashnikov costruito grossolanamente. E la loro immaginazione era, di conseguenza, tutt’altro che globale.
Questo mi riporta alla domanda che ho sollevato all’inizio: siamo caduti nella pericolosa illusione che l’immaginazione umana possa essere globalizzata? Per elaborare una risposta dobbiamo guardare ai mass media globali. I mass media riflettono principalmente gli interessi dei loro produttori. Ciò che passa per cultura internazionale è solitamente la cultura del mondo economicamente sviluppato. È la nostra immaginazione a essere globalizzata. I film e i programmi televisivi americani, in particolare, si ritrovano sugli schermi della maggior parte dei paesi.
Chi altro riesce a penetrare nell’immaginazione globale nel nostro splendido nuovo mondo? Sì, occasionalmente si sente la voce del terzo mondo, ma parla la lingua del primo mondo. Durante la lontana prima guerra civile del Congo del 1962, il giornalista Edward Be’r vide in un campo di suore belghe violentate un anchorman televisivo che gridava: “C’è qualcuna qui che è stata stuprata e parla inglese?” In altre parole, non bastava aver sofferto: bisognava aver sofferto ed essere in grado di esprimere la propria sofferenza nella lingua del giornalista. Il che ci porta alla logica domanda successiva: coloro che nei media globalizzati parlano in nome delle proprie culture sono i loro rappresentanti più autentici?
Internet potrà compensare? È uno strumento democratizzante? In Occidente, forse lo è diventato, ora che le informazioni sono molto più accessibili a chiunque e dovunque. Ma questo non succede nel mondo in via di sviluppo. La cruda realtà di internet oggi è la distribuzione digitale: si possono distinguere i ricchi dai poveri dai loro collegamenti a internet. Il divario tra chi ha e chi non ha a livello tecnologico si sta allargando, sia all’interno dei paesi che tra i paesi. La rivoluzione informatica, a differenza di quella francese, è una rivoluzione con molta liberté, poca fraternité e nessuna egalité. Dunque la linea della povertà non è l’unica su cui riflettere; c’è anche una linea digitale ad alta velocità, la linea a fibre ottiche, tutte le linee che escludono coloro che, letteralmente, restano tagliati fuori dalle possibilità del nostro splendido nuovo mondo. La chiave del divario internet è la tastiera del computer. Quelli che non ne hanno una rischiano l’emarginazione e la loro immaginazione non travalica i confini.
Queste preoccupazioni sono reali. Se vengono affrontate, se la volontà di superarle è assodata e applicata, il ventunesimo secolo potrebbe ancora diventare un’epoca di comprensione reciproca come non si è mai vista prima. Un mondo in cui conoscere degli estranei è più facile di quanto non lo sia stato in passato, deve diventare un mondo in cui sia anche più facile vedere gli estranei come persone non diverse da noi.
L’ignoranza e il pregiudizio sono le ancelle della propaganda, e nella maggior parte dei conflitti moderni, gli uomini di guerra approfittano dell’ignoranza della gente comune per diffondere timori e scatenare odi. È quanto è successo in Bosnia e in Ruanda, dove ideologie basate su assassinio e genocidio hanno messo radici in assenza di informazioni veritiere e di istruzione onesta. Se solo la metà degli sforzi fossero andati nella direzione di insegnare a quei popoli ciò che li unisce e non ciò che li divide, dei crimini innominabili sarebbero potuti essere evitati.
Anche la libertà di parola garantisce la diversità. In quanto scrittore indiano, ho sostenuto che la recente esperienza del mio paese con la penetrazione globale dei prodotti di consumo occidentali dimostra che possiamo bere la Coca Cola senza venirne colonizzati. La cultura popolare propria dell’India fa anch’essa parte della globalizzazione: i prodotti di “Bollywood” sono esportati nelle comunità degli indiani espatriati all’estero. Il successo del cinema e della musica indiani in Inghilterra e negli Stati Uniti dimostra che l’Impero può restituire il colpo.
E non si tratta solo dell’India. Un recente studio ha reso noto che la programmazione televisiva locale ha cominciato a sopravanzare le trasmissioni made-in-America in un numero sempre maggiore di paesi. E mentre il mondo globalizzato cambia, non lo fa solo in una direzione. In Inghilterra oggi, le “curry houses” indiane danno lavoro a più persone dell’industria metallurgica, del carbone e di quella cantieristica insieme.
Nel mio primo romanzo, The Great Indian Novel, ho reinventato un poema epico antico di duemila anni, il Mahabharata, sotto forma di racconto satirico della storia dell’India del ventesimo secolo, dai giorni dell’erabritannica ad oggi. La mia scelta era consapevole. La maggior parte dei paesi in via di sviluppo sono anche ex colonie, e una caratteristica del colonialismo era appropriarsi della definizione culturale dei popoli assoggettati. Scrivendo dell’India in inglese, non posso non pensare a coloro che hanno fatto la stessa cosa prima di me, alcuni con maggiore competenza linguistica, ma con minore conoscenza del paese. Ancora oggi pensando all’India nel mondo anglofono, si pensa per immagini condizionate da Rudyard Kipling e E.M.Forster, dai lancieri del Bengala e dai “Gioielli della Corona”. Ma le loro storie non sono le mie, i loro eroi non sono i miei; la mia narrativa cerca di riscattare il retaggio del mio paese, di raccontare, con una voce indiana, una storia dell’India. E sottolineo “una” storia dell’India, perché ci sono sempre altre storie e altri indiani a raccontarle. Ma che importanza ha un’asserzione letteraria di questo tipo di fronte alle sfide gigantesche davanti alle quali si trova un paese come l’India? La letteratura può avere un qualche significato in un paese di povertà, sofferenza e sottosviluppo? Io credo di sì.
Il mio romanzo comincia con l’affermazione che l’India non sia, come continua a dire la gente, un paese sottosviluppato, ma piuttosto, nel contesto della sua storia e del suo retaggio culturale, un paese altamente sviluppato in una condizione di decadenza. Tali sentimenti sono il privilegio dell’autore satirico; ma come romanziere sono convinto, con Molière, che per edificare bisogna divertire. Ma edificare a che scopo? Qual è la responsabilità dell’artista creativo, dello scrittore, in un paese in via di sviluppo nel nostro mondo in via di globalizzazione? Nei miei scritti ho indicato una responsabilità: dare un contributo, aiutare ad articolare e a dare espressione all’identità culturale (mutevole, variegata e molteplice, nel caso indiano) della società postcoloniale alle prese con i dolori della globalizzazione. La stragrande maggioranza dei paesi in via di sviluppo è uscita solo di recente dall’incubo del colonialismo; sia il colonialismo che la globalizzazione hanno alterato e distorto la percezione culturale che essi hanno di sé. Lo sviluppo non potrà realizzarsi senza una riaffermazione dell’identità: che questo è ciò che siamo, che è ciò di cui andiamo fieri, che è quanto vogliamo diventare. In tale processo, cultura e sviluppo sono fondamentalmente collegati e interdipendenti. Il compito dello scrittore è trovare nuovi modi per esprimere la sua cultura e far rivivere quelli antichi, nel momento stesso in cui la sua società tenta, nel bel mezzo della globalizzazione, di trovare nuovi modi di essere e di divenire.
In quanto scrittore votato al pluralismo indiano, vedo la riaffermazione culturale come una parte essenziale delle sfide alle quali un paese come l’India si trova di fronte, essenziale tanto quanto lo sviluppo economico. Tutti noi conosciamo il proverbio secondo cui “non si vive di solo pane”. In India, secondo me, la musica, la danza, l’arte e il raccontare storie sono indispensabili per la nostra capacità di affrontare quella costruzione essenziale che chiamiamo la condizione umana. Dopotutto, perché l’uomo ha bisogno del pane? Per sopravvivere. Ma perché sopravvivere, se è solo per mangiare altro pane? Vivere è qualcosa di più che sopportare solamente la vita: è arricchire la vita e farsi arricchire dalla vita. I più poveri tra gli uomini e le donne del mondo in via di sviluppo sentono pulsare dentro di sé l’immaginazione, perché raccontano ai loro figli delle storie sotto i cieli stellati — storie del loro paese e dei suoi eroi, storie della terra e dei suoi misteri, storie che hanno fatto di loro ciò che sono. E (dato che il mio secondo romanzo parlava di Bollywood) vedono e sentono anch’essi delle storie, alle luci tremule dei migliaia di cinema sparsi per il nostro paese, dove s’intrecciano il mito e la fantasia escapista, e la rettitudine morale quasi invariabilmente trionfa con i titoli di coda.
La globalizzazione, dicono i suoi avvocati difensori, riguarda la crescita e lo sviluppo. Ma non può ridursi a un elenco di cifre sulle tabelle dei PIL, a materia di studio per economisti e uomini d’affari, invece che per la gente. E se la gente deve svilupparsi, è impensabile che si sviluppi senza la letteratura, senza il canto, la danza, la musica, il mito, senza storie sulla sua vita, e senza esprimere la propria visione del proprio destino attuale e delle proprie speranze per il futuro. Lo sviluppo presuppone il dinamismo; il dinamismo richiede la libertà, la libertà di creare; la creatività esige, semplicemente, immaginazione.
Ma parlando della riaffermazione culturale dell’immaginazione, non voglio difendere una costruzione chiusa. Sono convinto che noi indiani non saremo meno indiani se, ricorrendo alla metafora del Mahatma Gandhi, apriremo le porte e le finestre del nostro paese e lasceremo che dei venti stranieri spazzino la nostra casa. Per me i venti della globalizzazione devono soffiare in entrambe le direzioni. La Carta dell’UNESCO ci ricorda che “poiché la guerra nasce nella mente degli uomini, è nella mente degli uomini che bisogna costruire le fondamenta della pace”. Ciò vale non solo per la guerra e per la pace, ma per l’intero tessuto della vita umana e della società che deve essere costruito nella nostra mente. Come ci hanno insegnato gli accoliti di Osama bin Laden o i giovani soldati dei Talebani, il mondo avrà sempre più di una mente. Ed ecco perché la diversità culturale è così essenziale nel nostro mondo sempre più piccolo. Perché senza la molteplicità di culture, non siamo in grado di capire come le persone di razze, religioni o lingue diverse possano condividere gli stessi sogni e le stesse speranze. Senza un’immaginazione umana eterogenea non possiamo capire la miriade di manifestazioni della condizione umana, né apprezzare l’universalità degli scopi e delle aspirazioni umane. Ecco perché, come scrittore, sostengo che la specificità della letteratura costituisce il miglior antidoto alla globalizzazione dell’immaginazione.
Ad ogni modo, il conflitto fondamentale dei nostri tempi non è lo scontro tra civiltà, ma tra dottrine diverse: fondamentalismo religioso ed etnico da una parte, capitalismo laico e consumistico dall’altra. Grazie alla globalizzazione, il mondo si sta concentrando in un unico mercato internazionale e contemporaneamente è straziato dalla guerra civile e dallo smembramento delle nazioni. L’autore Benjamin Barber ha scritto della doppia prospettiva che l’umanità si trova ad affrontare definendola “Jihad contro McWorld”: “Jihad nel nome di cento fedi dalla visione ristretta contro ogni tipo di interdipendenza… contro la tecnologia, contro la cultura popolare, contro i mercati integrati, contro la modernità in sé e per sé”, in contrasto con un “McWorld” della globalizzazione sfrenata, un mondo di “musica veloce, computer veloci e cibo veloce, con le MTV, i Macintosh e i McDonald’s che accorpano le nazioni in un unico parco divertimenti commercialmente omogeneo.” Sia la Jihad che il McWorld, naturalmente, finiscono per annullare il nostro bene più prezioso: la nostra identità.
Ciascuno di noi ha molte identità. A volte la religione ci obbliga a negare la verità riguardo alla nostra complessità annullando la molteplicità insita nella nostra identità. Il fondamentalismo islamico, in particolare, ha questo effetto in quanto incarna la passione della pura appartenenza, una smania intensificata dalla marea minacciosa della globalizzazione oltre che dalla natura della politica per il Medio Oriente. Naturalmente c’è qualcosa di prezioso e pregevole in una fede che permette a un essere umano di sentirsi tutt’uno con altri che, in tutto il mondo, tendono le loro mani verso Dio. Ma possiamo separare la religione dall’identità? Possiamo sognare un mondo in cui la religione ha un posto onorevole ma in cui il bisogno di spiritualità non sia più associato al bisogno di appartenenza? Se l’identità potrà essere principalmente in relazione alla cittadinanza piuttosto che alla fede, a un paese piuttosto che a una dottrina, e se questa identità è tale da poter vivere in armonia con altre identità, allora potremmo resistere sia alla Jihad che al McWorld.
Per ottenere questo dobbiamo promuovere il pluralismo. Io sono cresciuto in un’India laica. Essere laici, in India, non significava essere irreligiosi, cosa che persino i partiti apertamente atei come i comunisti o il partito DMK del sud trovavano impopolare tra i loro elettori; in realtà, nel Durga Puja, annuale di Calcutta, i partiti comunisti gareggiano nell’esporre i “pandal” (padiglioni decorativi, NdT) più sontuosi. Piuttosto, nella tradizione indiana laicità significava una moltitudine di religioni, nessuna delle quali era privilegiata dallo stato. Ricordo che nel quartiere di Calcutta in cui ho vissuto gli anni delle scuole superiori, il verso del muezzin che chiamava alla preghiera i fedeli islamici si fondeva con il canto dei mantra al tempio indù dedicato a Shiva e con il suono crepitante degli altoparlanti fuori dal gurudwara dei sikh che recitavano i versi del Granth Sahib. E a soli due minuti di distanza, lungo la mia via, c’era la cattedrale di San Paolo. Gli studenti, gli impiegati, i funzionari governativi, erano tutti liberi di indossare turbanti, veli, cappelli, o qualsiasi altro indumento fosse prescritto dalla loro religione. Questa è la laicità indiana: accettare tutti, senza privilegiare nessuno; niente costituisce l’eccezione, nessuno viene umiliato. Questa laicità è minacciata da alcuni oggi in India, ma rimane un retaggio prezioso per tutti gli indiani.
Il pluralismo può essere protetto soltanto sostenendo lo sviluppo della democrazia a livello locale, nazionale e internazionale per creare un contesto in cui il pluralismo culturale possa fiorire. Dobbiamo promuovere un’istruzione liberale e di libero pensiero che apra le menti ovunque piuttosto che chiuderle. Dobbiamo assumere una posizione di rispetto e umiltà nell’affrontare gli altri, adoperandoci per l’inclusione piuttosto che per l’emarginazione.
Quando i terroristi di oggi e domani saranno stati sconfitti, il nostro mondo dovrà ancora fronteggiare, per usare un’espressione del Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan, innumerevoli “problemi senza passaporto”, i problemi legati alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, del degrado del nostro ambiente comune, delle malattie contagiose e della fame cronica, dei diritti umani e dei torti umani, dell’analfabetismo di massa e dello sfollamento di massa. Esistono problemi che nessun paese per quanto potente, può risolvere da solo e che sono inevitabilmente una responsabilità comune del genere umano. Essi reclamano a voce spiegata delle soluzioni che, come i problemi stessi, travalichino le frontiere.
Oggi, che una persona venga da Tubinga o da Tallahassee, è semplicemente irrealistico ragionare solo in termini del proprio paese. Le forze globali premono da ogni possibile direzione; le persone, le merci e le idee travalicano i confini e coprono distanze enormi con frequenza, velocità e facilità sempre maggiori. Internet è emblematico di un’era in cui ciò che accade nel Sud-Est asiatico o nella parte meridionale dell’Africa — dal progresso democratico alla deforestazione, alla lotta contro l’AIDS — influenza la vita della Germania. Come è stato detto in relazione all’inquinamento dell’acqua, viviamo tutti a valle.
In gran parte del mondo esistono delle società in cui la ricchezza ha sede nell’anima e non nel suolo, il cui passato può offrire più abbondanza del presente, e la cui immaginazione è più preziosa della tecnologia. Riconoscere che potrebbe essere così e affermare che l’immaginazione è basilare per la consapevolezza dell’umanità della propria dignità tanto quanto la capacità di mangiare, bere e dormire sotto un tetto, fa parte della sfida a cui il mondo si trova oggi di fronte. L’unico modo per assicurarci che questa sfida verrà raccolta è preservare la libertà culturale e immaginativa in tutte le società, garantire che le voci individuali trovino espressione, che tutte le idee e le forme di arte vengano messe in condizione di prosperare e di contendersi il loro posto al sole. In passato abbiamo sentito dire che il mondo dev’essere assicurato alla democrazia. Quest’obiettivo sta per essere raggiunto; è venuto ora il momento di darci da fare per assicurare il mondo alla diversità.
I terroristi non sono riusciti a vedere le loro vittime come esseri umani che avevano il diritto alla propria immaginazione. Hanno visto solo degli oggetti, pegno superfluo della loro ricerca di distruzione. La nostra unica risposta efficace dev’essere l’orgogliosa affermazione della nostra umanità; dire che ciascuno di noi, chiunque e dovunque siamo, ha il diritto di vivere, amare, sperare, sognare e aspirare a un mondo in cui tutti hanno questo diritto. Un mondo in cui il flagello del terrorismo venga combattuto, ma in cui vengano combattuti anche i flagelli della povertà, della carestia, dell’analfabetismo, della malattia, dell’ingiustizia e dell’insicurezza umana. Un mondo, in altre parole, in cui il terrore non avrà modo di prosperare. Potrebbe essere il mondo del ventunesimo secolo appena nato, e potrebbe essere l’eredità più densa di speranza lasciata dall’atto atroce che l’ha generato.
Il presente articolo è un estratto del discorso di apertura della terza edizione del Festival internazionale della letteratura di Berlino (10-21 settembre 2003), tenuto il 10 settembre 2003 al teatro “Berliner Ensemble”.
I diritti del testo appartengono all’autore Sashi Tharoor, Sottosegretario Generale delle Nazioni Unite, e all’Internationales Literaturfestival Berlin.

















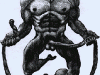



















Commenti
Non ci sono ancora commenti