 Se esiste un cineasta inquieto nel panorama cinematografico internazionale, questo è certamente Ken Loach. È curioso, invece, come i suoi film siano spesso accolti da una stima che nasconde l’apatia, da una ricezione favorevole che dissimula l’abitudine, da un atteggiamento di scarsa curiosità che proviene sovente proprio da coloro che maggiormente sembrano sentirsi compresi e rappresentati nelle opere del regista inglese. Il rischio di identificare Loach esclusivamente con le storie che racconta e con le posizioni politiche e sociali dei suoi film è un fatto naturale. È un rischio che corrono molti cineasti. Eppure, nessuno pensa a tutti i registi che — pur dedicando film alla povertà, all’emarginazione e ai temi più importanti della nostra società — si sono persi, sono stati via via ignorati, hanno abbandonato il campo o, più semplicemente, sono stati dimenticati. Perché questo non è accaduto a Ken Loach? In fondo, parliamo di una carriera lunga ormai 40 anni (Catherine è datato infatti 1964), e non si può certo dire che siano numerosi gli artisti che hanno saputo mantenere una tensione talmente forte sul proprio lavoro da attraversare un così lungo lasso di tempo (40 anni sono poco meno della metà dell’intersa storia del cinema, tanto per intenderci).
Se esiste un cineasta inquieto nel panorama cinematografico internazionale, questo è certamente Ken Loach. È curioso, invece, come i suoi film siano spesso accolti da una stima che nasconde l’apatia, da una ricezione favorevole che dissimula l’abitudine, da un atteggiamento di scarsa curiosità che proviene sovente proprio da coloro che maggiormente sembrano sentirsi compresi e rappresentati nelle opere del regista inglese. Il rischio di identificare Loach esclusivamente con le storie che racconta e con le posizioni politiche e sociali dei suoi film è un fatto naturale. È un rischio che corrono molti cineasti. Eppure, nessuno pensa a tutti i registi che — pur dedicando film alla povertà, all’emarginazione e ai temi più importanti della nostra società — si sono persi, sono stati via via ignorati, hanno abbandonato il campo o, più semplicemente, sono stati dimenticati. Perché questo non è accaduto a Ken Loach? In fondo, parliamo di una carriera lunga ormai 40 anni (Catherine è datato infatti 1964), e non si può certo dire che siano numerosi gli artisti che hanno saputo mantenere una tensione talmente forte sul proprio lavoro da attraversare un così lungo lasso di tempo (40 anni sono poco meno della metà dell’intersa storia del cinema, tanto per intenderci).
Tuttavia, va detto senza pudore, una parte della critica pensa: a) che Loach tutto sommato sia un cineasta di cui si conoscono idee e stile, per cui i suoi film — per quanto apprezzabili — non possono costituire sorpresa, e b) che Loach possieda grandi contenuti ma uno stile invisibile, medio e tutto al servizio del racconto. Nulla di più sbagliato. Se Loach ha saputo tenere alta la qualità del suo cinema è proprio in virtù di una spasmodica attenzione alla messa in scena, di un ragionamento inflessibile sui modi del racconto e dello stile, di una conoscenza puntuale della macchina-cinema e delle sue potenzialità. Non è vero che Loach sappia girare solo questo tipo di cinema. Anzi, i suoi film sono il frutto di una scelta estetica ponderata e riflessiva: è possibile affermare che ogni film di Loach è la negazione di tutte la altre possibilità con cui quella storia avrebbe potuto essere raccontata. E che ciascuna sua opera rappresenta al tempo stesso un partito preso del cinema che esclude tutti gli altri, secondo il celebre slogan di François Truffaut.
Inoltre, chi enfatizza la casualità e la ripetitività del metodo Loach non conosce a fondo la sua filmografia. Il regista britannico è a ben vedere uno sperimentatore. Nella sua carriera ha cambiato numerose volte modi narrativi, varianti stilistiche, contesti produttivi, mezzi tecnologici, formati, durate, persino “generi”, come più avanti cercheremo di dimostrare.
In pratica, voglio da subito impostare il saggio che segue come uno studio su Ken Loach in quanto cineasta “puro”, che individua nell’incontro problematico tra cinema e rappresentazione della realtà il luogo stesso della sua poetica. Da questa premessa derivano dunque le riflessioni che seguono.

I. Per una periodizzazione del cinema di Loach
Gli studiosi più seri del cinema di Loach hanno impostato una possibile periodizzazione dell’opera di Loach. Alcuni di essi — giustamente — hanno incluso in essa anche i lavori televisivi, che rivestono un’importanza non inferiore all’attività cinematografica nella carriera del regista inglese. Il più acuto dei suoi critici italiani, Luciano De Giusti, distingue ad esempio le fasi cinematografiche (1967-1971, 1979-1981, 1990 — oggi) e le fasi televisive (1964-1969, 1971-1975, 1980 — 1984), andando alla ricerca di simmetrie e opposizioni interne ritmate dal diverso approccio esperito nei diversi mezzi espressivi. Jacob Leigh, al contrario, non segue l’ordine cronologico, e cerca di distinguere le fasi tematiche dell’opera di Loach a seconda degli elementi di spicco interni ai singoli film. Di qui la scelta di raggruppare, per esempio, i film della “Experience of History” (The Big Flame, 1969, The Rank and the File, 1971, Days of Hope, 1975) in un ambito separato da quelli indicati come “The Core of What’s Happening” (Raining Stones, 1993, Ladybird Ladybird, 1994, Land and Freedom, 1995). Al contrario, Graham Fuller — nel ricco libro-intervista che ha dedicato a Loach -, suddivide I film di Loach in “Primi sguardi”, “Plays of Hope”, “Conflitto”, “Assedio” e “Rinascita”, seguendo l’ordine cronologico ma separando nettamente le diverse fasi.
Si tratta di tentativi di sistematizzazione intelligenti e spesso complessi, che dimostrano quanto sia folta la produzione del cineasta e quanto difficile da ordinare. Non voglio tuttavia rinunciare al cimento, per cui proverò a offrire la mia periodizzazione:
1) 1964 — 1966: periodo della ricerca di un linguaggio; 2) 1967 — 1971: periodo dei “film della famiglia”; 3) 1973 — 1980: periodo della “riflessione sociale”; 4) 1981 — 1990: periodo della “eruzione della politica”; 5) 1991 — 1994: periodo dei “generi sociali”; 6) 1995 — 2000: periodo delle “conferenze internazionali”; 7) 1999 — 2004: periodo della “resistenza alla fine del lavoro”.
Vediamo le varie fasi una per una.
1) Si tratta, con tutta evidenza, degli esordi di Loach. Come le biografie raccontano, sappiamo che Ken Loach compie il suo apprendistato alla BBC, prima come collaboratore poi come regista di episodi della serie Z Cars. Il dato importante è che si tratta di televisione in diretta, secondo una prassi tipica del piccolo schermo degli anni Cinquanta e Sessanta, introdotto dalla new wave americana (Lumet, Frankenheimer, Penn). Questo è solo il primo dato in grado di dimostrare l’importanza che per Loach riveste il momento della messa in scena. Il primo vero lavoro come regista che firma la propria opera è Catherine, capostipite di una lunga serie di ritratti femminili. A detta dello stesso autore, poi, gli episodi della serie Diary of a Young Man a lui affidati nel 1964 assumono un certo valore considerando la libertà di sperimentazione che gli era permessa. Il lavoro sul linguaggio cinematografico non può che dirigersi in senso emulativo verso le novità provenienti dalla nouvelle vague e dal free cinema, influenza su cui tornerò poiché è stata sottovalutata dalla maggior parte dei commentatori. In questi anni, Loach dirige alcuni plays teatrali adattandoli alla televisione con aggressività e spigliatezza — e ricevendo anche un premio della Birtish Tv Guild —, e giunge con Up the Junction — cronaca minuziosa e sociologica della vita di tre operaie — a modificare fin dal profondo le convenzioni del linguaggio televisivo, grazie a una macchina da presa mobile e osservatrice e a un montaggio ancora una volta godardiano.

Cathy Come Home, del 1966, rappresenta la vetta della prima parte della carriera del regista. La ricerca di un linguaggio sembra a buon punto. Il film racconta la vita di una coppia di disperati, cui lo stato prima toglie la casa e poi anche i figli, anticipando di anni la vicenda narrata in Ladybird Ladybird. La storia è interrotta spesso da statistiche e cifre sociali elencate da una voce over. L’osservazione, pur ottenuta attraverso formule antinaturalistiche e momenti di straniamento narrativo, giunge al cuore dei personaggi e impone in Gran Bretagna il nome di Kenneth Loach (solo più tardi si firmerà con l’abbreviativo Ken).
2) Il 1967 segna l’esordio cinematografico di Loach. Come abbiamo visto, sarebbe sbagliato pensare che tra il mezzo televisivo e il grande schermo, per il regista inglese, vi sia una differenza quantitativa, o che il primo venga subordinato al secondo. Al contrario, la carriera televisiva di Loach non si ferma qui e anzi prosegue, pur diradando negli ultimi anni i lavori per il piccolo schermo, fino a oggi. Poor Cow, dunque, è il suo primo film per il cinema. Si tratta di una pellicola a colori, scelta che impedirebbe — secondo lo stesso regista — al film di sprigionare la forza e la rabbia necessarie. Molta critica tende a convenire con Loach rispetto allo scarso esito del film. Al contrario, la figura di Joy — indecisa, volubile, maltrattata protagonista che passa da un galeotto a un altro — esibisce una originalità fuori discussione, e tradisce alcuni degli elementi ritornanti dei personaggi femminili successivi (l’impotenza di fronte all’aggressività maschile, la pervicacia nel mettere al mondo figli come unica forma di speranza, il sacrifico). Proprio la fragilità di questa donna senza grandi virtù — e certamente non quella della fedeltà — la rende umana e credibile. Tanto quanto la Kate di In Two Minds (1967), importante lavoro televisivo dello stesso anno che porta sullo schermo un testo di David Mercer, poi trasposto al cinema anni dopo dallo stesso Loach — in una sorta di autoremake — con Family Life (1971). Qui l’ispirazione proviene dalle teorie anti-psichiatriche di Ronald Laing, tuttavia il “fuoco” del discorso è sempre mantenuto sulle storture dell’ambiente famigliare e sui soprusi che un intero sistema sociale giunge a far penetrare fin nei recessi della vita domestica. La “malinconia” di Kate, travolta da elettrochoc e cure forsennate, non è altro che la resistenza passiva di una persona di fronte a un mondo dominato da leggi assurde. Questi sono, in fondo, i “film di famiglia” di Loach, che in questa fase sembra soprattutto interessato a mettere l’indice sulle devastazioni prodotte dalla piccola borghesia, parodia di un capitalismo intemerato. Anche Kes (1969) è la storia di una famiglia, sebbene questa volta il protagonista prescelto sia un ragazzino con la passione degli uccelli (in particolare di un gheppio). La violenza del fratello maggiore, abbinata all’indifferenza di genitori e insegnanti, fa il resto. Tra gli altri film televisivi di questi anni — dedicati quasi tutti a problemi sociali e lavorativi — spicca, non a caso, oltre a The Rank and the File, After a Lifetime (1971) che mette in relazione le lotte sindacali dei padri con quelle intraprese dai figli. E, infine, il nuovo lungometraggio per il cinema, Family Life, che riprende la storia di Mercer e la divulga a un più ampio spettro di pubblico, questa volta internazionale, che ne decreta un successo lusinghiero.

3) Loach sembra essersi spinto troppo in là. I progetti cinematografici languono, i produttori esitano, il clima nella vecchia Gran Bretagna sembra farsi molto cupo. Ancora lavori televisivi, tra cui Days of Hope, sceneggiato lungo e complesso su un celebre sciopero di minatori degli anni Venti, (che Luciano De Giusti chiama correttamente “uno Heimat inglese”, a chiarire il respiro narrativo di cui — se vuole — è capace il regista), o The Price of Coal (1977); e persino un film in costume, questa volta per il cinema, Black Jack (1979), storia più lieve tratta dal romanzo di Leon Garfield. Ad accompagnarlo in questi anni, il fido produttore Tony Garnett. È il periodo della riflessione sociale, di una specie di “ritirata strategica” in attesa di mettere a punto nuove forme di discorso, di osservazione apparentemente distante dove si cela un continuo lavorio, un incessante studio delle possibilità di racconto della società.
4) Looks and Smiles (1981) — a tutt’oggi uno dei capolavori di Ken Loach — impone una concretezza che covava sotto la cenere. È la storia di due giovani amici, che bighellonano in una Sheffield deprimente e priva di qualsiasi prospettiva. Uno dei due è sempre alle prese con liti e insoddisfazioni, l’altro — non meno sbandato — decide di seguire l’invito dell’esercito ad arruolarsi e viene mandato nella pericolosa Irlanda del Nord a sedare l’insurrezione armata. Questa volta, Loach gira in un bianco e nero color pece, perfettamente modulato da Chris Menges, direttore della fotografia molto importante per la messa a punto delle idee visive del cineasta. L’infelicità di Mick, il protagonista, è almeno mitigata dalla presenza di Karen, sua giovane compagna. Entrambi, però, scontano una situazione famigliare sconfortante — infatti Karen fugge dalla madre e dal patrigno per raggiungere il padre, che intanto si è rifatto una vita e una famiglia. Oltre alle figure di donne adulte e sole, a Loach interessano i protagonisti adolescenti, strozzati da un futuro impossibile (come in Kes, e come nel penultimo, straziante Sweet Sixteen, 2002). Lo scacco è squisitamente politico. Ed è proprio la politica, senza più mediazioni famigliari o allegoriche, ora a erompere. Loach gira alcuni documentari militanti (The Red and the Blue e Questions of Leadership, 1983, Which Side Are You on?, 1984), dedicati ai partiti e ai lavoratori. È il periodo che ospita due importanti film di Loach, o almeno due tra i più coraggiosi mai girati, il poco conosciuto Fatherland (1986) e The Hidden Agenda (1990). Se nel primo caso, Loach fa i conti con il comunismo dell’Est Europeo — senza falsi pregiudizi e anzi con una quota di dolore personale esposta in nome della sincerità —, nel secondo si va ad affrontare a muso duro la scottante situazione nord irlandese. Se si pensa che nemmeno i laburisti — almeno prima dell’arrivo dell’uomo forte Tony Blair, che ha cercato di risolvere la lunga guerra costringendo al tavolo delle trattative le due parti — hanno mai potuto esporsi più di tanto sui sanguinosi fatti irlandesi, si può capire come un film che mette in scena un complotto e che accusa direttamente i capi politici e militari dell’occupazione britannica, abbia creato lo stesso baccano di La battaglia di Algeri (1966), se non di più. Questa volta Loach imposta un “crescendo” vicino al genere thriller, o meglio al thriller politico, non immemore — crediamo — delle opere di Francesco Rosi. The Arthur Legend (1990-1991), documentario dedicato agli attacchi politici e mediatici nei confronti del leader “rosso” dei minatori Scargill, conclude un decennio “furioso”, che pone Loach al centro dell’attenzione, delle polemiche (viene accusato, come spesso accade a chi vuole ragionare senza fanatismi, di essere “fiancheggiatore dei terroristi”, in questo caso l’IRA), e del cinema d’autore. Sui termini teorici della questione torniamo tra poco.

5) Il 1991 è l’anno della consacrazione mondiale. Il film Riff-Raff, grazie alla sapiente produzione di Channel Four, lancia l’opera del cineasta. Per molti spettatori, persino per qualche giornalista disinformato, si tratta dell’esordio di un nuovo grande regista inglese. Il che la dice lunga sull’invisibilità della precedente produzione, non solo televisiva, di Loach e del cinema britannico in generale. Inoltre, il film apre una vera e propria British Renaissance, che in verità c’entra poco con Loach se non per il fatto che da quel momento in poi il connubio tra commedia e pamphlet sociale diventa una moda (si pensi agli enormi successi di film “annacquati” come The Full Monty o Grazie, signora Thatcher). Riff-Raff sembra lavorare al meglio sui codici che erano tipici della commedia all’italiana bagnati però in un approccio linguistico fatto di modernità e realismo “camera a mano”. Il racconto di un gruppo di manovali che lavorano in nero senza alcuna garanzia sindacale né sanitaria, e la cronaca delle loro peripezie per arrangiarsi a sbarcare il lunario restano nell’immaginario collettivo. L’apologo, pur non essendo il più efficace tra quelli del regista, si impone per forza espressiva e cura dei personaggi. Volti, dialoghi, elementi colti dal vivo, come fossero morsi di realtà staccati a colpi di macchina da presa, conquistano quasi senza grancassa mediatica il pubblico dei cinema d’essai. E fanno di Riff-Raff una specie di “long seller”, ma anche una matrice dalla quale Loach faticherà poi a divincolarsi. Per questo motivo, il seguente Raining Stones viene da alcuni erroneamente percepito come un Riff-Raff parte II, solo per il fatto che al centro dell’attenzione c’è di nuovo la classe proletaria e si riaffacciano quartieri, case, persone simili a prima.
Si tratta di un effetto-rimbalzo dovuto al fatto che pochi ancora comprendono come per Loach quell’universo sia lo scenario della propria opera-mondo, del proprio infinito romanzo sociale, del proprio affresco alla Zola a alla Balzac. Di nuovo, vi è il pregiudizio inconsapevole che inchioda chi fa film “sociali” al contenuto degli stessi, per cui si finisce col considerare ridondante ogni messaggio che appaia simile a quello precedente. In verità, Raining Stones appare più amaro del film di due anni prima. Esso possiede qualche similitudine con Prima comunione (1950)di Alessandro Blasetti — prova ulteriore di una qualche conoscenza del cinema realista italiano da parte di Loach —, anche se vira verso una tragedia sociale di vaste dimensioni. La funzione ironica, in questo caso, non serve a distanziare criticamente i personaggi, bensì ad avvicinarli attraverso forme di empatia. D’altra parte, è la prima volta che Loach mette in scena così esplicitamente la tensione verso l’illegalità prodotta da disoccupazione e mancanza di prospettive. Bob, il padre che cerca in tutti i modi di trovare i soldi per acquistare la veste da prima comunione per la figlia, è una figura ingenua e sfortunata, che finisce col precipitare — di lavoro umile in lavoro umile — tra le braccia di uno strozzino. Uccisolo involontariamente dopo una dura colluttazione, Bob si confessa all’amico prete, che gli consiglia di non dire nulla alla polizia. Il comportamento del religioso, che ha scatenato non poche indignate proteste in una parte della stampa, mostra la sicurezza con cui Loach ormai tratta i proprio argomenti. Fare il cineasta di parte non significa, dunque, ricorrere a tattiche ed espedienti per dimostrare una tesi, ma far scorrere di fronte alla macchina da presa vita e scelte, anche le più criticabili, dei propri personaggi. Essi sono umani, come umano è il prete rappresentato, solo questo conta per il regista. Dalla “dimostrazione del mondo” sorge la tesi, non prima. Dalla consapevolezza che Loach non “forza” alcuna situazione emerge l’esigenza politica (la redistribuzione sociale, la solidarietà commerciale e così via).
Dopo una commedia e una sorta di thriller a orologeria, si passa a un melodramma proletario, a parere di chi scrive l’opera più importante e strategica della carriera di Loach. Ladybird Ladybird racconta una storia ispirata a un fatto di cronaca, l’odissea umana e giudiziaria di una donna cui vengono strappati i quattro figli (da quattro padri diversi) per opera dei servizi sociali, quindi anche i due avuti dal nuovo compagno. È necessario comprendere che l’esplosione internazionale di Loach coincide con un movimento di “generi sociali” che identifica la fase della carriera di cui stiamo parlando. Evidentemente non si tratta, per il cineasta, di giocare con una tradizione codificata, bensì di accogliere, senza paura, anche elementi configurativi di narrazione che non ostano al principio realista e che aumentano il grado retorico (nel senso etimologico del termine) necessario alla disposizione dei materiali del racconto.

6) Si apre con Land and Freedom la fase più discussa del cinema di Loach. Per la prima volta, infatti — se si escludono le pellicole in costume — il regista si allontana dal mondo inglese e scozzese per indagare gangli ancora irrisolti della storia dell’idea socialista, ieri e oggi. Ispirandosi piuttosto platealmente al modello di Orwell (Omaggio alla Catalogna, come ammette il fido sceneggiatore Jim Allen), qui egli racconta la storia di David, giovane idealista della Liverpool del 1936, che parte per la Spagna allo scopo di dar manforte ai gruppi di opposizione antifascista. La vicenda di David, entrato nel POUM (gruppo di guerriglieri di ispirazione marxista e dalle venature anarchiche) diventa un vero e proprio romanzo di formazione politica, che sfocia però in tragedia. Non è infatti la violenza dei fascisti a distruggere l’esperienza rivoluzionaria, bensì i drammatici dissidi tra la Brigata Internazionale, egemonizzata da Stalin, e il resto degli insorti. Per Loach, Land and Freedom non è dunque solo il nostalgico ritorno a un momento, brutale e terribile, nel quale nascevano le grandi idee collettive e, diciamolo pure, comuniste, ma uno dei momenti-chiave della storia della sinistra, destinata per sempre a dividersi. È chiaro che di fronte a un film dallo sforzo economico senza precedenti, almeno nella carriera di Loach, il regista deve forzatamente adeguare anche il proprio stile ai momenti epici. La trasformazione non è indolore, e si comprende bene come il cineasta si trovi più a suo agio nei momenti “polifonici” che gli sono cari, dove le voci si sovrappongono, il reale si intorpidisce, i personaggi si moltiplicano, come nel caso della celebre scena della discussione sulla collettivizzazione delle terre. Quelle che abbiamo chiamato “Conferenze Internazionali”, proseguono con l’ottimo Carla’s Song, 1996, scritto da un avvocato, Paul Laverty, che aveva speso due anni della sua vita in Nicaragua, nel periodo della controrivoluzione somozista ai danni dei sandinisti. Il film, per la prima volta in Loach, è definitivamente spaccato in due. Una prima parte racconta, a Glasgow, dell’amore di un conducente d’autobus per la bellissima Carla, nicaraguese d’origine. La seconda, invece, trasporta il protagonista proprio nel paese centroamericano, dove la violenza e la barbarie dei somozisti appoggiati dalla CIA travolgono il sogno di amore e pace sociale del protagonista. Si tratta di una specie di incontro tra i due mondi che Loach ha narrato fino a quel momento, o tra il suo cinema precedente e quello di Land and Freedom. Ancora una volta, parte della critica storce il naso, specie di fronte ad alcune sequenze di battaglia e guerriglia, che tradirebbero le qualità non eccelse del regista al di fuori dei propri confini estetici. Non si sottolinea abbastanza, al contrario, il coraggio e la messa a prova continua del proprio cinema da parte di Loach, che ormai non sembra temere più alcuna sfida. In questa fase andrebbe anche inserito — anche se fuori “periodo” — il meno riuscito Bread and Roses (2000), dedicato alla disoccupazione in America.

7) E a sua volta, My Name is Joe (1998) anticipa l’ultima parte della carriera di Loach, che abbiamo chiamato “resistenza alla fine del lavoro”. Joe, come tutti i protagonisti successivi, affronta il mondo del capitalismo che ha trionfato, della fine del comunismo, del modello sociale americano che ha permeato di sé anche i paesi a guida socialdemocratica. Il pessimismo di Loach nasce proprio nel periodo della famosa “terza via” (sostenuta dall’SPD tedesco, da Prodi, da Clinton, da Blair) e dalla disillusione prodotta dalle sterzate a destra del capo dei laburisti. Non è ancora tempo di destre al governo (Aznar, Bush, Sharon, Berlusconi), che naturalmente a un uomo di sinistra come Loach fanno semplicemente orrore. Non si tratta, secondo lui, di una vera e propria contrapposizione sui modelli sociali, bensì di un’interpretazione più o meno aggressiva del capitalismo. Quel che rimane è una progressiva distruzione del mondo del lavoro. Ciò che prima era ai limiti dell’illegalità, ora diventa progetto economico. Se My Name is Joe è un film su un uomo sfortunato in ogni momento della sua vita, private e professionale, The Navigators (2001) cita esplicitamente i lavoro interinale, anzi è un grande romanzo, il primo dell’era postmoderna, sul senso del lavoro a termine. In molti hanno notato come Paul, Mick e gli altri offra una sensazione di rinnovata energia, di atteggiamento crudo e aspro, di ritorno alla polemica degli esordi. È così. Il nuovo Loach torna a chiedere carburante espressivo alla prima parte della sua opera, persino agli esordi televisivi. La morte di Jim Allen nel 1999 e la rinnovata stima in Paul Laverty (che firma anche Sweet Sixteen) fanno sì che per il regista voltare pagina diventi un’attività periodica. Proprio Sweet Sixteen torna a raccontare l’adolescenza. Ogni volta che un’epoca si apre, o che una stagione di ingiustizie sociali si inasprisce, infatti, Loach torna a parlare dei minorenni, e dei danni che i padri e le madri fanno ai proprio figli. Il film diventa poi una sorta di Quattrocento colpi calata nell’oscuro budello della vita di una città scozzese. La malavita e la mancanza di futuro si attraggono, come sempre, in uno dei ritratti più sentiti e impietosi di un maestro del cinema giunto al pieno controllo dei propri mezzi espressivi, un cineasta che continua a scegliere la pluralità alla perfezione e la forza realista allo spettacolo d’autore (che pure ormai si potrebbe permettere). E così, nel film collettivo 11 settembre dedica il proprio episodio al ricordo di un altro, spaventoso e persino più sanguinoso 11 settembre, quello del 1974 in cui morirono migliaia di cileni durante il colpo di stato ai danni di Allende.
II. Il realismo di Loach: questione di stile
È certamente vero che il cinema del regista britannico può essere definito “realista” senza pericolo di incorrere in errore. A una funzione di rappresentazione della realtà sociale lo chiama il cineasta, a una testimonianza sociale lo collega lo spettatore, ed è intorno a queste forme di referenzialità che discutono giornali, televisioni e cronache quando hanno a che fare con i film di Loach. Tutto bene, quindi. Salvo che è necessario, da parte di una critica che non si accontenti dell’ovvio, riflettere su quello che comporta questo concetto di realismo. Anzitutto, va ricordato che — di tutti i realismi possibili — quello di Loach è il più garantito, nel senso che egli si occupa di personaggi “situati” storicamente e socialmente, il cui contesto funge da garanzia veridica. Inoltre, egli parla quasi sempre di un mondo che mostra di conoscere, instaura cioè un patto fiduciario con lo spettatore in virtù del fatto che egli — uomo di sinistra, regista militante, persona fiera e colta — quelle cose “le vive”.

D’altra parte, si tratta di un realismo assai diverso da quello ipotizzato in alcuni momenti della storia del cinema. Pensiamo per esempio alla teoria della fotogenia, che pretende che sia il dispositivo a “svelare” le potenzialità estetiche del reale, o a Bazin che giudica il cinema ontologicamente realista a causa della natura del mezzo o ancora al Dogma, che fa del pauperismo tecnico un viatico fondamentale per raggiungere il cuore stesso della realtà. In Loach, al contrario, non esiste un partito preso programmatico atto a facilitare l’incontro col reale. Egli, per fare un esempio, non è certo un fanatico del piano-sequenza, figura linguistica che invece — da Bazin in poi — è diventato il passaporto “ontologico” di molto cinema d’autore (da Godard a Hou Hsiao Hsien, da Straub a Ciprì/Maresco e mille altri ancora). Ciò non esclude però che operi scelte coerenti con ciò che intende raccontare. E qui si trova il piano più nascosto dell’estetica loachana: la messa in scena. Si tratta di un approccio indefinibile, che unisce apparente casualità a forme strutturali predeterminate, che ammette l’idea dell’attesa e della rivelazione (il cineasta zen che chiede al fenomenico di restituire ciò che di più proprio), che ha una natura antropocentrica e narrativamente forte. Riff-Raff è esemplare in questo senso, poiché innesta un’architettura di commedia in un contesto ultra-realista e quasi cronachistico. Questo effetto — che peraltro infastidisce i detrattori di Loach — è ottenuto grazie a un uso della macchina da presa che potremmo definire di “improvvisazione controllata”. Non sono più gli attori — come in Cassavetes, per esempio — a costituire l’elemento irriducibile dell’operazione filmica, bensì la regia stessa. Loach non ammette di scegliere a priori dove posizionare la macchina da presa, se non in rari casi. D’altro canto, però, non è un giansenista della messa in scena, per citare un famoso aforisma, e nulla gli interessa dell’inquadratura e del piano come forme linguistiche di un qualche peso. Il suo stile è così fatto di tagli secchi, di movimenti apparentemente casuali, di attenta registrazione di quel che accade — nei dialoghi, per esempio, la macchina tende a seguire il parlante “dopo” che questi ha preso la parola, come se fosse cioè un ascoltatore che volge lo sguardo per ascoltare. Loach non desidera evitare l’uso del campo/controcampo o delle convenzioni classiche, semplicemente ne libera le potenzialità obbedendo prima di tutto al contesto. Conta di più la “presenza” del reale che non il consenso teorico a qualche forma di dogma.
A volte, questo metodo alimenta qualche sospetto di incuria o di rozza staticità della regia. Non si tratta di questo. Lo stile di Loach è unico proprio perché è uno dei pochi cineasti che fa dell’assenza di stile il proprio punto di forza. Un po’ cinéma-verité, un po’ documentario, un po’ dramma tradizionale, un po’ cinema a tecnica leggera, la “mano” di Loach è riconoscibile tra mille, più delle mdp affannate e traballanti dei Dardenne, più dei piani infiniti di Pedro Costa, più delle geometrie euclidee di Almodòvar, più dello sporco digitale di Von Trier, e così via. I suoi ambienti “pesano” più degli altri, i volti che mette in scena “dicono” meglio di tutti, la rappresentazione sociale scandisce la propria autenticità in maniera inequivocabile. Come scrive Michele Marangi, “Al di là dell’understatement tipicamente inglese, la scelta di Loach appare non solo dettata da questioni economiche, quanto dal rigore narrativo: dopo pochissime inquadrature ha già contestualizzato un ambiente — fisico e sociale — e individuato un protagonista, che sempre appare in costante dialettica tra le caratteristiche sociali e quelle personali”. A sua volta, in un acuto saggio sul realismo di Loach, Norman Gobetti mette in luce come esso produca di fatto un atteggiamento morale, per via di ciò che potremmo definire la “affermazione e la difesa dell’esperienza personale di fronte all’ideologia e al feticcio professionale; una affermazione estetica: la fiducia nella spendibilità filmica di questa esperienza (si potrebbe dire nella porosità della pellicola cinematografica rispetto alla vita); e una scelta di campo politico: lavorare il più possibile all’interno della classe operaia”.

Certo, esistono altri elementi in grado di enfatizzare l’impressione di realismo. Per esempio, la scelta degli attori, non di rado individuati tra i lavoratori della classe sociale che rappresenta il soggetto del film, o tra coloro che hanno vissuto in prima persona drammi simili a quelli dei personaggi (Crissy Rock e Vladimir Vega, esule cileno, impiegato poi anche — struggentemente — per 11 settembre). Ciò, naturalmente, non significa contraddire quanto scrivevamo all’inizio, rispetto alla turbolenza artistica — incompresa — di Loach. Si pensi a un film come Poor Cow, dove, pur essendo presenti temi e figure del cinema loachano, si fanno strada scelte destinate a non ripetersi, come i cartelli godardiani, le finte interviste, gli sguardi in macchina, le libertà strutturali, l’aria un po’ Swingin’ London. Pensiamo alla differenza tra quel ritratto femminile e Ladybird Ladybird. Qui l’accensione realista ha un motore tutto diverso. Si tratta, in fondo, di un women film ambientato nel sottoproletariato inglese. Qui l’oscillazione tra il caso particolare di accanimento giudiziario e la denuncia generale degli abusi sociali è perenne, e permette al film di trarne beneficio, rendendolo palpitante.
La natura ambigua di Ladybird Ladybird è dovuta anche all’inedita forma melodrammatica che la narrazione sembra assumere. Loach, pur di non sottrarre un’oncia alla crudeltà della situazione, mostra la protagonista quando ha già subito la perdita dei primi figli, e ne racconta il ritorno alla vita, l’incontro con un uomo buono e onesto, la ricerca di una sia pur provvisoria felicità. Per una volta, la famiglia — almeno quella nuova — può funzionare da argine alla violenza di una vita segnata dal disordine, ma a distruggere tutto interviene l’autorità giudiziaria, pronta a prendere con sé i neonati della donna. La gravidanza come atto di ribellione alle proprie sfortune diventa un atroce coazione a ripetere, ogni figlio — nella sua unicità — diventa eguale agli altri per difetto: infatti, Maggie li perde tutti, impotente, uno per uno. È il film in cui Loach — in questo rispettando la scelta interpretativa di Crissy Rock — lascia più spazio alla rappresentazione del dolore, e il cui meccanismo di strangolamento narrativo punta alla commozione incredula dello spettatore. Non deve essere un caso se proprio questo film è stato il più discusso e variamente interpretato dalla critica. De Giusti è tra i pochi a nominare, non senza ragione, la tragedia. Scrive, infatti: “È l’ombra cupa di questo aspetto barbarico che, oscurando l’immensa tenerezza della storia d’amore, ha dettato al film la sua forma, quella della tragedia. Una tragedia moderna. Ladybird Ladybird costituisce una variazione in chiave contemporanea della strenua lotta ingaggiata dall’individuo contro una forza soverchiante. Come la tragedia antica, possiede un nucleo mitico: Maggie patisce la violenza primordiale della madre che vede reciso, da un potere arbitrario, il legame di sangue con i figli”.

Leigh, che invece suggerisce eloquentemente di considerare il film “a melodrama of protest”, insiste sul fatto che — d’accordo con le caratteristiche melodrammatiche individuate da studiosi come Christine Gledhill o Steve Neale — anche Ladybird Ladybird sottenda elementi di “sproporzione narrativa” e strategie dell’eccesso. Ovvero, come in tutti i melodrammi, Loach disporrebbe a piacimento dello spettatore per portarlo alla completa adesione rispetto al punto di vista di Maggie, attraverso l’uso di flash-back arbitrari e scene-madri di dolore e passione. A sua volta, Francis Rousellet si concentra su questo film in quanto sintetizza vari momenti della carriera di Loach, così come Maggie — tanto simile alla Cathy di Cathy Come Home — riassume un po’ tutte le donne dipinte dal regista: deboli, sfruttate, oppresse, brutalizzate, fragili, spesso “sbagliate” ma profondamente compassionevoli e umane, a differenza dei maschi.
Looks and Smiles, invece, considerato come film di apertura di una fase cinematografica nuova e per certi aspetti più consapevole, aveva destato l’attenzione dei Cahiers du Cinéma. L’estensore dell’articolo — il futuro cineasta Olivier Assayas — , pur ammettendo di non amare particolarmente l’opera di Loach, non può fare a meno di notare che il regista riesce a “trascendere il dogmatismo del suo progetto grazie a una eccezionale capacità di dare vita a personaggi e ad esprimere un sentimento di tenerezza nei loro confronti”. È proprio la “tendresse” di cui parla Assayas che si prova di fronte a certe donne e certi uomini dei suoi film. Il passaggio di questo sentimento dal cineasta allo spettatore rappresenta la cerniera di congiunzione tra le varie forme stilistiche adottate nelle diverse fasi della carriera, quel nocciolo umanista che il cinema di Loach non ha mai disperso.
Quella “tendresse” non manca nemmeno alle opere internazionali di Loach, a cominciare da Terra e libertà, che ha fatto tanto discutere storiografi e intellettuali (basti pensare al duro e leale scambio di opinioni — rispettivamente negativa e positiva — sul film da parte di Manuel Vazquez Montalban e Rossana Rossanda, ora in apertura del libro omonimo edito da Gamberetti Editore). È la garanzia di una posizione antropocentrica, come si è detto, che trascende i singoli momenti storici nei quali i personaggi si trovano a esistere. Forse, Terra e libertà dà più di un problema poiché proprio la nozione di realismo, dalla quale siamo partiti, scricchiola. In che senso? Per l’argomento stesso. Si può offrire una “promessa (esaudita) di realismo” se si parla di Liverpool, Manchester, Glasgow o Sheffield e di quei quartieri operai che sembrano comunicare da soli il proprio disagio. Si rischia di più, ovviamente, se si decide di ricostruire — intendo dire anche materialmente, su un set che non è più quello reale degli slums operai — un evento storico di tale portata. Segno, si diceva, dell’insofferenza di Loach alla monotonia, della tendenza alla sperimentazione che lo contraddistingue.
III. Influenze originalità del cinema di Loach
Ci si è spesso chiesti da dove “provenga” il cinema di Loach. Le definizioni che ne sono state date sono numerose, e mutevoli a seconda del momento. Docu-drama, realismo sociale, kitchen sink drama, free cinema, dramma proletario, neorealismo all’inglese, commedia drammatica, cinema di denuncia, filone civile, sono solo alcune delle etichette — più o meno di comodo — con le quali i recensori hanno cercato di spiegare ai propri lettori che tipo di film sarebbero andati a vedere. Appena conosciuto il cinema di Loach, in verità, non c’è più bisogno di farsi queste domande. Gli spettatori lo seguono in virtù di un rapporto ormai consolidato ed estremamente confidenziale. Tuttavia, anche in questo caso, non bisogna sottrarsi all’analisi.

I primi lavori di Loach non possono che tenere conto del clima culturale e cinematografico che si respira in quel momento in Europa. I primi anni Sessanta — per chiunque faccia cinema fuori da Hollywood — sono segnati dal clamore che ha destato la Nouvelle Vague. Il linguaggio cinematografico — grazie ai francesi ma anche a tutte la altre “onde” che seguono — subisce una costante innovazione, sia in senso espressivo che strutturale. L’aggressione che Godard in particolare compie verso il racconto cinematografico tradizionale e verso codici e convenzioni che lo sorreggono, è imitato da mezzo mondo. Non è una sorpresa, quindi, constatare come il giovane Loach sia propenso a utilizzare alcuni strumenti antinaturalistici (tipici di quegli anni) anche nei lavori televisivi. A distinguere radicalmente i due autori c’è però l’impegno politico. L’anarcoide e selvaggio Godard si politicizza lentamente, fino alla svolta del ’68 e alla rinuncia della “firma” per il collettivo Dziga Vertov. Per Loach, invece, è da subito naturale immettere alcune delle svolte linguistiche suggerite dal “nuovo cinema” in un contesto di granitico realismo. Anche in questo caso, lo studio del contesto britannico aiuta a comprendere. Il cinema inglese, come noto, non ha una vera e propria nouvelle vague per come la intendono a Parigi, ma da qualche anno — già dagli anni Cinquanta — si muove il cosiddetto Free Cinema, movimento fondato da Karel Reisz e Lindsay Anderson che intende posizionarsi a fianco della new wave teatrale degli Angry Young Men. Si tratta, come si è spesso detto, di un contenitore più che di una scuola poetica, che avvicina registi tra di loro differenti per sensibilità e formazione, in grado tuttavia di lavorare ai fianchi la tradizione cinematografica britannica. L’evoluzione formale è minima, la scelta dei soggetti invece rivoluzionaria (si pensi a opere come Io sono un campione di Anderson, Sabato sera domenica mattina di Reisz, I giovani arrabbiati e Gioventù, amore e rabbia di Richardson, solo per citare le pellicole dei primi anni Sessanta). Lo spirito anti-istituzionale e la scelta di raccontare vite alternative anima i film di finzione di molti registi del periodo, sebbene il documentario sembri il terreno d’elezione del movimento. Debolezze strutturali a parte, il free cinema influenza chiaramente Loach, che pensa di rapirne grinta e concretezza senza rinunciare dalle preziose suggestioni che giungono dal cinema francese.
Come terzo punto di riferimento, sembra chiaro che Loach guardi al neorealismo, che del resto era riconosciuto come modello sia dalla Nouvelle Vague — un po’ più “disimpegnata” — sia dai “nuovi cinema” del centro e sud America, di ispirazione politica, sociale e rivoluzionaria.
Del free cinema Loach mantiene la tendenza a conservare l’integrità della narrazione, alla nouvelle vague chiede invece il propellente necessario per disfarsi delle obsolescenti strutture narrativo-formali del cinema precedente (in Inghilterra: le commedie degli Ealing Studios e gli autori alla David Lean). L’elemento operaista emerge in sintonia con registi come Tony Richardson e Richard Lester (che pure compie un percorso un po’ diverso), per i quali porre l’attenzione sull’adolescenza o sul mondo dei proletari equivale a mostrarsi arrabbiati nei confronti di una società — quella britannica — incapace di rinnovarsi. Proprio il lento declino della grandiosità coloniale del Regno Unito è indicato da molti storici come il motivo essenziale della nascita di movimenti di protesta, da quelli teatrali a quelli cinematografici, per arrivare alla nascita del punk con i Sex Pistols. I fermenti di disgregazione imperiale offrono a cineasti come Ken Loach la possibilità di indirizzare in un discorso squisitamente politico anni di frustrazione, ingiustizia sociale e ignoranza dei più elementari diritti del lavoro. I crimini perpetrati in nome di un nazionalismo in via di rapido declino non sono più perdonati.
Quel che più sorprende nel rapporto con le nouvelles vagues è la capacità di travasare l’elemeno anarchicamente sperimentale (e gioioso e libero) di Godard & co. in un contesto lavorativo così concreto e preciso. Si può dunque ipotizzare che l’arte di Loach provenga dall’inedita fusione di questi elementi, ovvero dalla messa in opera delle istanze di rinnovamento provenienti da diverse cinematografie in Europa. Tra esse, quella francese — più spigliata e apolitica — e quella inglese — meno disinvolta ma più attenta al sociale —, fungono da poli magnetici in grado di venire disposti e manipolati (nel senso più creativo del termine) dal regista britannico. Inoltre, non va dimenticata una qualche analogia con il cinema ceco, che in quegli anni sta producendo una propria nouvelle vague, chiamata “nova vlna”, con centro catalizzatore a Praga. Qui opera Milos Forman, un regista che Loach ha indicato più volte come suo spontaneo compagno di strada, almeno fino al viaggio hollywoodiano dell’autore praghese. Effettivamente, film come L’asso di picche sembrano essere assai vicini allo spirito di Loach, per come sanno affiancare un affettuoso umorismo verso i proprio personaggi e una sintonia completa nei confronti dell’universo dei lavoratori.

A riprova di questa intima relazione con le poetiche più rivoluzionarie degli anni Sessanta, vi è un’opera come Sweet Sixteen, che sorprendentemente omaggia I 400 colpi di Truffaut, scoprendo la citazione solo nel finale — con il protagonista interdetto sulla spiaggia a scrutare un futuro che non c’è. Sia chiaro: nulla, durante questa storia di sopraffazione e deriva criminale, rimanda all’opera di Truffaut, eppure la sequenza conclusiva non lascia adito a dubbi. In fondo, quel che cerca il cinema di Loach non è proprio un rapporto di intimità quasi autobiografica con i personaggi, un’idea di condivisione e appartenenza, una promessa di verità nei confronti dello spettatore? In nome di questo metodo, personale e svincolato da ogni legge o convenzione, si fonda la vicinanza tra universi cinematografici così diversi. Tutto il resto è costituito da scelte: ad esempio scegliere di cantare il romanzo dei proletari invece delle disavventure adolescenziali di un giovane a Parigi. O farsi “incantare” dagli errori del proprio protagonista, fino a seguirlo nei passi più disastrosi. Sweet Sixteen, a quasi quaranta anni dall’inizio della carriera del cineasta, diventa forse il film che più di ogni altro evidenzia la matrice “nouvelle” del suo cinema, e che chiarisce simbolicamente il rapporto con i maestri francesi (Truffaut/Godard lavati al secco del dramma proletario e della depressione sociale).
Inoltre, non si può dimenticare come Loach faccia riferimento a un’intera cultura di sinistra, in grado cioè di rimettere in discussione abitudini e certezze di ogni disciplina umana e sociale. Con l’idea che qualsiasi aspetto della vita viene modellato dall’interpretazione che le istituzione ne danno, nasce un’opposizione aspra e polemica ai metodi di controllo sociale e cura dei cittadini. Ad esempio, il movimento antipsichiatrico che fa riferimento alle teorie di Laing è certamente l’influenza più importante su opere come In Two Minds e soprattutto Family Life; quest’ultimo rappresenta, tra l’altro, una delle vette del cinema loachano, per la capacità di rappresentare senza arrestarsi di fronte a nulla la capacità delle leggi statali di ferire a fondo una persona. Per Loach — e per l’autore del testo, David Mercer — la protagonista non ha altra colpa che quella di essere stata poco amata da una famiglia indifferente e ignorante, e di avere una tendenza alla malinconia e alla depressione. La violenza con cui parenti e società si abbattono su di lei genera inevitabilmente nuovo disagio sino a costituirne — in forma di paradossale cura — la principale causa. Il meccanismo implacabile con cui tutti infieriscono su Janice non è dissimile da quello di Ladybird Ladybird. Proprio in questi ritratti di donne incomplete e vessate sembra esaltarsi la narrazione più “potente” del regista, quella in cui l’apparente casualità di messa in scena, la trasparenza di un linguaggio spezzato ma antropico trovano perfetta sintesi. Il ventre oscuro della società dà in questi casi il peggio di sé, poiché — alla base del sistematico esercizio di ingiustizia — non vi è alcuna reale volontà di colpire quella determinata persona ma una più generale, indegna abitudine a rifiutare di rispettarne le relazioni umane, affettive, emozionali, che vengono così travolte per ignoranza.
Last but not Least, il cinema italiano. È piuttosto evidente come il “gesto” neorealista funzioni anche per Loach come una vera e propria tradizione sorgiva dalla quale ottenere la verità poetica tanto agognata. Come si diceva, tuttavia, non sembra interessargli tanto la lezione del Rossellini moderno, quella che poi trattengono proprio i Cahiers du Cinéma e la successiva Nouvelle Vague, che introduce un elemento di sospensione e riattualizzazione del linguaggio per adeguarlo al complesso e cangiante rapporto con la realtà. A ben pensarci, si potrebbe persino immaginare un Ken Loach immodesto al punto tale da cercare una propria, personale rifondazione del cinema realista attraverso la lezione italiana e la fusione degli elementi nouvelle vague, riportati nell’alveo principale da cui erano partiti, il neorealismo rossellinaino. A parte tutto, di neorealista in Loach c’è davvero tanto: l’utilizzo di set naturali, e di case, palazzi, cortili, strade, pub, vicoli, negozi, uffici scelti dentro il tessuto urbano delle città in cui il film viene ambientato; l’abitudine di individuare attori che provengono — in alcuni casi — dalla stessa classe proletaria di cui si narra, il più delle volte senza esperienze dirette nell’ambito del cinema o del teatro; di scoprire interpreti poco noti (che poi ricevono grande impulso dall’incontro con Loach, basti pensare ai casi di Robert Carlyle o Peter Mullan); la capacità di girare con troupe ridotte, mezzi limitati, macchine da presa mobili e leggere, enfatizzando l’aspetto documentario che proviene da un utilizzazione così concreta delle cose e dei luoghi.

D’altra parte, al cinema italiano, Loach sembra guardare in senso più ampio. Ciò che stupisce, infatti, è quella sensazione da “commedia all’italiana” all’opera che traspare dai film apparentemente più lievi del regista, quelli in cui c’è spazio anche per una comicità amara e consapevole (in particolare, Riff-Raff, Piovono pietre, Paul Mick e gli altri). In questo senso, viene il sospetto che si tratti di qualcosa di più che non una semplice coincidenza. Questa capacità di cogliere sul vivo il farsi della società, di criticare ironicamente la modernizzazione (pretesa) della comunità contemporanea, l’attenzione all’intreccio tra lavoro e vita privata, la sensibilità nel modellare personaggi la cui caratterizzazione è al limite — mai sorpassato — del grottesco rimandano proprio all’esperienza italiana — sia pure deprivata dell’aspetto carnevalesco e volgare che proviene squisitamente dalla nostra tradizione artistica.
Verrebbe voglia, perciò, di avvicinare Loach all’unica figura in qualche modo “autoriale” del cinema italiano in grado di mantenere coerente e acuto il proprio sguardo sulla società e sul lavoro, passando dal neorealismo alla commedia all’italiana e al cinema di ricerca: proprio Sergio Amidei, cui Premio e Catalogo sono come al solito ispirati. Non è forse Amidei ad avere scritto alcune delle più belle pagine del neorealismo (Roma città aperta, Sciuscià, Paisà), ad avere raccontato la storia per analizzare il presente (Cronache di poveri amanti come Terra e libertà), ad essersi avvicinato in forma di commedia a studi sociali di enorme impatto drammatico (Il medico della mutua, Anni ruggenti, Un borghese piccolo piccolo)?
Forse il paragone è azzardato, ma sarebbe Ken Loach il primo- questo straordinario cineasta di successo, eppure ancora così incompreso — a sentirsi onorato dell’accostamento, a darci ragione, a svelarci quanto vicino, quanto vivo e importante sia quel modello per la sua opera.
“Io penso che sia possibile filmare qualcosa che sia pienamente reale” (Ken Loach)
Il presente saggio è stato pubblicato sul Catalogo 2004 della XXIII edizione del Premio Sergio Amidei alla migliore sceneggiatura cinematografica.
Si ringrazia Roy Menarini, Giuseppe Longo e l’ufficio stampa del Premio per la gentile concessione.
Opere citate
AA.VV., Ken Loach, “Garage”, Scriptorium, Torino 1995
Jim Allen, Ken Loach, Terra e libertà, Gamberetti, Roma 1995
Olivier Assayas, “Le gentil prolétaire”, Cahiers du Cinéma, n. 328, ottobre 1981
Luciano De Giusti, Ken Loach, Il Castoro, Milano 1996
Sveva Fedeli, a cura di, Ken Loach, Quaderni della Mediateca, Firenze, 1992
Graham Fuller, Loach secondo Loach, Ubulibri, Milano 1990
Jacob Leigh, The Cinema of Ken Loach, Wallflower, London 2002
Francis Rousselet, Ken Loach, un rebelle, Cerf-Corlet, Paris 2002
















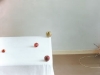




















Commenti
Trackbacks/Pingbacks
[…] In merito allo stile del regista, scrive Roy Menarini: “Se Loach ha saputo tenere alta la qualità del suo cinema è proprio in virtù di una spasmodica attenzione alla messa in scena, di un ragionamento inflessibile sui modi del racconto e dello stile, di una conoscenza puntuale della macchina-cinema e delle sue potenzialità. Non è vero che Loach sappia girare solo questo tipo di cinema. Anzi, i suoi film sono il frutto di una scelta estetica ponderata e riflessiva: è possibile affermare che ogni film di Loach è la negazione di tutte le altre possibilità con cui quella storia avrebbe potuto essere raccontata. E che ciascuna sua opera rappresenta al tempo stesso un partito preso del cinema che esclude tutti gli altri, secondo il celebre slogan di François Truffaut” (https://www.fucinemute.it/2004/08/per-un-cinema-del-reale/). […]