 Ci sono i Leoni d’Oro e i Leoni d’Argento. E poi ci sono i leoni e basta, giovani e vecchi leoni del cinema italiano e mondiale, che non ottengono magari i riconoscimenti, ma che sono leoni per il coraggio con cui affrontano prove rischiose, per il coraggio di mettersi in discussione, di tentare strade nuove. È un vecchio leone Gianni Amelio, non premiato con il suo Le chiavi di casa, ma autore di una prova superba. È un vecchio leone, leone d’Inghilterra, , lui sì d’oro, ma da lodare per il suo impegno sociale e politico e per il grande cinema. Lo è Wim Wenders, autore un po’ in calo, ma ancora in grado di dare zampate di classe e di poesia.
Ci sono i Leoni d’Oro e i Leoni d’Argento. E poi ci sono i leoni e basta, giovani e vecchi leoni del cinema italiano e mondiale, che non ottengono magari i riconoscimenti, ma che sono leoni per il coraggio con cui affrontano prove rischiose, per il coraggio di mettersi in discussione, di tentare strade nuove. È un vecchio leone Gianni Amelio, non premiato con il suo Le chiavi di casa, ma autore di una prova superba. È un vecchio leone, leone d’Inghilterra, , lui sì d’oro, ma da lodare per il suo impegno sociale e politico e per il grande cinema. Lo è Wim Wenders, autore un po’ in calo, ma ancora in grado di dare zampate di classe e di poesia.
È un giovane leone, smanioso di trovare il suo posto nel branco dei cineasti di razza lo spagnolo Alejandro Amenabar, passato a Venezia dal cinema di genere al cinema universale dei sentimenti, e lo è il coreano Kim Ki Duk, autore di un cinema diverso da tutto. E sono giovani leoni Javier Bardem, attore che fornisce una prova maiuscola in Mare Dentro, e il nostro Kim Rossi Stuart, leoni feriti, per i ruoli dolenti che interpretano, ma carichi d’orgoglio.
In questi nomi, ma non solo, c’è il meglio del Festival di Venezia. Almeno, speriamo: per la consueta rassegna Le vie del cinema, sono sbarcati a Milano molti dei film in concorso in laguna, a giudicare dalla stampa tutti i più importanti. Più qualche perla dalle sezioni minori, dal Festival di Locarno, e molti film fuori concorso, che sempre più oscurano quelli in concorso nei festival: è andata spesso così anche qui, ma si è trattato quasi sempre di film di gran classe. Il programma è stato molto ricco, i cinema in cui sono stati proiettati i film distribuiti su tutta Milano: distanti uno dall’altro, hanno costretto il pubblico a vere e proprie corse contro il tempo. E spesso a scelte dolorose: nell’impossibilità di vederli tutti, speriamo di avere scelto bene.
Partiamo dal film di Gianni Amelio, Le Chiavi di casa (Gianni Amelio, Italia, 105’), il vero vincitore morale della rassegna. Lasciando da parte le polemiche (quest’anno minori comunque di quelle dell’anno scorso per la mancata vittoria di Buongiorno, notte) e godendoci un film unico.
Amelio è partito da un libro di Pontiggia, Nati due volte, dedicato all’esperienza dell’autore con il figlio handicappato. Un handicap fisico che non deriva dai geni, ma dall’errore umano nella fase del parto, e per questo è ancora più difficile da accettare.
Amelio ha capito però che la storia del libro era un’esperienza unica, impossibile da ricreare sullo schermo. E da quella del libro è passato ad un’altra storia, comunque simile, costruendo il film sul giovane Andrea Rossi, un ragazzo veramente handicappato (il film è dedicato ad Andrea e Andrea, cioè a lui e al figlio di Pontiggia), e mettendogli accanto Kim Rossi Stuart, un attore noto per la sua sensibilità, sperando che avvenisse qualcosa. Ed è avvenuto: Stuart, incontrando Andrea, è andato al di là della recitazione, si è fatto coinvolgere, ha messo in scena la sua anima. Stuart è stato se stesso, “senza pelle”, senza protezioni, per dirla con il titolo di un suo film precedente. I suoi occhi che guardano Andrea, incantati, innamorati, stupiti, dicono più di mille parole.

I due, padre e figlio che si ritrovano dopo quindici anni, (il padre l’aveva dato in affidamento dopo la nascita senza mai conoscerlo) per un viaggio, in ospedale a Berlino e poi in Norvegia, hanno interagito in maniera davvero speciale. Il piccolo Andrea è stato se stesso, con naturalezza: una figura piena di vita, simpatica, coinvolgente, che non esita, in una delle scene più intense del film, a dire al padre “così non si fa” quando lo vede piangere.
Il film è tutto in questo meraviglioso rapporto, raccontato con semplicità sia a livello di sceneggiatura (di Rulli e Petraglia, che disegnano ancora una splendida immagine della diversità, dopo la Giorgia de La meglio gioventù), sia a livello di regia, pulita e senza virtuosismi inutili, con una fotografia che privilegia i toni chiari e tenui e una luce bianca, quasi a trasmetterci un senso di innocenza.
A Berlino Andrea/Paolo e il padre incontrano la madre di una ragazza disabile (Charlotte Rampling) e nei loro discorsi si sentono il dolore ed i dubbi dei genitori di fronte a casi simili.
Ma il film non sceglie mai scene ad effetto, mai la lacrima facile, mai la commozione a tutti i costi e neanche finali consolatori.
Le chiavi di casa è un film semplice, ma unico, prezioso, distante dal cinema inteso come finzione e vicino il più possibile alla realtà.
Dimentichiamoci le polemiche sul Leone d’Oro e andiamo tutti a vedere questo film, godiamoci Gianni e Paolo che fanno il bagno insieme e si coccolano. Cerchiamo di capire quanto Andrea/Paolo cerchi di essere, e sia, normale. E premiamo questo film con il nostro affetto.
Ed è una storia di malattia anche Mar Adendo (Mare Dentro, Alejandro Amenabar, Spagna, 125’) un altro dei grandi film della mostra. È la storia di Ramòn Sampedro, immobilizzato in un letto da 28 anni perché paralizzato dal collo in giù dopo un tuffo. La sua vita gli sembra senza dignità, e vuole farsi aiutare a morire. Ma le leggi spagnole non permettono l’eutanasia: da qui una lunga battaglia legale (e morale), che riuscirà a fargli incontrare gente dalla grande umanità.
Ramòn è una figura speciale: non un uomo depresso e stanco, come si potrebbe immaginare, ma vitale, ironico, solare. Come il Paolo del film di Amelio è lui a consolare gli altri, ad insegnare, ad aiutare. Lo interpreta in maniera magistrale Javier Bardem (già sex symbol e attore feticcio di Bigas Luna, ma anche già paraplegico per Almodovar in Carne Tremula), invecchiato grazie ad un trucco speciale che lo rende quasi irriconoscibile. Prototipo dell’attore “fisico”, qui recita solo con il volto: ma dai suoi occhi luminosi, dal suo sorriso, il sorriso di chi “piange ridendo” traspare un’interpretazione straordinaria.
Amenabar è un regista che ha sempre avuto a che fare con la morte. In Apri gli occhi (il film sembra aprirsi proprio come quello, con una voce femminile ed una sorta di sogno), la morte era il pericolo da scongiurare, un nemico impossibile da combattere, ma il protagonista cercava di beffarla con un artificio tecnologico, con il sogno della vita eterna, di un mondo ideale. In The Others la morte era vicina, difficile da accettare, ma inesorabile. Qui invece è qualcosa a cui si aspira, una liberazione dalle ansie della vita. Non è solo accettata, vissuta con serenità, ma richiesta, attesa.
 È per questo che Mar Adendro è il film della maturità per Amenabar. che si conferma autore in grado di confezionare film ad alto tasso di spettacolarità, ma stavolta anche di poesia. Qui usa una fotografia dai colori brillanti, ralenti e dissolvenze, dolly per le ampie carrellate sui paesaggi, a rappresentare la voglia di volare, di muoversi. Confeziona una sceneggiatura piena di momenti di ironia e sarcasmo (anche nei confronti della Chiesa).
È per questo che Mar Adendro è il film della maturità per Amenabar. che si conferma autore in grado di confezionare film ad alto tasso di spettacolarità, ma stavolta anche di poesia. Qui usa una fotografia dai colori brillanti, ralenti e dissolvenze, dolly per le ampie carrellate sui paesaggi, a rappresentare la voglia di volare, di muoversi. Confeziona una sceneggiatura piena di momenti di ironia e sarcasmo (anche nei confronti della Chiesa).
La scelta formale di Amenabar va in direzione opposta a quella di Amelio: lineare e sobria quella dell’italiano, ricca di enfasi e di momenti mèlo (compresa una scena al suono di Nessundorma), come da tradizione spagnola (Almodovar docet) quella di Amenabar: ma i risultati sono in entrambi i casi splendidi.
Ancora una volta nel cinema di Amenabar la via d’uscita è il sogno. E noi, davanti a Ramon Sampedro, non dobbiamo giudicare, ma solo cercare di capire.
È una storia di sofferenze, e di leggi inadeguate anche il film vincitore del Leone d’Oro: Vera Drake (Il segreto di Vera Drake, Mike Leigh, Gran Bretagna, 125’). Un’altra storia di Segreti e bugie, (come il film che vinse il Leone d’Oro a Venezia nel 1996) ma dette a fin di bene: Vera Drake, signora inglese poco abbiente, ma che vive la sua vita con dignità, aiuta giovani donne in difficoltà. Cioè le aiuta ad abortire piuttosto che mettere al mondo dei figli per farli crescere senza amore, o senza i soldi per mantenerli. Siamo in Inghilterra, negli anni Cinquanta, e l’aborto è un reato penale.
Il film è diviso in tre parti: nei primi venti minuti vediamo la vita normale di Vera, pronta ad aiutare tutti, madre e moglie premurosa, il the delle cinque sempre pronto per gli ospiti. Nella seconda parte, all’improvviso vediamo come Vera aiuti le ragazze ad abortire: dal tono allegro non troppo della prima parte si passa a tanti piccoli drammi quotidiani. Una parte che forse soffre di qualche ripetizione. La terza parte inizia quando i nodi vengono al pettine (non diciamo di più) e la storia entra nel dramma: la vergogna di Vera, il suo riguardo verso i familiari, le ripercussioni sulla vita della famiglia, la sua candida e assoluta buonafede (ripete spesso “aiutavo ragazze in difficoltà” e non percepisce alcun compenso). È qui che il film decolla definitivamente, è qui che viene fuori tutta la bravura della Staunton, strepitosa nella confessione sottovoce al marito, quando quasi non riesce a parlare dalla vergogna: una scena emblematica della sua condizione e della sua moralità. Imelda Staunton che è solo la punta dell’iceberg di un cast perfetto, dall’umanità straordinaria, e diretto magnificamente da Leigh.
Che prende nettamente posizione su un tema controverso come l’aborto, facendo notare l’iniquità di certe leggi di fronte alle esigenze della gente. Ma tiene conto anche dei sentimenti: il suo sguardo verso la protagonista è di assoluta solidarietà e compassione, e tutti noi veniamo portati dalla sua parte. Il segreto di Vera Drake è un film apparentemente semplice, eppure complesso, e perfetto in ogni ingranaggio del meccanismo, o quasi. Quello di Mike Leigh è un cinema dal forte impatto politico e sociale, ma sempre attento ai rapporti umani, colti in ogni minima sfumatura. Ed è sempre un cinema da lotta di classe: i momenti in cui si vede la ragazza ricca che può abortire pagando è illuminante riguardo alle discriminazioni sociali, come è sempre presente la critica alla borghesia, ipocrita nel condannare Vera per i suoi “peccati” (la moglie dell’amico di famiglia).
Finale sorprendente e riuscito, come tutto il film. Leone d’Oro e Coppa Volpi (a Imelda Staunton come migliore attrice) meritatissimi.

Da un film politico, ma anche intimista, passiamo ad un film totalmente intimista: 5×2 (Cinqueperdue, François Ozon, Francia, 90’). Analizzata con arguzia (e furbizia) da Muccino in Italia, in Francia la crisi della coppia è studiata da François Ozon, regista versatile ed eclettico: i momenti salienti della vita di Gilles e Marion che vediamo sono cinque (da qui il titolo) e ci vengono mostrati al contrario: dal divorzio, alla perdita del desiderio, alla nascita di un figlio, al matrimonio, al primo incontro.
Una storia vissuta a ritroso, come già accadeva in Irreversible di Gaspar Noè, film famoso per una scena di stupro lunga nove minuti con la nostra Monica Bellucci. E anche qui all’inizio c’è un quasi stupro, con Marion costretta all’ultimo rapporto con l’ormai ex marito. In Irreversible c’erano dei lunghi piani sequenza, con movimenti di macchina sempre più confusi man mano che la discesa agli inferi si compieva. Qui il montaggio e la regia sono piuttosto classici, eppure come in quel film è straniante vedere le scene sapendo cosa è successo dopo: inizia bene e finisce con un lieto fine, che però è fittizio, perché siamo appena all’inizio della storia. Sapendo come andrà a finire, seguiamo tutto il film con un senso di fatalismo, pensando all’ineluttabilità del destino, ed usciamo dalla sala con un certo amaro in bocca.
A fare da contrappunto a queste Scene da un matrimonio dei nostri tempi, alcune canzoni italiane del passato: giustamente, se Muccino e Bertolucci usavano le canzoni francesi, Ozon usa le nostre, con effetti rètro a volte chic (Paolo Conte) a volte kitsch (Little Tony).
Certo, l’idea è stata già sfruttata, e regia e sceneggiatura sono prive di guizzi. Però 5×2 è un film intelligente, si lascia seguire, e la sua analisi dei mali della coppia risulta riuscita.
Ozon è un regista che ama le donne, quasi quanto le amava Truffaut: dopo aver trasformato in icona la provocante lolita Ludivine Sagner in Gocce d’acqua su pietre roventi e Swimming Pool, dopo aver utilizzato insieme un dream team di star francesi in Otto donne e un mistero, ora valorizza Valeria Bruni Tedeschi, bellezza insolita, mai vista così sensuale e affascinante prima d’ora.
E, inevitabilmente, in questa guerra dei sessi sembra parteggiare per la donna: anche se nessuno è esente da colpe, l’uomo sembra davvero uscire male da questa storia. Rafforzando l’idea che il sesso debole forse ormai è proprio quello maschile…
Un’altra storia intimista, ma di tutt’altro tipo è Bin jip (Three Iron, Kim Ki-duk, Corea, 95’). Anche a Venezia, come a Cannes, la sorpresa arriva dalla Corea. Se sulla Croisette aveva incantato Park Chan-wook con Old Boy, qui è Kim Ki-duk con questo Bin jip. Due film diversissimi, due colpi di genio: lì una storia di vendetta, qui una storia d’amore.
Storia d’amore, sì, ma surreale, sospesa, ironica, e anche un po’ violenta: un ragazzo dallo sguardo spiritato e dai capelli sparati, che sembra uscito da un manga; si sposta in case vuote, mentre i proprietari sono in vacanza o comunque altrove, e le usa, ma senza rubare nulla, anzi facendo il bucato e riparando oggetti. In una delle case incontra la moglie infelice di un uomo violento, che lo seguirà in altre case, fino ad innamorarsene.
Bin jip sorprende perché in pratica è un film “muto”. Non lo è completamente, a dire il vero: i personaggi secondari parlano, sbraitano, si agitano, mentre i due protagonisti non dicono (e non si dicono) una parola in tutto il film, che affrontano con una sorta di calma zen.
Forse perché in un mondo in cui tutti urlano la scelta vincente è il silenzio? O forse perché chi si ama lascia parlare gli sguardi. “Non abbiam bisogno di parole” diceva una canzone di qualche tempo fa. E forse in un’era in cui tutti vogliono apparire a tutti i costi, scomparire resta l’unica soluzione. Infatti il nostro eroe riesce a vivere ovunque senza farsi vedere, inventando stratagemmi a ripetizione. È quasi un supereroe.
E se avete in mente le terribili violenze di Old Boy, troverete una nuova arma letale: la mazza da golf (Three Iron è appunto un tipo di mazza), non usata come bastone, ma per lanciare le palline da golf come proiettili.
Three Iron è un film lieve, con momenti da comiche, con un tono sospeso, che diverte e sorprende ad ogni inquadratura. Il pubblico milanese ha mostrato di gradire: la sala era gremita ad ogni proiezione, la partecipazione è stata simile solo per Vera Drake. Non per niente a questo film è andato il Leone d’Argento, che stavolta ha premiato il prodotto più nuovo e insolito della mostra. Forse alla fine è tutto un sogno. Ma che siano sogni o incubi, il cinema coreano dimostra di saper vedere sempre più nel profondo del nostro inconscio.

Da film più intimi passiamo a film più attuali, politici, legati all’era in cui viviamo. È un segno dei tempi di sicuro (La terra dell’abbondanza, Wim Wenders, Usa, 118’), ambientato nell’America post 11 settembre 2001. L’America vista dell’artista tedesco non è mai quella da cartolina, ma quella dei derelitti, degli emarginati, degli indigenti. Quella degli outsider di Million Dollar Hotel, che viene citato in un paio di scene. È proprio lì vicino, in una missione per i poveri, che va a vivere Lana (un’intensa Michelle Williams), americana, ma cresciuta in Africa e proveniente da Israele. L’assassinio di un arabo che frequentava la mensa la farà ricongiungere a suo zio Paul (John Diehl), che all’inizio del film vediamo occuparsi di sicurezza. Ma poi scopriremo che non lavora per nessuno, ed è un reduce del Vietnam paranoico che cerca di rendersi utile con un compare per scacciare il senso di colpa per non aver evitato l’11 settembre e per esorcizzare i fantasmi del Vietnam.
Ci troviamo nel settembre 2003, a due anni dall’attentato: i due sono le due anime dell’America, o, se vogliamo, del mondo di oggi: Paul, paranoico fino all’ossessione, rappresenta chi cerca la sicurezza fino all’eccesso, e per questo è pronto a calpestare ogni altra cosa, ma finisce per dimostrarsi patetico. Nel personaggio di Lana ci sono i valori cristiani, quelli della solidarietà e della fratellanza. Secondo Wenders queste due anime sono sempre più in conflitto, e la discrepanza tra quello che l’America è oggi ed i valori su cui è fondata è enorme. La “terra dell’abbondanza”, la terra promessa, come la consideravano tante persone, è un paese inospitale, diffidente, e pieno di povertà, effettiva, ma anche morale.
L’idea di partenza è ottima, e i momenti di poesia nel film non mancano, ma Wenders si dimostra ancora una volta incapace di tessere i fili del racconto, che alla lunga diventa ripetitivo e a tratti noioso.
La fotografia, sui toni freddi del verde e dell’azzurro, è di gran classe; così come la colonna sonora, con quel rock, che ,come ha ammesso Wenders, gli ha salvato la vita: qui si sentono Bowie, Travis e Leonard Cohen. Un film imperfetto, ma carico di fascino e di significati, effettivamente il migliore tra gli ultimi di Wenders.
Il cinema ormai sta dimostrando di guardare in faccia la realtà anche per quel che riguarda l’America post undici settembre: ricordate come dopo l’attentato ogni film che aveva a che fare con il terrorismo veniva rimandato? Ora invece quella tragedia è al centro di molti film. Ovviamente Fahrenheit 9/11 e 11’09″01, due film espressamente dedicati a quell’evento. Ma anche con film come la 25a Ora e The Terminal, dove si mostra finalmente New York, ferita e dolente nel primo, impaurita e chiusa nel secondo.
Wenders, lontano dall’Europa, cerca ancora di guardare la realtà. Ma i suoi angeli ci sono sempre, solo che sono senza ali, e umani: sono i preti, i volontari delle missioni, chi lotta per la pace. Solo che non sempre bastano a salvarci.

Ci vorrebbe un angelo, e forse c’è, per salvare le protagoniste di Terra Promessa (Promised Land, Amos Gitai, Israele, 90’) un altro film calato profondamente nel mondo attuale. Alcune ragazze, provenienti da paesi dell’ex blocco sovietico, arrivano nel deserto del Sinai, luogo mitico per i suoi significati religiosi. Ma per loro sarà l’anticamera dell’inferno e nient’altro. Non sappiamo come ci siano arrivate, probabilmente allettate da false promesse di successo o benessere. La terra promessa per il popolo ebraico era quella destinata a loro da Yahweh, il loro dio, dopo le loro sofferenze e peregrinazioni. Per queste ragazze è forse il sogno di una vita migliore. Invece si rivela essere solo il nome di un night club dove vengono lavate con una pompa come in un lager e costrette a prostituirsi contro la loro volontà. Una turista straniera (Rosamund Pike, già vista nell’ultimo 007) proverà a salvarle. Forse sarà lei il loro angelo.
Il film dell’israeliano Amos Gitai è un atto d’accusa forte e coraggioso: i casi di prostituzione e tratta delle bianche in Israele sono diffusissimi. Girato in digitale con macchina a mano e luci naturali, quasi in stile Dogma, il film ha lo stile del documentario, del film verità. Comincia con un ritmo regolare e più pacato, poi nel finale il montaggio si fa più serrato, con flashback e qualche inserto onirico. Che però finiscono per confondere troppo le idee allo spettatore, e rendere meno intelligibile lo svolgersi degli eventi.
Promised Land è comunque un film importante: e se la nostra protagonista se la cava, quante altre ragazze sono ancora prigioniere nella “terra promessa”?
Usciamo dai film in concorso, e facciamo una breve digressione verso Locarno (la rassegna dei film del festival svizzero è abbinata a quella veneziana) per un film che nello spirito e nella forma si avvicina molto a quello di Gitai. È Private (Saverio Costanzo, Italia, 90’), vincitore del Pardo D’Oro. È la storia di una famiglia palestinese che all’improvviso si trova la casa occupata da un commando dell’esercito israeliano. La casa verrà divisa in tre parti: il salotto resterà alla famiglia, il piano superiore ai militari, una parte resterà in comune, quando i militari daranno il permesso.
La scelta di Costanzo è semplice, ma geniale: scegliendo di mostrare una casa occupata come metafora di un territorio occupato ingiustamente, fa entrare ognuno di noi nei panni dei palestinesi. Cosa proveremmo se casa nostra fosse invasa senza spiegazioni da intrusi? Dovremmo andarcene? Ma perché se è casa nostra? Con questo Private i Palestinesi siamo noi: impossibile non entrare nelle loro vite, non vivere il loro dramma.
Il film, come si è detto, stilizza e semplifica ogni aspetto dei conflitti, e le varie anime di un popolo: c’è chi (il padre) cerca comunque di far rispettare le regole, di resistere con dignità, di far continuare la vita. C’è chi pensa alla rivolta (il figlio maggiore, il più impulsivo) e chi è incuriosito dal nemico (la figlia) e cerca di rendere meno dura la guerra al fratellino raccontandogli storie, un po’ come faceva benigni ne La vita è bella.
Costanzo gira con mezzi di fortuna, un po’ alla Blair Witch Project per intenderci: immagini sgranate, luci naturali e camera a mano. Ma riesce a creare la suspence, grazie ad una bomba sotterrata in una serra, ad una ragazza che scruta i soldati chiusa in un armadio, come faceva Kyle McLachlan in Velluto Blu. Private è un film coraggioso, onesto, necessario, che ci riporta al cinema italiano di un tempo.

Difficile comunque fare un bilancio sullo stato di salute del cinema italiano. Gradi film quelli di Amelio e del giovane Costanzo, non sono arrivati a Milano i film Lavorare con lentezza di Guido Chiesa e Ovunque sei di Michele Placido. È arrivato invece il poco riuscito (Carlo Mazzacurati, Italia, 105’), presentato fuori concorso. Un film che prometteva bene: regista di classe, il bravo Mazzacurati, due tra i migliori attori nazionali degli ultimi anni, l’idolo Accorsi (uno dei pochi attori in Italia a garantire incassi) e la rivelazione dell’ultimo anno, Maya Sansa, il sorriso più irresistibile del cinema italiano. E poi la base letteraria, il libro Una relazione di Carlo Cassola.
Giovanni è un bancario sposato con figlio che incontra una ragazza amata un solo giorno in gioventù: è Maria, ragazza che ha commesso alcuni errori in passato e vorrebbe dimenticarli. Tra i due scoppia la passione, prima fatta di amplessi furtivi e selvaggi, che pian piano lasciano posto ad un sentimento intenso, un amore impossibile.
Detta così, la storia ricorda quella del recente Non ti muovere, anche se qui ci troviamo nel 1936 e comportamenti ed atteggiamenti sono smorzati, attenuati. Ma Mazzacurati sceglie di non mostrare mai la vita familiare di Giovanni, tranne nella scena in cui Maria lo vede con moglie e figlio, proprio come accadeva nel film di Castellitto.
Nel film ci sono momenti di sensualità ed altri di poesia, come la scena della giostra: Maria e Giovanni si avvicinano per poi staccarsi, proprio come accade a loro nella vita. Una vita ed un amore precari, come sottolineano le continue scene di treni che vanno e vengono.
Gli ingredienti sembrerebbero esserci tutti, ma il film non decolla mai: tutto sembra essere troppo trattenuto, calligrafico, elegante. Forse per rispetto verso quei tempi, così diversi da quelli attuali di Non ti muovere. Ma anche la sceneggiatura è priva di guizzi, i dialoghi sono piatti, e piatte sono anche le psicologie dei personaggi, mai in evoluzione. Mazzacurati sembra essere più a suo agio con i piccoli drammi dei nostri giorni (Il toro, Vesna va veloce) che con una storia letteraria e distante. Davvero un peccato.
Il film di Mazzacurati, che doveva essere in concorso, è stato invece uno dei tanti film fuori concorso della mostra. Che hanno fatto spesso la parte del leone, a Venezia come a Milano. Tra questi due thriller americani. Il primo, The Manchurian candidate (Il candidato della Manchurian, Jonathan Demme, Usa, 132’) pur nella sua struttura commerciale, ha numerosi agganci con la realtà. In Fahrenheit 9/11 Michael Moore ci aveva mostrato come il presidente degli Stati Uniti sia legato da molteplici affari a grosse compagnie internazionali, che lo finanziano, legandolo a loro. Ma un presidente Usa ha comunque un grande potere. Perché non asservirlo completamente a sé, cercando di controllarlo direttamente? Questo il paradosso, o forse la metafora di quello che già accade nel sistema politico degli Stati Uniti.
Ben Marco è un ufficiale che ha combattuto nella Guerra del Golfo negli anni Novanta. Un suo soldato, Shaw, decorato come eroe di guerra, è candidato alla vicepresidenza degli Stati Uniti, grazie all’operato dell’ambiziosa madre. Ma Shaw non si ricorda esattamente come andarono le cose. E Marco ha numerosi incubi. Non sveliamo il meccanismo, anche se nel film il gioco viene svelato piuttosto presto.
 The Manchurian candidate è un film interessante su cosa può succedere in America oggi: se le dichiarazioni su un’America più forte e baluardo della libertà sono spinte all’eccesso, ma molto verosimili, il messaggio sull’informazione, su verità e montatura, anche questo portato al paradosso, sono più che mai attuali.
The Manchurian candidate è un film interessante su cosa può succedere in America oggi: se le dichiarazioni su un’America più forte e baluardo della libertà sono spinte all’eccesso, ma molto verosimili, il messaggio sull’informazione, su verità e montatura, anche questo portato al paradosso, sono più che mai attuali.
The Manchurian candidate è un film che però risulta macchinoso nelle sequenze delle indagini, mentre nei momenti più visionari si rivede il talento di Jonathan Demme, quello che aveva evocato i nostri incubi peggiori ne Il silenzio degli innocenti. Questo suo nuovo film si può definire un buon prodotto di genere, leggermente superiore alla media, visto che Demme è un autore: i livelli alti dei suoi capolavori sono però lontani. Il finale con suspence richiama l’assassinio in pubblico de L’uomo che sapeva troppo di Hitchcock o, se vogliamo rimanere in ambiti presidenziali, quello de La zona morta di Cronenberg o del recente televisivo 24. Ecco, forse il problema è che certi temi e certe scene risultano già troppo visti e sentiti. E Demme osa, ma non abbastanza per dare un tocco in più al film.
E poi il problema di questi film è quello di farsi sorpassare dalla realtà. Guardando Fahrenheit 9/11 viene da pensare: ma quale giallista poteva scrivere una trama più intricata? Sì. La realtà è davvero più inquietante della finzione.
Più slegato dalla realtà, ma comunque riuscito e inquietante, è Collateral (Michael Mann, Usa, 119’), che ha scioccato perché è la prima volta (o quasi) di Tom Cruise “cattivo”. In Collateral è Vincent, “vestito per uccidere” in un elegante completo grigio metallico, e con un’inedita capigliatura brizzolata, che deve uccidere cinque persone in una sera, e per farlo sequestra Max con il suo taxi, costringendolo a seguirlo nelle sue imprese.
L’ottimo Michael Mann ritorna alle atmosfere notturne ed urbane di Heat — La sfida, dove Al Pacino e Bob De Niro giocavano un’emozionante partita a due. Qui la partita è a tre, perché oltre a Vincent e Max c’è anche la polizia.
Mann dimostra di essersi aggiornato e di aver imparato la lezione da Tarantino: per i dialoghi, che sono brillanti, ironici, a volte surreali come nei suoi film, ma anche per l’amoralità che pervade i film dell’autore “pulp” per eccellenza, e si sente anche qui. Vincent infatti è tremendamente “cool”: colto, sagace, sa sempre cosa dire e cosa fare in ogni situazione. Al pubblico sta simpatico e si segue il film sperando che porti a termine il suo lavoro. Tranne quando capiamo chi sarà l’ultima vittima… Ci sta simpatico come ci stava simpatico un altro Vincent, Vega (il Travolta di Pulp Fiction) e la sua uscita di scena ci dispiaceva.
Ma Vincent è anche una sorta di Terminator umano, per come mette la sua missione davanti a tutto, per la sua freddezza, per il suo non fermarsi davanti a niente. Ed è notevole anche il gioco psicologico che lo lega a Max, che rivela a tratti di aver imparato la sua lezione, di avere qualcosa in comune con lui.
Al film non manca niente: ironia, battute perfette, ritmo, colpi di scena, grandi attori anche nei ruoli di comprimari. E non manca nemmeno una strepitosa forma visiva: girato in digitale (a volte si nota, ma i risultati sono mirabili) sfruttando le luci naturali di Los Angeles, Collateral unisce il blu della notte, in tutte le sue tonalità, ai colori delle luci al neon, a volte in primo piano, a volte sfocate, a volte riflesse su vetri e superfici metalliche con affascinanti riverberi. Los Angeles, ripresa anche dall’alto, è una vera e propria protagonista del film.
Nel sottofinale c’è anche un attimo in cui rivediamo La finestra sul cortile di Hithcock, e la paura di osservare da lontano il pericolo avvicinarsi a qualcuno, senza poter fare niente.
 Ed ha i capelli bianchi anche John Travolta in A love song for Bobby Long (Una canzone d’amore per Bobby Long, Shainee Gabel, Usa, 119’) alla ricerca di un ruolo diverso dal villain grottesco che ha finito per interpretare all’infinito dopo Pulp Fiction.
Ed ha i capelli bianchi anche John Travolta in A love song for Bobby Long (Una canzone d’amore per Bobby Long, Shainee Gabel, Usa, 119’) alla ricerca di un ruolo diverso dal villain grottesco che ha finito per interpretare all’infinito dopo Pulp Fiction.
In questo film, presentato a Venezia nella sezione Orizzonti, è Bobby Long, un ex professore di letteratura alcolizzato. Vive con un amico, e all’improvviso nella loro vita entra Pursy (Scarlett Johansson), figlia delle coinquilina, una cantante morta, che ha ereditato da lei la casa.
L’incontro tra Bobby e Pursy segue lo schema un po’ prevedibile diffidenza-rottura-riavvicinamento, ma il film è sincero, ben scritto e interpretato, non indulge nelle scene pietose tipiche di questi film (vedi Via da Las Vegas), non tenta improbabili love story e commuove senza trucchi di sorta.
La Johansson di Lost in translation disegna un altro personaggio di giovane donna in cerca di certezze, e Travolta dopo Pulp Fiction azzecca con sensibilità il ruolo che può valere una carriera. Ma è riuscita tutta l’atmosfera del film, che odora di alcol, blues e letteratura, come in una sorta di Attimo fuggente decadente e da sbornia, in una New Orleans rifugio di perdenti, ma con l’anima.
Una grande colonna sonora, stavolta a base di rock (si sentono, tra gli altri, Bob Dylan, Jefferson Airplaine, Patti Smith) è la cosa migliore di A home at the end of the world (Una casa alla fine del mondo, Michael Mayer, Usa, 95’), storia che segue dagli anni Sessanta agli Ottanta due ragazzi, attraverso le prime esperienze omosessuali, il trasferimento a New York, l’amore per una ragazza di uno dei due, la sessualità più selvaggia dell’altro, la nascita di un figlio, lo spettro dell’Aids. La ricostruzione dei tempi passati è fatta bene, ma già vista, e la storia troppo debole per lasciare il segno. La malattia viene poi solo accennata nel finale: si sceglie di non mostrare drammi, ma il film così resta incompiuto, e non si capisce bene dove voglia andare a parare. Il film, che comunque si lascia seguire, ha fatto notizia più per un nudo integrale di Colin Farrell, poi tagliato perché distraeva il pubblico, che per il suo valore artistico. Farrell, tra l’altro, nella parte di un ragazzo timido e impacciato, è palesemente fuori ruolo, come non convince nel ruolo di una ragazza punk con il cuore d’oro Robin Wright Penn. La pellicola arriva dalla sezione Mezzanotte.
Dulcis in fundo, il film di un grande maestro, altro evento fuori concorso, che uscirà di sicuro nelle sale presto. Tra tanti thriller all’americana, adrenalinici ed eccessivi, fa un certo effetto vedere come Claude Chabrol mette in scena le sue storie di delitti e misteri con la più assoluta calma e freddezza, con l’occhio di un osservatore distaccato e divertito. Ne La demoiselle d’honneur (La damigella d’onore, Claude Chabrol, Francia, 110’) vediamo una famiglia alle prese con un matrimonio. Per la prima mezz’ora viene evocata una misteriosa figura, quella della damigella della sposa. Che finalmente vediamo al matrimonio: si legherà al fratello della sposa, sconvolgendogli la vita. Lui ne è immediatamente attratto, forse perché ha il sorriso arcaico di una statua che tiene sempre con sé, quel sorriso arcaico che aveva la Catherine di Jules et Jim. La ragazza ricambia il suo amore, ma sembra chiedergli delle prove d’amore sempre più impegnative…

Chabrol dopo Virginie Ledoyen e Anna Mouglalis lancia un nuovo sex symbol, la morbida bellezza di Laura Smet, occhi di ghiaccio e corpo da passione. E continua a fare il suo cinema, dove non condanna mai nessuno, ma osserva l’omicidio non come un peccato capitale, ma come uno dei comportamenti naturali dell’uomo. Il delitto in Chabrol nasce sempre nella borghesia annoiata e decadente, e sempre dalla famiglia o da persone vicine e insospettabili, come in Il buio nella mente, in Grazie per la cioccolata, o il recente I fiori del male. In questo film si sentono anche echi delle teorie di Nietzsche sul superuomo, secondo le quali chi uccide è al di sopra della morale, libero e forte. Teorie che riecheggiavano anche in Nodo alla gola di Hitchcock… Allora è vero che Chabrol è il suo erede? Forse sì. Ad ogni modo, anche lui è un vecchio leone, sornione ed indomabile.











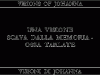











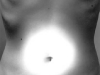













I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was
Di Chantal | 22 Settembre 2014, 16:38curious what all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like
yours would cost a pretty penny? I’m not very web smart
so I’m not 100% certain. Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
Many thanks