Quando si ebbe la notizia del fatto che Abbas Kiarostami, Ken Loach ed Ermanno Olmi avrebbero girato un film insieme, a episodi, molti rimasero colpiti, credendo che l’unico legame tra i tre cineasti fosse in fondo la propria appartenenza all’alveo del cinema d’autore internazionalmente riconosciuto.

Tre personalità differenti, tre diversi modi di intendere la società, tre idee politiche poco conciliabili, persino tre sguardi sulla religione assai stridenti (se si pensa al cattolico Olmi e al marxista ateo Ken Loach). Le perplessità, tuttavia, appartenevano a coloro che non conoscono a fondo il cinema dei tre registi, un po’ per la ridotta distribuzione italiana dei film di uno di loro (Kiraostami), un po’ per la scarsa dimestichezza con il primo cinema di Olmi, un po’ per la comune credenza che l’opera di Loach cominci da Riff Raff, mentre essa è ormai ricca di oltre quarant’anni di storia — si veda in tal senso il mio saggio di apertura dello scorso catalogo.
L’idea di premiare Ken Loach nel 2004 era dovuta proprio all’ascendenza neorealista e all’attenzione — inapparente — verso il processo di scrittura moderna che avvicina il cineasta britannico all’opera di Amidei, senza contare naturalmente la straordinaria importanza della carriera loachana al di là di qualsiasi valutazione interpretativa. Tickets, uscito quest’anno e largamente sottovalutato dalla critica, esprime perciò una continuità tra questi cineasti che non può essere limitata soltanto al fatto produttivo o simpatetico, tant’è vero che quest’anno il Premio all’Opera viene attribuito proprio agli altri due compagni di strada del vincitore 2004. Quanto stiamo affermando, in buona sostanza, è che questo premio risponde a un vero e proprio progetto di cinema incarnano dai tre autori, sia pure attraverso prospettive diverse e talvolta collidenti,. E che Kiarostami e Olmi, come dimostra questo film collettivo tutt’altro che casuale, condividono un “mestiere delle armi” cinematografico di cui, nelle prossime righe, proveremo a saggiare le caratteristiche.
Abbas Kiarostami: il cinema come ritorno al punto di partenza
 Tra i suoi innumerevoli meriti, Abbas Kiarostami ha anche quello di avere guidato una vera e propria “nouvelle vague” del cinema iraniano. Senza la sua stella polare non avremmo certamente avuto la possibilità di conoscere le opere di Moshen e Samira Makhmalbaf, Jafar Panahi, Babak Payami, Bahman Ghobadi, Abolfazl Salili, Darius Mehrjui (esponente in verità più anziano del gruppo), e molti altri emersi nell’epoca post-khomeinista. Tutti quanti sembrano condividere le novità estetiche apportate da Kiarostami, oltre che una forma di collaborazione che sconfina nel “dono” creativo. I soggetti passano da uno all’altro, le famiglie vengono coinvolte nei progetti, il denaro per realizzare i film viene prestato e restituito, secondo un’etica di gruppo che fa della nuova onda iraniana l’unica scuola poetica degna di questo nome e del passato cui si riferisce (il neorealismo italiano, soprattutto) nel cinema contemporaneo. Certo, qualcuno ha voluto individuare negli ultimi anni una certa involuzione del cinema iraniano, ancorato a schemi fabulatori sempre riconoscibili, e tuttavia il crinale tra ripetizione e rimodulazione di un mondo narrativo senza precedenti è davvero sottile.
Tra i suoi innumerevoli meriti, Abbas Kiarostami ha anche quello di avere guidato una vera e propria “nouvelle vague” del cinema iraniano. Senza la sua stella polare non avremmo certamente avuto la possibilità di conoscere le opere di Moshen e Samira Makhmalbaf, Jafar Panahi, Babak Payami, Bahman Ghobadi, Abolfazl Salili, Darius Mehrjui (esponente in verità più anziano del gruppo), e molti altri emersi nell’epoca post-khomeinista. Tutti quanti sembrano condividere le novità estetiche apportate da Kiarostami, oltre che una forma di collaborazione che sconfina nel “dono” creativo. I soggetti passano da uno all’altro, le famiglie vengono coinvolte nei progetti, il denaro per realizzare i film viene prestato e restituito, secondo un’etica di gruppo che fa della nuova onda iraniana l’unica scuola poetica degna di questo nome e del passato cui si riferisce (il neorealismo italiano, soprattutto) nel cinema contemporaneo. Certo, qualcuno ha voluto individuare negli ultimi anni una certa involuzione del cinema iraniano, ancorato a schemi fabulatori sempre riconoscibili, e tuttavia il crinale tra ripetizione e rimodulazione di un mondo narrativo senza precedenti è davvero sottile.
Per quanto riguarda Abbas Kiarostami, invece, il problema della stagnazione artistica non è certo all’ordine del giorno. Se si pensa all’ultimo trittico di opere — Ten, Five e Ten on Ten — ci si accorge di come il cineasta iraniano abbia scelto una volta di più di ricollocare radicalmente il proprio cinema, anticipando ogni cedevolezza alle retoriche d’autore e spiazzando nuovamente gli spettatori. Si può certo affermare che Kiraostami non è mai dove si pensa di trovarlo. Le sue idee viaggiano più veloci, forse perché la sua poetica è quanto di più originale il cinema internazionale abbia di recente prodotto.
Andiamo con ordine. Kiarostami è nato a Teheran nel 1940, e si è laureato in pittura nella sua stessa città. Appassionato di fotografia, sviluppa la passione per il “quadro” fisso che diverrà poi il suo marchio anche quando si avvicina al mezzo cinematografico. È grafico e autore di pubblicità, attraverso le quali guadagna il sapere tecnico necessario alla realizzazione dei film. Già dal 1969 ha l’idea di edificare un certo di produzione nell’istituto Kanun, dove in seguito molti dei cineasti che abbiamo nominato trovano modo di sfruttare le proprie capacità. È dal 1970 che Kiarostami è attivo alla regia. Come per Ken Loach, anch’egli viene conosciuto all’estero relativamente tardi: il suo Dov’è la casa del mio amico? (1987) giunge ai festival dopo diciassette anni di corti e lungometraggi realizzati e visti praticamente solo in patria. Non stiamo parlando di poca cosa: sedici corti e tre lunghi (i quali sono, per completezza: Il viaggiatore, 1974; Il rapporto, 1977; Gli alunni della prima classe, 1984; i titoli vanno intesi come traduzioni dell’iraniano, e sono stati utilizzati per le rare proiezioni retrospettive italiane dedicate al regista). È però il Pardo di Bronzo, vinto nel 1989 al festival di Locarno, a permetterne la conoscenza nel mercato occidentale.

Dov’è la casa del mio amico? È un film esemplare per comprendere il cinema di Kiarostami. Esso narra infatti la storia del piccolo Ahmad, che scopre di avere infilato per errore nella propria cartella il quaderno di un compagno di classe. Il bambino decide di riportarlo all’amico per evitargli una brutta punizione, ma non sa dove abiti. Comincia così un lungo viaggio in quartieri e luoghi sconosciuti alla ricerca della casa del suo compagno. Il film è costruito attraverso una “questua” infinita, caratteristica essenziale di questi film: un personaggio cerca qualcosa, un elemento casuale o un gruppo di persone gliela nega, e il protagonista intraprende un percorso — il più delle volte concreto, spaziale — allo scopo di aggirare il divieto. Le sequenze sono lunghissime, il che ha fatto parlare della nouvelle vague iraniana come di un “cinema della lentezza” (e sortito le ironie degli anti-cinefili); la figura più sfruttata è quella del piano-sequenza, il dialogo e l’utilizzo di attori non professionisti, specie bambini, accrescono la riconoscibilità delle opere.
Il successivo I compiti a casa (1989) sembra una nota a margine del precedente: si tratta di un documentario realizzato con le interviste ai bambini di una scuola iraniana. L’elemento educativo, lo sguardo dell’infanzia interessano a Kiarostami in quanto permettono un punto di vista inedito sul mondo. Il bambino, come nel neorealismo, è portatore di uno sguardo ottico e sonoro puro, come intuito felicemente da filosofo Gilles Deleuze a proposito del cinema italiano del dopoguerra.
Close Up (1990), premiato a Riminicinema nel 1990, radicalizza la riflessione di Kiarostami sul linguaggio cinematografico. La trama, in questo senso, chiarisce tutto: Sabzian, un poveraccio appassionato di cinema, decide di fingersi il regista Makhmalbaf. Con questo stratagemma, riesce quasi a farsi produrre un film da una famiglia abbiente. Una volta scoperto, l’uomo finisce in tribunale, dove si pente e viene perdonato. Insieme al vero Makhmalbaf, infine, si reca dalla famiglia ingannata per chiedere scusa. Non è tutto: il fatto narrato è accaduto veramente. Infatti assistiamo al processo ripreso dalla mdp di Kiarostami. Solo in seguito, il regista ha chiesto a Sabzian, il vero protagonista della truffa, di interpretare se stesso nella ricostruzione fittizia dei fatti. In questo film c’è praticamente l’intera poetica kiarostamiana: l’apparente gioco di specchi e citazioni tra realtà e finzione (ovvero il dialogo intertestuale tra Kiarostami e Makhmalbaf, la continua allusione al cinema come mezzo e all’autore come centro di produzione creativa e come simbolo di posizione sociale) viene servito allo spettatore attraverso una spontaneità e una naturalezza innegabili. Sembra interessare al regista assai più l’avventura umana spogliata di qualsiasi secondo grado piuttosto che la gara cinefila e la grana metacinematografica. Eppure, la riflessione sull’arte è davvero vertiginosa. Close Up si interroga sul concetto di fare cinema, sulle conseguenze sociali che questo mestiere determina, sulle responsabilità del cineasta. Come scrive Eugenio Premuda: “L’equivoco che intrappola Sabzian è forse proprio questo: recita la parte di un regista, cercando in questa parte un ruolo più affine alla sua essenza, un ruolo da recitare nella recita quotidiana del consorzio umano; l’essenza di Sabzian sembra allora essere quella dell’attore e non più del regista”.

Non è un caso che uno dei registi più influenzati da Kiarostami, Nanni Moretti (plateale la matrice kiarostamiana di Caro diario), abbia girato un cortometraggio intitolato La sera della prima di “Close Up” (1996), piccola cronaca della proiezione del film presso il cinema Sacher di Roma, ideata come omaggio e prosecuzione della myse en abyme del regista iraniano.
Il viaggio dentro il cinema prosegue con E la vita continua (1992), dove si racconta l’Iran sconvolto dal terribile terremoto del 1990. Il paesaggio è annientato, la situazione è neo-neorealista (un nuovo azzeramento dello spazio percettivo, simile e forse peggiore di quello causato dai bombardamenti, costringe e reinventare lo sguardo sulle cose). Un regista, in compagnia del figlioletto, si reca in automobile nel villaggio di Potché, alla ricerca del protagonista del suo film Dov’è la casa del mio amico?. Ancora una forma di autoreferenzialità che viene — al contrario di quanto si immagina — proiettata sull’esterno. L’alter ego di Kiarostami, il regista in cerca dei suoi attori forse scomparsi, è testimone vivente del disastro, e attraverso la sua probabile perdita dice meglio di qualsiasi racconto di finzione lo smarrimento e il dolore dell’annullamento.
Il viaggio attraverso macerie, cumuli di stracci, tendopoli e luoghi impervi è davvero accecante: la camera-car diventa figura centrale di questo universo, che entra dal finestrino con casualità e innocenza,. Intervallato solo da alcune inquadrature in campo totale dove la macchina del protagonista si inerpica sempre più lontano, il racconto ha un andamento rapsodico e rispettoso della durata, della fatica, della frantumazione determinata dalla tragedia. La messa in scena è qui completamente compromessa col dato documentario, la moralità del cinema viene messa a prova nell’atto stesso del suo farsi. In uno dei finali più commoventi della recente storia del cinema, il ragazzo non viene effettivamente ritrovato, anche se forse appare in lontananza, un po’ controluce, con la macchina da presa lontanissima che abbraccia il quadro accompagnato dalla musica di Vivaldi, senza spiegare di più. Il finale aperto è per Kiarostami una costante. Egli spiega, infatti: “Il viaggio è un elemento costitutivo della nostra cultura ed è legato al misticismo. Per noi non è importante la meta che si vuole raggiungere, ma il percorso che si deve compiere”. In questa ottica va letto l’intero film E la vita continua, visto che, come bene spiega Pier Paolo Loffreda: “la ricerca è inesauribile, conosce soste, ripensamenti, nuovi tentativi, slanci, e il mancato raggiungimento dell’obiettivo preposto produce un disorientamento fecondo di possibilità”.
Il successivo Sotto gli ulivi (1994) vince il Premio Rossellini (non a caso) al 47° Festival di Cannes e il premio per il miglior film al Bergamo Film Meeting. Stavolta si racconta di un villaggio del nord Iran, colpito duramente dal terremoto, dove giunge una troupe per realizzare un film intitolato E la vita continua. Un muratore è chiamato a recitare la parte di un ragazzo in procinto di sposare la donna amata. Caso vuole che l’attrice sia la donna che l’operaio veramente ama: l’uomo cerca così di far coincidere le riprese e la vita reale, corteggiando insistentemente la ragazza.
Inutile commentare il grado di raffinatezza compositiva raggiunto qui da Kiarostami, che sembra tornare ossessivamente al suo cinema per dare continuamente un seguito al fuori set. Quel che sconvolge è — oltre alla già citata sensazione di autenticità emanata dalle opere —, è il riappropriarsi infinito del mezzo cinematografico attraverso la realtà. Come a dire, portando alle estreme conseguenze il gesto neorealista: il cinema è a tutti gli effetti la realtà, immerso in essa e da essa formato, tanto che il “film” è di per sé un paniere di possibili storie. Non c’è in verità un profilmico vero e proprio o un “al di qua” della finzione, poiché, grazie all’effetto-domino del film successivo, ogni dimensione segreta della finzione viene illuminata e resa evidente.

Il mondo occidentale è finalmente sensibile al cinema di Kiarostami, come dimostra un lungo articolo che Peter Handke gli dedica in occasione dell’uscita di Sotto gli ulivi a Berlino. E Alberto Pezzotta scrive acutamente: “Sotto gli ulivi è uno studio sul fuori campo, la soggettiva e la voce off: spesso non si vede chi parla (neanche una mano un altro indizio), ma se ne sente solo la voce. Lo spettatore, in questo modo, più che introiettato nell’occhio della cinepresa, è sbilanciato, estroflesso, buttato nella realtà di questa remota regione iraniana terremotata”. Il piano fisso e il fuori campo insistono nel cinema di Kiarostami come uniche “parole” possibili per il rispetto della realtà. Inoltre, nel film i più esperti sono in grado di riconoscere con sollievo il bambino protagonista di Dov’è la casa del mio amico?, il che ci dice contemporaneamente (ma Kiarostami non lo esplicita in alcun modo, moltiplicando questo cinema dell’ambiguità e della chiarezza insieme): 1) il ragazzo è vivo e continua persino a fare l’attore 2) se Sotto gli ulivi ci parla del set di E la vita continua, allora ciò significa che quel bambino era presente nel film, e che quel ragazzino quasi invisibile in fondo all’inquadratura era proprio lui.
Vertigini, una volta di più; sensazione di non riuscire più a riprendere le fila di questo universo pirandelliano e intimamente rosselliniano (del Rossellini post-neorealista, però, quello di Stromboli, Francesco, Viaggio in Italia e soprattutto Siamo donne,dove tutti gli episodi sono interpretati da attrici nella parte di se stesse e uno in particolare, quello con Ingrid Bergman, diretto da Rossellini, assume i connotati di un esperimento linguistico tra l’home movie e il film di finzione).
Il sapore della ciliegia (1997) è a tutt’oggi il più importante successo di Kiarostami, Palma d’Oro al festival di Cannes dello stesso anno. È la storia del signor Badii, che se ne va in giro sulla sua macchina bianca in cerca di qualcuno che lo aiuti a suicidarsi. Meglio: a coprire di terra la tomba che si è scavato o a riportarlo a casa nell’eventualità di un ripensamento. L’uomo incontra molte persone, tra cui un seminarista afgano e un soldato curdo, che si rifiutano di aiutarlo. Un vecchietto, invece, pur avendogli elencato tutte le cose belle della vita (il sapore delle ciliegie, per esempio), alla fine decide di aiutarlo. Alla fine, Badii forse non si suiciderà.
“Forse” è termine doveroso visto il dubbio sul finale del film. Kiarostami, infatti, ne ha girati due. In uno, quello distribuito in Europa, nel momento finale vediamo improvvisamente la troupe al lavoro, e il protagonista svelato nel ruolo di attore. L’arte si ritrae di fronte alla morte? Forse, ma c’è anche la possibilità che Kiarostami intenda che il cinema stesso si rechi volontariamente verso la fine in attesa di un aldilà garantito dalle nuove tecnologie. In fondo, questa sequenza è girata in video digitale, lo stesso cui Kiarostami consacra Ten. Il resto del film riporta al centro della rappresentazione le riprese in camera car e l’ostinato fuori campo in cui rimane il protagonista mentre dialoga con l’interlocutore, un metodo che il regista utilizza in favore dello spettatore, chiamato così “sull’abisso” dell’inquadratura a interagire con i parlanti.

Ne Il vento ci porterà via (1997), un gruppo di viaggiatori arriva in un piccolo paese per filmare la morte di un’anziana all’insaputa degli abitanti. Presto, però, l’ozio coglie i realizzatori e altri eventi distraggono il protagonista con macchina da presa. Si tratta di una variazione, meno importante delle altre, sul cinema di Kiarostami, anche se una sequenza è da antologia: il viaggio reiterato di uno dei personaggi forestieri sulla collina per trovare “campo” al suo telefono cellulare, ironica constatazione dell’impossibilità del dialogo tra modernità e ruralità in Iran (“il film è una generalizzata indagine sul disorientamento”, secondo Marco Dalla Gassa).
In effetti, è difficile soffermarsi sul valore simbolico che molte delle storie narrate hanno per l’Iran. Ci è difficile attingere alle metafore sociali che comunque questi film contengono, pur riconoscendo alcune figure piuttosto evidenti. Kiarostami, per solito, ama depositare i ragionamenti più esteriori nelle sceneggiature scritte per altri, tra cui ricordiamo almeno Il palloncino bianco (1995) dell’ex assistente Jafar Panahi, e Oro rosso (2004), vicenda tragicomica di un reduce di guerra obeso e stolto che attraversa tutta Teheran in motorino finendo nei guai, girato anch’esso da Panahi.
Più tardi, nel marzo 2000 Abbas Kiarostami riceve un fax dal Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD), che gli chiede di girare un documentario sulla sorte degli orfani dell’Uganda, che a causa della guerra civile prima, dell’Aids poi ammontano ad oltre 1.600.000. Il regista iraniano accetta e soggiorna a lungo nel paese africano. Il risultato è questo A.B.C. Africa (2002) che ottiene un grande successo a Cannes. A.B.C. Africa evidenzia una grande tensione morale. Il regista iraniano qui incontra in qualche modo il documentario puro e agisce per paradosso, ovvero tanto i suoi film narrativi sconfinano nel “non fiction” quanto A.B.C. Africa è scritto e attentamente preparato: basti vedere l’impressionante sequenza della stanza d’ospedale dove vengono assistiti i bambini infettati dall’Hiv. Sequenza apparentemente casuale — sembra quasi sia frutto di una repentina scoperta da parte della troupe — in realtà preparata da un Kiarostami che per l’occasione si è posto anche davanti alla m.d.p. Quella ugandese è una terra allo stremo, non differente dall’Iran terremotato, un luogo dove la morte è di casa e dove anche coloro che si prodigano per aiutare la popolazione sono al contempo tra i maggiori responsabili della diffusione del morbo. Tutto è ottenuto grazie alla forza della visione: il dettaglio incongruo del cartellone pubblicitario di un condom, dove le parziale nudità dei modelli è coperta da un telo, rende in un istante senza parole l’ambivalenza della posizione della chiesa cattolica in Africa. E così, mantenendo tutte le apparenze di un lavoro su — per quanto degnissima -commissione, Kiarostami impartisce un’ulteriore lezione di etica del cinema.
Come detto, Ten riapre il fronte del suo cinema. Sul numero di settembre 2002 della rivista francese “Cahiers du Cinéma”, la recensione al film termina con questa frase: “Dieci è il nuovo nome che il cinema assume da oggi, per noi”. Eccessivo? Neanche un po’. Il nuovo film di Kiarostami, clamorosamente sottostimato dai nostri critici o tutt’al più salutato con stima di sufficienza, è al contrario il più ardito e geniale tentativo di fare cinema e parlare “di” cinema per un autore nel 2002. Il film racconta attraverso dieci sequenze carattere e vicende di alcuni personaggi, tra cui cinque donne e un bambino. Ad unificare gli episodi, una giovane e bellissima donna di Teheran, la “conduttrice” (in tutti i sensi) della trama, recentemente separata dal marito e alle prese con un figlio piccolo ma già intelligente e polemico. Il film è tutto ambientato dentro l’automobile della donna, e durante gli infiniti spostamenti da casa propria alla scuola del figlio, dalla scuola alla casa della nonna, dalla moschea ai negozi, dai negozi alla periferia, e così via. Ogni volta, la donna carica persone diverse, in qualche caso anche solo per dar loro un passaggio. Nasce così un mosaico di dialoghi, ripresi con una videocamera digitale, che ora inquadrano il parlante ora solamente il destinatario. La telecamera è posta sul cruscotto, un po’ come avviene nelle trasmissioni di sequenze “rubate” del tipo “reality show”. La novità tecnica diventa, però, per Kiarostami una nuova soluzione linguistica, che permette — oltre all’abbattimento dei costi e alla leggerezza della messa in scena — di proseguire quel rapporto problematico col realismo che da sempre ha costituito la chiave di accesso alle operazioni del regista iraniano. Infatti, Dieci non si esaurisce nell’idea della sua struttura, né nel consueto ritratto della società iraniana, che questa volta straripa dai finestrini come sfondo ingombrante.

L’idea straordinaria del regista è stata quella di costruire un “woman film”, una specie di melodramma femminile attraverso la tecnica del microrealismo con telecamera. Il percorso iniziatico e l’emancipazione della protagonista avvengono nel contesto di alcuni viaggi in auto, mentre la macchina drammaturgica, lungi dallo scomparire, assume nuove e inedite forme di racconto. Si finisce con l’affezionarsi a queste protagoniste, si finisce col commuoversi di fronte a queste donne divise tra il rispetto di una tradizione soffocante e i problemi comuni a tutte le persone di sesso femminile di questo mondo. Il confronto tra i due dialoghi con il figlio, quello iniziale, stretto solo sul viso del bambino, e quello finale, breve e sereno, spiega come in questi novanta minuti sia passata tutta la storia dei rapporti umani, affettivi e amorosi.
È come se Dov’è la casa del mio amico? avesse aperto un “ciclo” di film che procede a partire da esso (il film, l’attore del film, il film sull’attore del film forse perito nel terremoto, il film sul film intorno all’attore del film, ecc.); Dieci a sua volta si pone come luogo di attivazione delle poetiche del cinema. Basti vedere, in questo senso, i film presentati a Cannes 2004: Five è costituito da cinque lunghissime inquadrature fisse di un quarto d’ora l’una ottenute con una macchina digitale; in più, non ci sono attori, e forse — suggerisce qualcuno — nemmeno bisogno di un occhio attivo dietro la macchina da presa. Barattoli, rane, cani, cose, persone, animali attraversano l’inquadratura in questo trionfo del cinema-in-quanto-tale che, curiosamente, somiglia però alle poesie del cineasta (ad esempio, “Al primo assalto del vento autunnale/una schiera di foglie/si è rifugiata in camera mia”: è la natura ad attraversare il mondo e il cinema, non quest’ultimo a racchiuderle, secondo un esempio di assoluta modernità cinematografica); 10 on Ten, invece, consiste — come scrive Leonardo Gandini — in una “operazione paratestuale sul film precedente”, ovvero un documentario in dieci capitoletti su come è stato realizzato Ten; stessa struttura, stessa durata, ma un film sull’altro film dalla fisionomia identica. Una sfida infinita, dunque, quella di Kiarostami con la forma del cinema e con se stesso.
Venendo ad aspetti più teorici, va detto che le riflessioni sul cinema del cineasta iraniano hanno ormai raggiunto un grado di elaborazione più che soddisfacente. Di Kiarostami, per esempio, si sono occupati anche filosofi del calibro di Jean-Luc Nancy, che nel volume Abbas Kiarostami — L’evidenza del film (vincitore del Premio Umberto Barbaro 2004, istituito da “Filmcritica”) costruisce un discorso eminentemente teoretico intorno al lavoro del regista. Vale la pena citarne l’incipit: “Ecco un cinema che enuncia, con potenza e ritegno, con grazia e severità, una necessità di sguardo e di utilizzo dello sguardo. Non una nuova problematica della rappresentazione che verrebbe ad aggiungersi a quelle che hanno scandito, a giusto titolo, la storia del cinema, ma piuttosto un’assiomatica dello sguardo: l’evidenza e la certezza di uno sguardo cinematografico come riguardo per il mondo e per la sua verità”: Questa idea di “riguardo” e “ritegno”, davvero suggestiva ed esatta, secondo Nancy attraversa l’intera opera di Kiarostami sovrintendendo di conseguenza alle scelte stilistiche e alle pratiche linguistiche del cineasta iraniano. Il libro, suddiviso in capitoletti (“Sguardo”, “Reale”, “Pregnanza”, ecc.), si sofferma a lungo sull’idea, un po’ bergsoniana, che in Kiarostami lo sguardo e il reale siano “mobilitati insieme”. In un paragrafo intitolato evocativamente “Cosa che rotola”, Nancy spiega: “Ma che cos’è il movimento che in tal modo è l’essere del cinema (non il suo oggetto, né ciò che esso rappresenterebbe o restituirebbe, come si crede allorquando si pensa il cinema tutto intero solo come un ‘disegno animato’)? Il movimento è ciò che ‘si fa soltanto se il tutto non è dato né può essere dato’ (Deleuze)”. Il dialogo filosofico tra Nancy, il citato Deleuze e le sovrastrutture di Bergson segnalano, quanto meno, che nel cinema di Kiarostami è in gioco un’intera visione del mondo, e che ad essa consegue una messa a punto di procedimenti tecnico-stilistici consustanziali a questa stessa idea. Ecco perché il piano fisso, la camera car, il piano sequenza e il fuori campo (magari tutti riuniti nella stessa occasione) non sono cascami cinefili adottati da registi amati (Bresson, si è detto; Rossellini, naturalmente; Straub e Huillet, forse) bensì l’unica possibile messa in scena per questi film.
 Non è un caso che Kiarostami compaia in molti dei volumi divulgativi intorno al linguaggio del cinema. Si veda, per esempio, l’agile studio di Emmanuel Siety intorno all’inquadratura: egli analizza la seconda sequenza di Dov’è la casa del mio amico?, in cui alcuni ragazzini giocano e si azzuffano fuori dalla scuola fino a che decidono di lanciarsi all’inseguimento di un volatile. Ebbene, scrive Siety, “il quadro lascia filare via i suoi occupanti senza battere ciglio, delegando a una nuova inquadratura il compito di racciuffare i ragazzini durante la loro corsa”. Il critico francese inserisce Kiarostami tra i registi che possiedono un’ “etica dell’inquadratura”, in compagnia di Roberto Rossellini, Johan van der Keuken e Jacques Rivette (in base soprattutto al celebre saggio “Il carrello di Kapò o dell’abiezione”).
Non è un caso che Kiarostami compaia in molti dei volumi divulgativi intorno al linguaggio del cinema. Si veda, per esempio, l’agile studio di Emmanuel Siety intorno all’inquadratura: egli analizza la seconda sequenza di Dov’è la casa del mio amico?, in cui alcuni ragazzini giocano e si azzuffano fuori dalla scuola fino a che decidono di lanciarsi all’inseguimento di un volatile. Ebbene, scrive Siety, “il quadro lascia filare via i suoi occupanti senza battere ciglio, delegando a una nuova inquadratura il compito di racciuffare i ragazzini durante la loro corsa”. Il critico francese inserisce Kiarostami tra i registi che possiedono un’ “etica dell’inquadratura”, in compagnia di Roberto Rossellini, Johan van der Keuken e Jacques Rivette (in base soprattutto al celebre saggio “Il carrello di Kapò o dell’abiezione”).
Ancora, per citare la mobilitazione interpretativa che il regista iraniano ha saputo far sorgere, bisogna citare lo studio di Mehrnaz Saeed-Vafa e Johnathan Rosenbaum (uno dei critici e studiosi americani più stimati ed esperti), di stampo prettamente accademico, frutto di una ricerca pluriennale per la University of Illinois. Qui gli autori si soffermano soprattutto sul significato culturale e politico dei film di Kiarostami, indagandone lo stile per scoprirne le finalità ideologiche (per Rosenbaum ad esempio “le difficoltà dei viaggi narrati nei suoi film sono un buon esempio di come la vita di tutti i giorni in Iran riesca immediatamente ad assumere un carattere poetico o filosofico”).
Inoltre, come si diceva, l’autore iraniano opera anche nel campo della pittura della fotografia e della poesia. Per quanto riguarda la fotografia, bisogna far riferimento — oltre che alle mostre come quella organizzata dalla Cineteca Comunale di Bologna nel giugno di quest’anno o al Museo Nazionale del Cinema di Torino nel 2003 — al volume “Kiarostami” edito da Electa nel 2003 dove sono raccolti molti scatti del regista. Per la maggior parte si tratta di fotografie senza titolo, dedicate a paesaggi vuoti e immagini naturali quasi astratte. Il merito del libro è quello di aprire una dimensione inedita di Kiarostami, quella dell’artista che opera attraverso diversi mezzi di espressione: in un saggio contenuto nel volume, infatti, il direttore dei “Cahiers du Cinéma” Jean-Michel Frodon si sofferma proprio sulle opere para-cinematografiche, come il cortometraggio Nascita della luce (1997), dove il sorgere del sole viene colto in cima a una montagna, o come l’installazione Sleepers, realizzata per la Biennale di Venezia 2001, dove viene mostrata la videoregistrazione di una coppia che dorme in forma di provocazione nei confronti dei divieti della Repubblica Islamica; o le brevi sequenze girate dal regista in riva al Mar Caspio nel 2002, mute e estatiche, che secondo Frodon rimandano alla struttura dell’haiku. Curiosamente, proprio agli haiku fa riferimento anche Riccardo Zipoli, curatore e traduttore italiano della raccolta di poesie di Kiarostami intitolata Un lupo in agguato. Quello che Zipoli afferma essere un “repertorio del sentire umano” fa risaltare la tendenza dell’autore a illustrare la vita tramite le sue contrapposizioni. Ancora una volta — e si noti l’identità di conclusioni cui giungono studiosi di estrazione opposta — “alla realtà viene negata la possibilità della stasi, e ciò contribuisce a sottolineare il ruolo centrale che il concetto di movimento ha nella poetica di Kiarostami”. Anche per Zipoli la ricchezza e la densità espresse in forma semplice richiamano l’atmosfera degli haiku giapponesi “che lo stesso Kiarostami riconosce tra le sue fonti di ispirazione” (esempio: “Un fumo bianco/su un cielo azzurro/da una capanna/di fango”; oppure: “I bagagli/sono pronti/ho voglia di sdraiarmi/ma non ho il tappeto”). Forse questi esempi chiariscono meglio di qualsiasi altro testo ciò che Kiarostami intende quando afferma: “Non credo che il cinema possa inventare qualcosa di nuovo. Credo invece che sia costretto suo malgrado, a ritornare alla semplicità, al punto di partenza”.

Ermanno Olmi: il cinema come indagine sul punto di partenza
Non avrebbe senso costruire lo stesso tipo di indagine critica fin qui espressa per Kiarostami anche sul cinema di Ermanno Olmi, per almeno due ordini di motivi: 1) Olmi è un cineasta più anziano e dalla carriera maggiormente strutturata e 2) la critica su Olmi ha raggiunto ormai l’esaustività, e nulla di quanto possiamo dire qui riuscirebbe ad approfondire ulteriormente.
Tuttavia, non dimentichiamo la scommessa di partenza: cercare di comprendere se Kiarostami e Olmi — come pensiamo — hanno concepito insieme Tickets per motivi assai più che occasionali.
Ma soprattutto: il cinema di Olmi ha a che fare con quello di Kiarostami? A prima vista, naturalmente, no. La migliore definizione del cinema olmiano ce la fornisce Orio Caldiron che, all’interno della voce dedicata al regista nel Dizionario universale del cinema curato dal compianto Fernaldo Di Giammatteo, parla di “magia dei gesti e dei volti”. In effetti, si è parlato spesso anche di “realismo fantastico” e di “fiabesco quotidiano” per definire certe opere di Olmi, anche se l’impressione è che questi giudizi siano calibrati soprattutto sui suoi film più “recenti” come L’albero degli zoccoli (1978) o Il segreto del bosco vecchio (1993). Prima (gli esordi) e dopo (le ultime opere) le cose non sono così semplici. “Magia del gesto”, invece, è altra cosa, più vicina alla rivelazione del momentaneo che non alla matrice culturale e letteraria.
Il primo punto di contatto con Kiarostami (e con Loach, se è per questo: ma non insisteremo oltre sull’argomento) è dato dalla frequentazione del documentario. Film come Cantiere d’acciaio (1955), La diga d’inverno (1955), Tre fili fino a Milano (1961) e tanti altri hanno costituito un apprendistato non dissimile da quello del collega iraniano. Si tratta, inoltre, di opere complesse, che hanno costituito nel panorama del documentario (industriale e non) italiano un tratto di sicura originalità. Ne scriveva con la consueta intelligenza Alberto Farassino: “Olmi non sa filmare le macchine senza gli uomini, ma non sa nemmeno filmare gli uomini senza le macchine o mettere in scena la filosofia morale senza il paesaggio industriale”. Filosofia, paesaggio. Termini che ritornano, che creano un legame indissolubile tra ciò che la macchina da presa “attraversa” e ciò che finisce col “pensare”. Non è un caso, del resto, che per la critica francese, meno impelagata di quella italiana con l’eredità neorealista, Olmi sia un rappresentante della “modernità” cinematografica, in sintonia con un approccio rosselliniano e libero alla materia trattata, al tempo stesso affrontata con rigore ma apertura linguistica. Ne parla soprattutto Jean-Luois Comolli in un lungo saggio comparso sui “Cahiers du Cinéma” nel 1964 e citato anche dalla brillante ricostruzione della fortuna critica del maestro di cui è autrice Laura Buffoni. I primi, grandi film olmiani sono certamente Il posto (1961), I fidanzati (1963), Racconti di giovani amori (1967, Un certo giorno (1968), e I recuperanti (1969), opera da alcuni considerata secondaria e invece assolutamente imprescindibile per comprendere lo sfondamento di ogni barriera tra documento paesaggistico e finzione, pari almeno al celebrato esordio di Il tempo si è fermato (1959).

Se non fosse che Olmi interroga il mondo per trovarvi le tracce di una spiritualità, potremmo definire alcune delle sue inquadrature come haiku. “Chi è stato ad Asiago i ricuperanti li incontra tutti i giorni; vanno a cercare i pezzi della Prima Guerra Mondiale, ma per un artista come Olmi questi non sono pezzettini da recuperare e vendere per farsi un ‘bianchetto’: queste sono le reliquie della storia e della morte, delle battaglie e dei valori”, scrive in una bellissima nota Don Antonio Balletto all’interno di un saggio eloquentemente intitolato “La dimensione religiosa nel cinema di Ermanno Olmi”. Don Balletto, poi, aggiunge una citazione di Rilke, proveniente dalla Nona elegia: ‘Forse siamo sulla terra solo per dire rosa, acqua, ciliegio…”, frase che ci riporta una volta di più nel mondo delle cose concrete, della natura e dei luoghi vissuti. Sia Olmi che Kiarostami partono da questo dato, possiedono uno sguardo che si mette in movimento col reale, posano gli occhi su quello che scorre e rotola. Certo, si potrà obiettare, nella seconda parte della sua carriera Olmi intraprende un cinema completamente diverso, favolistico, realizzato attraverso costruzioni imponenti di set e certamente lontane dal gusto per la semplicità degli esordi. Nulla di più vero: e nessuno, del resto, vuole negare a un cineasta così importante il dono dell’inquietudine, la passione per le svolte — anche brusche — della propria poetica.
Eppure, quel gesto (rosselliniano, se si permette) di partire dal fenomenico, di lasciare che il mezzo cinematografico, al di là dei procedimenti stilistici scelti, si faccia modificare dal mondo davanti all’obiettivo è certamente lo stesso, come la stessa è l’avventura umana. Con Ipotesi Cinema, in fondo, Olmi ha fondato una scuola e un centro di produzione, così come ha fatto Kiarostami in Iran: in entrambi i casi, il cinema è vissuto come autorialità, certo, ma anche come condivisione e apertura. Ecco, proprio nell’apertura all’altro, al circostante, all’accidentale si fonda una filosofia comune, anche quando l’uno chiede al mondo esteriore di restituirgli il barlume della divinità, e l’altro pone all’universo domande filosofiche. Certo, entrambi di fronte al sapore della ciliegia non vogliono privarsi della cosa-in-sé e — arrivati sino in fondo alla polpa — credono che dell’esperienza qualcosa si metta in funzione, si carichi di significato, si accenda di trascendente. Ecco che cosa scriveva Giovanni Buttafava a proposito di I fidanzati: “Il principio documentaristico e la frammentazione complessa della struttura permettono di sottrarsi al determinismo più o meno naturalistico che domina la narrativa (anche cinematografica) più diffusa, per raggiungere i più alti eventi cinematografici basati sul principio del ‘caso’”. Quel I fidanzati che “riesce a darci dopo tanti film una Sicilia nuova” (Ugo Casiraghi, L’Unità, 17/5/1963).
 “Olmi, agli inizi, è un autore che constata: è il suo modo di essere rosselliniano. Per ritrovare questo sguardo depurato, questo cinema di ‘prosa’ (non a caso Pasolini contrappose il primo Olmi de Il tempo si è fermato al moderno cinema di poesia di Prima della rivoluzione in una memorabile conferenza-con-proiezioni alla Mostra di Pesaro del 1965) alle preziose testimonianze (…) di della sopravvivenza di una visione utopica del mondo, dove permane l’armonia fra l’uomo e la natura, fra l’uomo e il mondo, fra l’uomo e il creato”, scrive Adriano Aprà. E proprio a Rossellini è indirizzata una lettera di Olmi datata luglio 1970, dove il regista di Asiago, con grande affetto, spiega al maestro la sensazione di solitudine provata dai “poeti”, da coloro che al contempo parlano a persone come loro ma devono comunque avere un pubblico perché l’opera viva (“Personalmente credo ai poeti, e anche che ciò che essi dicono non andrà perduto. E dato che un’opera di poesia non è legata a un fatto di costume o a un momento storico, essa continuerà a vivere, a trovare chi l’ascolta. Il pubblico di un poeta non è dunque in un tempo determinato, o in una determinata categoria di persone, ma è nell’umanità, nella storia. Il resto non mi interessa molto”).
“Olmi, agli inizi, è un autore che constata: è il suo modo di essere rosselliniano. Per ritrovare questo sguardo depurato, questo cinema di ‘prosa’ (non a caso Pasolini contrappose il primo Olmi de Il tempo si è fermato al moderno cinema di poesia di Prima della rivoluzione in una memorabile conferenza-con-proiezioni alla Mostra di Pesaro del 1965) alle preziose testimonianze (…) di della sopravvivenza di una visione utopica del mondo, dove permane l’armonia fra l’uomo e la natura, fra l’uomo e il mondo, fra l’uomo e il creato”, scrive Adriano Aprà. E proprio a Rossellini è indirizzata una lettera di Olmi datata luglio 1970, dove il regista di Asiago, con grande affetto, spiega al maestro la sensazione di solitudine provata dai “poeti”, da coloro che al contempo parlano a persone come loro ma devono comunque avere un pubblico perché l’opera viva (“Personalmente credo ai poeti, e anche che ciò che essi dicono non andrà perduto. E dato che un’opera di poesia non è legata a un fatto di costume o a un momento storico, essa continuerà a vivere, a trovare chi l’ascolta. Il pubblico di un poeta non è dunque in un tempo determinato, o in una determinata categoria di persone, ma è nell’umanità, nella storia. Il resto non mi interessa molto”).
Ecco dunque che, da questo fitto reticolo di rapporti, somiglianze, luoghi elettivi, assonanze concettuali, il cinema di Olmi si dimostra di matrice rosselliniana (più che genericamente “neorealista”) e la stessa cosa si potrebbe dire di Kiarostami. Entrambi raccolgono del neorealismo l’eredità più teorica, quella sistemata da André Bazin e da Godard, per intenderci, non quella della tradizione italica dei contenuti e del risarcimento sociale dell’arte.
E si approda dunque a Tickets. Come dimostra puntualmente la rassegna di questa edizione, il 2004/2005 sancisce la rinascita del film a episodi. Quel che sembrava un ricordo del passato, infatti, sembra riaffermarsi in questa strana stagione cinematografica capace di esprimere l’atomizzazione estetica di gran parte del cinema internazionale, che ormai vive alla giornata senza più produrre linee poetiche nazionali o luoghi di elaborazione creativa (non a caso ha chiuso ufficialmente anche il movimento Dogma).
Bene, se Manuale d’amore di Veronesi ha costituito l’atteso ritorno della commedia episodica all’italiana, Eros ha invece ricollocato lo spettacolo d’autore internazionale, che sembrava scomparso con gli ultimi fuochi degli anni Settanta. Laddove Antonioni, Soderbergh e Wong Kar-wai hanno palesemente girato i propri scarti narrativi, per cause probabilmente diverse l’uno dall’altro, Olmi, Kiarostami e Loach si sono accordati sulla cornice strutturale del film e hanno condiviso la genesi di una pellicola fortemente voluta dalla Fandango e coprodotta dalla Sixteen Films di Loach. Il treno su cui si svolge il film, in effetti, viaggia dal nord Europa verso Roma, il che fa comprendere come locations e maestranze siano per lo più nostrane; del resto, lo stesso Kiarostami lavora per la prima volta con attori italiani, sortendo per di più effetti decisamente positivi. Olmi perciò diventa un po’ il regista-ospitante e Ken Loach il co-autore dell’iniziativa. Nel primo caso, l’episodio olmiano appare come una variazione dichiaratamente senile delle opere più meditabonde del regista, con Carlo Dalle Piane che sembra incastrato nello spazio-tempo della propria memoria immediata e prova la nostalgia di un micro-abbandono e di una rinuncia d’amore (l’oggetto del desiderio lasciato sul binario è Valeria Bruni Tedeschi). Sul treno si agitano poliziotti e soldati, quasi a far presagire un attentato o semplicemente a suggerire l’atmosfera paranoica dei viaggiatori post-11 settembre. Bisogna però ammettere che tutte le circostanze politiche appartengono a un contesto piuttosto vago. Il piccolo film di Loach, invece, rinnova quella fragilità aspra che il regista britannico ha sempre saputo catturare in maniera ammirevole. Ecco infine — ma in verità l’episodio è quello centrale in ordine cronologico dei tre — il film di Kiarostami, che tra l’altro pare intenzionato proprio in questi mesi a “staccarsi” dai due colleghi e dare un seguito alla storia raccontata attraverso un nuovo lungometraggio autonomo (caso inedito, se la memoria non ci inganna, di sequel personale di un episodio tratto da film collettivo). Le esasperanti vessazioni che il giovane obiettore subisce dall’intrattabile signora che accompagna non rendono giustizia al sostrato squisitamente kiarostamiano del frammento. Costruito come una serie di confronti a due, di dialoghi a camera fissa e di rappresentazioni del fuori campo, il racconto permette una commedia di caratteri amara e nostalgica. Si pensi al piccolo mistero che circonda il rapporto tra il ragazzo e le adolescenti che lo riconoscono, e allo squarcio di passato che riemerge dal dialogo: Kiarostami riesce, senza forzare alcuna soluzione, a sussurrare un mondo provinciale e infantile che non c’è più, che appartiene al passato e ai ricordi di ciascuno dei personaggi eppure toccato dalle punture della malinconia. Il proverbiale dominio della parola e dell’esperienza dialogica (anche nel senso che Bacthin dava alla parola) permette a Kiarostami di indicare, oltre che la strada del buon cinema, persino una possibile riappropriazione degli spazi poetici che competono al cinema italiano. Il suo episodio è il più “italiano” di tutti, e al contempo il più lieve, il più ricercato, il più enigmatico, secondo una formula verbocentrica e dolceamara che rimanda ai nostri modelli degli anni Cinquanta.

Per ciò che concerne la pratica critica, è come al solito quasi impossibile formare un discorso interpretativo sui film a episodi firmati da più registi. Nessuno infatti parla più di Ro.Go.Pa.G ma piuttosto di La ricotta, e così via. Quando i singoli segmenti si sono staccati per chiara fama dal corpo principale è difficile che si riesca a ricomporli, anche nei casi dall’ispirazione più coesa (come per Paris vu par…). Nel nostro caso, oltre alla classica ricomparsa di alcuni personaggi tra un episodio e l’altro (tecnica narrativa assai sfruttata atta a solidificare il testo che tende a frantumarsi), di importante c’è almeno l’ambientazione in treno, che non è scelta da poco. Inutile ricordare quanto sia fotogenico questo mezzo di locomozione, almeno a giudicare da La signora scompare (1938), Le iene di Chicago (1952), A trenta secondi dalla fine (1985)o Europa (1991).
In Tickets, invece, il tema del viaggio e le caratteristiche visuali del treno vengono affrontate dal solo Olmi. Gli altri preferiscono ragionare sul senso simbolico dello spostamento di civiltà e sulla costrizione spaziale cui sono sottoposti i protagonisti. All’automobile si sostituisce dunque il treno, nella visione kiraostamiana del movimento.
Si chiude un cerchio, forse, dopo il quale il cinema di Kiarostami, Olmi e Loach troverà nuove strade poetiche. Fuori di metafora: è un cinema che non scomparirà dalla storia. È un cinema contemporaneamente “improvviso” (tanto quanto lo è un terremoto, una morte, l’acquazzone su un villaggio) e “duraturo”, in virtù della persistenza delle immagini riprodotte. Ecco dunque che il cinema non rifà se stesso, piuttosto rinasce guardandosi al punto di partenza, al grado zero della sua natura. Basta trovare cineasti, come Olmi e Kiarostami, che lo accendano di realtà.
Il presente saggio è stato pubblicato sul Catalogo 2005 della XXIV edizione del Premio Sergio Amidei alla migliore sceneggiatura cinematografica. Si ringrazia per la gentile concessione Roy Menarini, Giuseppe Longo e Luana de Francisco dell’ufficio stampa del Premio Amidei.
Testi citati: Gilles Deleuze L’immagine tempo, Ubulibri, Milano 1989; Eugenio Premuda, “Close-Up: gioco di ruolo per volto e macchina da presa”, in Aa.Vv., Il mondo dal finestrino – Il cinema di Abbas Kiarostami, Edizioni della Battaglia, Palermo 2002; Pier Paolo Loffreda, “E la vita continua”, Cineforum, n. 333, aprile 1994; Marco Dalla Gassa, Abbas Kiarostami, Le Mani, Genova 2000; “Speciale Dieci”, Cahiers du Cinéma, settembre 2002; Giorgio De Vincenti, Il concetto di modernità nel cinema, Pratiche, Parma 1993; Jean-Luc Nancy, Abbas Kiarostami. L’evidenza del film, Donzelli Editore, Roma 2004; Emmanuel Siety, L’inquadratura, Lindau, Torino 2004; Jacques Rivette, “Il carrello di Kapò o dell’abiezione”, Cahiers du Cinéma, giugno 1961; Mehrnaz Saeed-Vafa, Johnathan Rosenbaum, Abbas Kiarostami, University of Illinois, Urbana/Chicago 2003; Alberto Barbera, Elisa Resegotti, Kiarostami, Electa, Milano/Torino 2003; Riccardo Zipoli, “Il realismo ideale di Abbas Kiarostami”, in Abbas Kiarostami, Un lupo in agguato, a cura di Riccardo Zipoli, Einaudi, Torino 2003; Alberto Farassino, “Un metro di pellicola è lungo cinque”, in Aa.Vv., Europacinema ’85, catalogo 1985; Jean-Luois Comolli “Retour en Italie 2.”, Cahiers du Cinéma, luglio 1964; Don Antonio Balletto, “La dimensione religiosa nel cinema di Olmi”, in Elisa Allegretti, Giancarlo Giraud, Ermanno Olmi – L’esperienza di Ipotesi Cinema, Le Mani, Genova 2001; Laura Buffoni, “La fortuna critica di Ermanno Olmi”, in Adriano Aprà, a cura di, Ermanno Olmi – Il cinema, i film, la televisione, la scuola, Marsilio/Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, Venezia 2003; Adriano Aprà, a cura di, Il cinema di Ermanno Olmi, Incontri Internazionali Ponticelli Terme, Parma 1979; Giovanni Buttafava, “Presenze”, in Tullio Masoni, Adriano Piccardi, Angelo Signorelli, Paolo Vecchi, Lontano da Roma. Il cinema di Ermanno Olmi, La Casa Usher, Firenze 1990; la lettera di Olmi a Rossellini è stata pubblicata su “Positif” nel gennaio 1978, e ora è in A. Aprà, a cura di, cit., Parma 1979.
Ulteriore bibliografia su Abbas Kiarostami: Aa.Vv., Abbas Kiarostami. Textes, entretien, filmographie complète, Éditions de l’Étoile/Cahiers du Cinéma, Parigi 1997; Bruno Roberti, a cura di, Abbas Kiarostami, Dino Audino Editore, Roma 1996; Marco Della Nave, Abbas Kiarostami, Il Castoro, Milano 1999; Michel Ciment, a cura di, “Dossier Kiarostami”, Positif, dicembre 1997; Marco Della Nave, Alessandro Dardari, Antonio Desideri, Fabrizio Leone, Il cinema secondo Kiarostami, Cacm/FICC, 1994; Goffredo Fofi, “Abbas Kiarostami”, in Come in uno specchio. I grandi registi della storia del cinema, Donzelli Editore, Roma 1995; Ilaria Gatti, Lo sguardo discreto: il cinema dell’interiorità da Virginia Woolf a Kiarostami, Le Mani, Genova 2005; Zaven Goukasian, Abbas Kiarostami, a collection of criticism & essays on his films, Didar Publishers, Teheran 1997.
Ulteriore bibliografia su Ermanno Olmi: Aa.Vv., Ermanno Olmi: le radici dell’albero, Rapallo 1979; Giuliana Callegari, Nuccio Lodato, a cura di, Ermanno Olmi terzo tempo, Quaderni di Documentazione, Amministrazione Provinciale di Pavia, Pavia 1978; Marilia D’Addio, a cura di, Ermanno Olmi, Festival Tertio Millennio, Roma 1998; Jeanne Dillon, Ermanno Olmi, Il Castoro, Milano 1985; Luca Finatti, Stupore e mistero nel cinema di Ermanno Olmi, ANCCI, Roma 2000; Tullio Kezich, Ermanno Olmi – Il mestiere delle immagini: diario in pubblico di un’amicizia, Falsopiano, Alessandria 2004; Mauro Pecchenino, Il poeta con la cinepresa: Ermanno Olmi, Edizioni Alkaest, Genova 1979; Giorgio Tabanelli, Ermanno Olmi. Nascita del documentario poetico, Bulzoni, Roma 1987.
















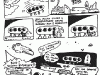














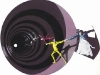





Commenti
Non ci sono ancora commenti