L’incontro
La prima volta la incontro al cinema.
Già tra le inquadrature iniziali, il suo sguardo buca il confine geometrico di un primo piano e si posa su di me, sottraendomi allo spazio materiale della sala affollata e trasportandomi senza movimento in una dimensione intermedia tra i nostri differenti piani di esistenza. Lì, senza parole, reclama la mia totale attenzione, lasciando a intendere che tutto è per me, quella sequenza, l’intero film, il suo sforzo interpretativo: un dono — per me.

Lo fa con una scena di pianto trattenuto: gli occhi si bagnano, ma un’espressione di dignità reprime le lacrime; la pelle del mento tremola nervosamente, ma senza eccedere in uno scatto muscolare; la voce si incrina, ma non si spezza. La sua spontaneità è tale da negare l’idea della recitazione, spostando il film dalla finzione alla rappresentazione della realtà, e sorge il dubbio che si tratti di stralci rubati di vita vera, di momenti ripresi segretamente e poi montati insieme a formare una storia.
Per due ore la osservo muoversi, parlare, sorridere, piangere sullo schermo, e la sua immagine riflessa, policromatica e bidimensionale, presto diviene presenza — nuova realtà, assolutamente plausibile, distante da me lo spazio di un tocco.
Il miraggio prospettico della profondità, l’illusione che la sua piatta fisicità abbia spessore si converte in una verità originale in cui l’evanescenza si fa consistenza, seppure una consistenza rarefatta e intangibile come l’aria — e come l’aria, l’emozione che mi trasmette è invisibile ma certa, impalpabile ma sensibile.
Così la inseguo lungo la proiezione, attraverso i piani sequenza e gli stacchi di camera, registrando ogni sua espressione, ogni suo gesto, ogni variazione nella sua voce, nel tentativo illusorio di separare l’attrice dal personaggio. Il film rimane un semplice sfondo.
Quando l’incanto termina, la luce diffusa schiaccia lo schermo, riducendolo a una lastra opaca, e contemporaneamente dilata la sala, infondendo in quelle che erano le ombre degli spettatori un giallastro soffio rivitalizzante. Lentamente, come corpi mossi da una volontà remota, tutti si alzano in piedi e prendono a muoversi goffamente tra le file di poltroncine. Ancora vuoti di se stessi, faticano a riappropriarsi del loro presente.
A mia volta confuso, scruto quei volti anonimi che mi scorrono al lato, cercando una conferma di quel che ho vissuto, di quel che ho provato. Mi sembra che la gente abbia guardato soltanto il film, non lei, non abbastanza lei, e mi chiedo se sia stata un’esperienza unicamente mia, se sono stato il solo a riconoscere l’attrice dietro al personaggio — se sono stato il solo a vedere Elena Duse.
Il primo pensiero: vorrei conoscerla.
 L’idea si affaccia con la vaghezza delle fantasticherie e dei desideri ovviamente irrealizzabili, ma di colpo un’insolita punta di orgoglio si erge dentro di me e mi dico quasi stizzito che devo almeno tentare. Nell’istante in cui concedo a me stesso una possibilità, ecco che la possibilità si palesa: la intervisterò a nome della rivista presso cui svolgo il praticantato per diventare giornalista.
L’idea si affaccia con la vaghezza delle fantasticherie e dei desideri ovviamente irrealizzabili, ma di colpo un’insolita punta di orgoglio si erge dentro di me e mi dico quasi stizzito che devo almeno tentare. Nell’istante in cui concedo a me stesso una possibilità, ecco che la possibilità si palesa: la intervisterò a nome della rivista presso cui svolgo il praticantato per diventare giornalista.
Mentre la redazione approva la mia proposta, frugo in Internet in cerca di informazioni, magari di un contatto. Non mi meraviglia scoprire che è un’attrice teatrale, elogiata e già premiata come giovane promessa. Con sorpresa, invece, trovo il suo indirizzo di posta elettronica. È gentile, mi risponde personalmente, mandandomi il proprio numero di telefono ed esorcizzando il mio unico timore di trovarmi davanti a una persona inavvicinabile. La chiamo, la sua voce come nel film, impostata, rassicurante. È strano: anche se solo in parte, posso dire di riconoscerla pur non avendo mai parlato con lei in precedenza. Cerco di cogliere un frammento della sua identità attraverso le poche parole che ci scambiamo, ma non rimangono che suoni e tanta gentilezza, una gentilezza sincera, un senso di autentica apertura. Ci accordiamo con facilità: visto che molto presto debutterà con un nuovo spettacolo teatrale, andrò alla prima, a Torino, e il giorno dopo ci incontreremo.
Anima e corpo
Il film si intitola “Anima e corpo”. Elena Duse ne è la protagonista e, come molti attori teatrali, è rimasta sconosciuta al grande pubblico fino al suo esordio sul grande schermo. Leggo di lei sulle riviste, l’hanno già intervistata. Era già magra, eppure il copione l’ha obbligata a dimagrire di 15 chili durante i due mesi di riprese. Com’era prevedibile, la bieca miopia della critica e dei giornalisti focalizza quasi esclusivamente questo aspetto, la prova fisica anziché quella interpretativa, come se il personaggio fosse reso dalla sola trasformazione corporea, dal costume, dal travestimento — come se fosse una maschera senz’anima.
Ad attrarre la mia attenzione, però, non erano state le generose immagini del suo corpo in rapido deperimento, con la camera che accarezzava la pelle tirata sulle costole e i seni sempre più minuti, bensì l’intensità di quella prima scena di pianto, a cui le successive facevano eco in una costante assenza di sopratoni. La sua recitazione si era dimostrata impeccabile, curata e controllata nei dettagli, allo scopo, paradossalmente, di ottenere la massima naturalezza possibile. Non le bastava rendere credibile il personaggio: voleva trasmetterne il vissuto in modo preciso e coinvolgere lo spettatore in una partecipazione senza condizioni. In questo senso l’alterazione della forma, l’adattamento fisico, costituisce un simbolo, l’evidenza esteriore della riduzione della persona al personaggio, la prova di una accettazione che si fa compenetrazione.
Mi domando se Elena Duse si sia temporaneamente persa nella ragazza magra che appare sullo schermo, se quella compenetrazione sia stata onnicomprensiva e sia durata oltre il tempo delle riprese. Solo più tardi mi dirà di riuscire a difendere la propria personalità, mantenendola separata da quella dei suoi personaggi. Mi dirà: “Io non li giudico, li accetto, così non provo resistenze a entrare in loro, e non fatico quando devo separarmene”. Mi sembra un’incredibile prova di forza: io non ne sono capace.

I miei personaggi hanno lo spessore di una pagina e sono fatti di carta e di parole.
Sono la mia ombra.
Dapprima languidi riflessi delle mie emozioni, si nutrono degli eventi della mia vita, addensandosi come nebbia impalpabile. Poi, inaspettatamente, dalle nebbie essi prendono forma: appaiono come lemuri, e io sento che erano sempre stati lì, ad attendere il tempo in cui sarei stato pronto per riconoscerli. Essi non nascono, non muoiono, semplicemente appaiono, e da quel momento vivono con me, in me, come simbionti inscindibili, esigendo che io scriva di loro, ma donandomi in cambio il proprio sguardo — e quello sguardo è capace di svelare la disposizione ordinata e consequenziale che si cela sotto l’apparente casualità degli eventi, rivelandomi le connessioni tra vicino e lontano, mostrandomi le storie.
Sono loro, sono i miei personaggi a narrarmi le storie che scrivo, in questa lingua fatta di pure intuizioni. Spesso mi chiamano nel sonno, costringendomi a svegliarmi per prendere rapidi appunti che al mattino troverò quasi illeggibili; altre volte mi conducono a visioni fantastiche, sogni a occhi aperti di cui ho riempito quaderni interi senza coglierne il significato — quello appare dopo, nel passaggio dal frammento al racconto, ed è allora che inizia la fatica, la sfida della composizione, la grande ricerca
L’esplorazione parte da una mappa chiamata struttura, traccia un percorso a capitoli, segna tappe di sequenze, si muove con passi che sono parole. Ogni passo va misurato, ponderato, controllato, perché il sentiero è ripido, scosceso e sempre più buio via via che si cala nel solco dell’inventiva, un pozzo cui attingere chimere e fantasie il cui solo scopo è far sognare un lettore che non conosco.
Non è mai facile: ogni racconto è un parto intellettuale di cui l’ispirazione è la gestazione e la stesura è il travaglio. La creatura che nasce ha ancora bisogno di nutrimento e di cure, di rifiniture minimali in cerca dell’equilibrio formale — quella leggerezza apparente capace di nascondere lo sforzo della creazione. Davanti a questo il giornalismo è un rifugio, forse sarà una fonte di sostentamento, ma non ha rapporto alcuno con ciò che chiamo scrittura. A importarmi sono solo le storie, le realtà dentro la realtà, perché esse pulsano dentro di me, pulsano di vita propria — la vita dei personaggi, la mia.
Tutti i miei personaggi non sono che uno.

Non importa quanti nomi essi abbiano, non importa che alcuni siano maschi e altri femmine: la psicologia di ognuno di loro è un frammento del mio ego, una selezione di specifici tratti della mia personalità maneggiati e rimescolati. L’anima si scompone, si ricompone, si segmenta nuovamente — e a ogni ciclo corrisponde un nuovo stato di consapevolezza che è già un personaggio. Così, ogni personaggio è mio figlio, eppure tutti mi sono estranei.
Durante questo processo di moltiplicazione spontanea essi esistono, ma sono privi di sostanza. Esistono come esistono i pensieri, nient’altro che l’idea di qualcosa che verrà, spiriti erranti nel limbo della mia immaginazione. Soltanto se li traduco in segni, soltanto così posso donare loro la libertà di esistere al di là di me. E nell’attimo in cui essi trascendono il creatore, divengono realtà, nutrendosi delle menti dei lettori e nutrendole a propria volta.
Questo mi differenzia da Elena Duse: io traduco l’anima in parole, lei traduce le parole in corpo ed espressione. Elena Duse entra nei personaggi che emergono da immaginazioni come la mia, immaginazioni straripanti suffragate da una penna.
Attraverso i personaggi, la mia identità può comunicare con identità lontane, identità che non conoscerò mai. Questa è la gratificazione dello scrittore e per questo, quando nessun editore accettò di pubblicare il mio primo romanzo, persi parte della mia identità. Non solo il mio slancio verso il mondo era stato smorzato: soprattutto, soffrivo per quei personaggi intrappolati su pagine che nessuno avrebbe letto mai, fremevo per loro.
In principio credetti che quel rifiuto non avesse inciso sulle mie capacità, ma presto mi accorsi che mi aveva tolto energia. Ero inerme di fronte alla pagina bianca, privo di convinzione, e tuttora, quando mi accingo a scrivere, non posso evitare di chiedermi se sia uno sforzo che meriti di essere compiuto.
Per tre anni mi sono lasciato travolgere dal contingente, dal lavoro, i viaggi, le donne. Non posso smettere di scrivere, ma ho relegato la scrittura a un ruolo marginale, evitando sistematicamente di creare qualcosa di organico, di completo. Riempio quaderni interi, ma non un racconto fra quelle pagine: non ho più lasciato spazio ai miei personaggi — ho scritto solo di me, soltanto per me.
So che dovrei tentare ancora, e non ho dimenticato l’estasi di cui ero preda nel dar vita a qualcosa di nuovo. Forse ho paura di non provare più quel trasporto, o forse non ho più volontà. Certamente, mi sento sempre più vuoto.
Mi chiedo se sia per questo, per riempire il vuoto, che faccio ogni cosa — ogni altra cosa — con tanto zelo. Come quando stendo l’intervista.

Le domande
Inizio documentandomi, leggendo le riviste specializzate. Ne ho bisogno, è la mia prima volta, sono un dilettante. Non l’ho detto a Elena Duse, ma sono assolutamente certo che se ne accorgerà.
Le interviste che scopro sono tutte frettolose, costrette entro i margini rigorosi di una, massimo due pagine, foto comprese. Io scrivo per una testata telematica, non ho limiti di spazio, solo di tempo: quello che potrà dedicarmi.
Mentre nella mia mente continuano a scorrere le immagini del film, con Elena Duse cui trema la pelle del mento, Elena Duse che corre scherzosa tra gli alberi, Elena Duse che si pesa sulla bilancia implacabile ed è visibilmente sempre più leggera, assorbo le sue parole stampate su carta di scarsa qualità e leggo diffidente le righe in grassetto che le precedono. Detesto la falsa confidenza tanto di moda nell’ambiente del cinema, lo stile ammiccante degli intervistatori, che la chiamano per nome e le danno del ‘tu’, come se averla vista nuda su uno schermo gigante bastasse a renderli intimi. Detesto le loro domande allusive, materiale da pettegolezzi, e detesto quando le propongono affermazioni che sono già una risposta, e alle quali non rimane altro da aggiungere se non l’imbarazzo che scaturisce dall’obbligo di dire comunque qualcosa. Perché il potere di un giornalista è enorme, spropositato, non ci si può sottrarre: il suo diritto di porre domande va al di là del diritto alla riservatezza degli individui. Il giornalista, infatti, dispone del pericoloso privilegio di esigere delle risposte — non le risposte, soltanto delle risposte, ma già si tratta di un privilegio che è proprio di despoti e torturatori: il privilegio di interrogare.
(Mi sembra del tutto evidente quanto domandare e interrogare siano verbi dai significati tremendamente lontani. Una domanda non ha altra conseguenza che la sua risposta. In un interrogatorio, invece, è la risposta l’inizio delle conseguenze. Una domanda ammette sempre il silenzio. In un interrogatorio, invece, il silenzio sarà punito).

La pena contro chi, per un pudore ormai demodé o per mancanza di argomenti, non si concede al pretestuoso diritto all’informazione, è lo sbugiardamento plateale, o peggio: l’ostracismo mediatico. Coloro, però, che si concedono alla curiosità pubblica o alle esigenze dello spettacolo corrono il rischio di ritrovare le proprie parole rimaneggiate, le proprie frasi mozzate, le proprie asserzioni censurate, come mi sembra accada in queste interviste banali, standardizzate, rielaborate per adattarsi al formato della pagina: non c’è niente, tra queste righe, che mi aiuti a comprendere Elena Duse.
All’improvviso tutte le interviste, quelle su carta patinata, quelle televisive o radiofoniche, quelle frettolose come quelle più calme e posate, tutte mi sembrano semplicemente degli squallidi balletti, delle danze rituali ben coordinate, in cui il giornalista e l’intervistato, il presentatore e i suoi ospiti si attengono a ruoli di cui sono ben consapevoli, e per i quali il livello di improvvisazione è minimo. Il giornalista sceglie le proprie domande per orientare l’intervistato verso una direzione premeditata, in modo da mostrare i fatti sotto una prospettiva arbitraria e di comodo — quella che egli pensa la gente voglia sentire. L’intervistato interpreta la propria parte, atteggiandosi a persona affidabile quando è in veste di esperto, scaldandosi nei dibattiti politici e sportivi, rispondendo con una battuta quando ci si aspetta che sia brillante. Mi rendo conto che l’intervistato recita quasi sempre, nascondendosi dietro la maschera più adatta per l’occasione. È normale che sia così: i pensieri sono l’unica libertà che abbiamo. A me, però, questo balletto non interessa. Io voglio scoprire la fonte della sua volontà, voglio svelare il segreto del suo talento, lo voglio davvero. Per me non si tratta soltanto di un’intervista: per me è un incontro, è un’occasione per capire. Solo se le mie domande sapranno essere acute, pertinenti e soprattutto sincere riuscirò a evitare che si difenda, che reciti.
Comincio a stendere l’intervista. Decido di chiederle: “Un’attrice recita solo sul palco o anche nella realtà?”. Poi le invio una e-mail in cui accenno agli argomenti di cui parleremo. Non sono tenuto a farlo, ma continuo a non sopportare la nostra disparità. Per lei sono soltanto una voce.

La città
Eccitato all’idea che la mia prima intervista mi abbia portato in un luogo inesplorato, cerco di perdermi nella sua città, una Torino per me completamente nuova che osservo attraverso l’obiettivo della mia reflex. Mi lascio trasportare da una specie di frenesia fotografica, convinto, senza saperne il perché, di dovermi tutelare dall’inaffidabilità della memoria, e passo dopo passo, strada dopo strada, capisco che questo ricorderò: una lunga sequenza di inquadrature e focalizzazioni, accompagnate dal suono secco degli scatti e dal senso inebriante della scoperta. Costruisco un labirinto di immagini che non rappresenta un luogo, ma una dis-topia: non Torino, ma una visione privata di Torino, costituita da una serie di frammenti disgiunti che manterrà una propria coerenza solo al mio sguardo. Forse un giorno, dimentico di quel che provo ora, guarderò queste foto e crederò si sia trattato della città, delle sue architetture, dei suoi passaggi: di un fascino storico che ho cercato di intrappolare. Oggi, però, so bene che quel che cerco è lei, Elena Duse, e che la sua città non fa che suggerirmi indizi per comporre la sua identità, per assemblare gli elementi che sono andato raccogliendo: un corpo appiattito, una voce filtrata, qualche riga di e-mail, alcune informazioni inessenziali; e poi, certamente, il film, rappresentazione fuorviante di un ego immaginario. Le mie foto di Torino sono come questi tasselli: isolate, rimandano a un fascino che ne travalica i bordi; accostate, generano una mappa la cui geometricità complessiva non si lascia cogliere.
La chiesa
Mosso da un istinto turistico, o forse da mera curiosità, entro nella chiesa pigiata tra i palazzi risorgimentali, e mi ritrovo immerso in una ricchezza che niente all’esterno lasciava presagire. Subito stordito dalla quiete improvvisa, avanzo tra abbaglianti decorazioni orafe, che riflettono sfarzosamente la luce altrimenti scarsissima, e gli affreschi dai colori intensi e vivaci, evidentemente il risultato di un restauro recente. La patina opaca di polvere secolare che normalmente ricopre le pareti, le pitture, le sculture delle chiese è stata rimossa, e si può quasi pensare che non avesse mai attaccato. Mi guardo intorno, cercando di immaginare l’effetto di un simile splendore sulle menti incolte e superstiziose del volgo in epoca rinascimentale. Ho la sensazione che in questo luogo il tempo sia immobile, che questa opera d’arte vivente si sia mantenuta giovane attraverso le epoche, grazie a un proprio ineffabile respiro di luce. Mi rendo conto che se un tempo le chiese impressionavano il popolo attraverso un dispiegamento di martiri e angeli ammonitori, oggi continuano a toccare l’animo attraverso le bellezze di cui sono custodi, a tal punto che entrare in un luogo di preghiera completamente spoglio suscita quasi un senso di delusione. Così, quelle stesse opere commissionate un tempo per il loro valore sociale, quelle stesse opere dal linguaggio la cui grammatica tende a sfuggirci, sono godute oggi per il loro valore estetico ed evocativo. E se allora la sacralità si trasmetteva attraverso una simbologia ormai sempre più esoterica, adesso si rivela nella capacità di fascinazione dell’arte, i cui meccanismi rimangono di una misteriosa inafferrabilità. Eppure non vi è trascendenza nell’arte: ogni opera è fatta di reale, di immanente, della concretezza di materiali e forme e colori che provengono dall’esperienza individuale dell’artista. L’uomo non può inventare niente, può solo generare nuove associazioni, trasformare il visibile per mezzo di accostamenti originali di elementi esistenti. Quando questi accostamenti, però, riescono a rendere con una concretezza accessibile ai sensi quel che non ha materia né forma né colore, quel che esiste astrattamente soltanto dentro di noi, ecco, si è in presenza dell’arte.

In questo senso l’arte è la suprema forma di finzione, perché si finge quel che non è, evocando emozioni che sono già nell’occhio di chi guarda; ed è la suprema forma di verità, giacché rappresenta autenticamente la realtà intangibile che si cela dietro alla realtà visibile. È questa doppia natura dell’arte, forse, a richiamare in essa il divino, attraverso la mediazione della fede, che è al tempo stesso suprema finzione (per chi non crede) e suprema verità (per chi crede). Il mistero della fede, come il mistero dell’arte, sarebbe allora una proiezione del nostro ego, una risposta ai nostri bisogni interiori.
Deciso ad appuntare queste idee sul quadernino che porto sempre con me, mi siedo sulla panca di fronte all’altare. Mi attardo a osservare i marmi lucidi e protetti da un silenzio irreale, come un vuoto totale, come se non vi fosse aria. All’improvviso noto delle ombre dietro l’altare. Non producono alcun suono. In principio mi appaiono angeli bianchi, angeli senz’ali, poi si mostrano ragazze: sono due restauratrici. Una in piedi su un’impalcatura, l’altra più in basso, seduta, ritoccano un enorme quadro decisamente sbiadito in più punti. Lavorano con gesti brevi e ripetuti, quasi minimali, lenti, accurati, e a me sembra che ogni pennellata ricada sullo stesso punto, instancabilmente. Non posso vedere i loro volti, eppure mi sembrano splendide, in simbiosi con la chiesa. Provo un senso di comunione con loro: pennello e penna, celebravamo un omaggio all’arte, un gesto di dedizione e adorazione.
Credo di provare lo stesso senso di comunione con Elena Duse. Il mio interesse per lei è quasi opposto al cieco fanatismo degli ammiratori. D’altra parte il fenomeno del divismo non mi ha mai toccato, nemmeno a quell’età in cui quasi tutti inneggiano a un attore o un cantante come a un modello. Tutte quelle belle e tutti quei bellocci desiderati e osannati per me sono sempre stati soltanto icone prive di significato, personificazioni esotiche di sogni non miei. Molti fantasticano sugli artisti perché immaginano che essi vivano in un mondo diverso e magico, e che provino emozioni negate ai più. A me, invece, colpisce il fatto che essere scelto da un’artista significa in qualche modo essere all’altezza del suo talento, così come essere accettati da una bella donna significa essere degni della sua bellezza, e che di quel talento e di quella bellezza ci si possa sentire investiti di riflesso. Per questo sono così ansioso di incontrare Elena Duse: spero che mi sia svelato quanta parte della sua bravura è dovuta al talento, quanta alla sua determinazione, quanta alla scelta di personaggi adatti a lei. Ho bisogno di capirlo, perché Elena Duse è riuscita laddove io sono ancora ai primi passi, smarrito.
Una signora anziana mi passa davanti, fiera di essere indaffarata e tutta compresa nel suo ruolo. Probabilmente aiuta il parroco a mantenere pulita e ordinata la chiesa.

All’improvviso mi si avvicina e con fare indisponente mi chiede cosa scrivo. Cerco di riprendermi in fretta dalla sorpresa e le rispondo, mentendo: “impressioni sulla chiesa”. Come sconcertata, senz’altro preoccupata, mi chiede di rimbalzo: “Per farci cosa?”. Questa specie di sgomento mi diverte. Le dico che scrivo per me, lei conclude con un semplice “ah”, e si allontana. Quasi non riesco a crederci: è gelosa, è gelosa della chiesa che considera sua, il suo tempio, forse la sua vera casa. Forse ha paura che possa carpirne la bellezza, rubargliela con le parole, come le tribù primitive temevano che le foto potessero rapire l’anima.
La vecchia mi ha infastidito: decido di andarmene. Do un ultimo sguardo alle restauratrici, concentrandomi sulla pace metodica e regolare delle loro pennellate, quindi mi muovo verso l’uscita. La signora mi è subito addosso: mi si accosta a una distanza quasi intima, e mi accorgo di quanto è ingobbita sotto il peso degli anni, o forse delle troppe ore di Padre Nostro e Ave Maria. Con fare ieratico mi raccomanda di dire una preghiera, perché tanti in quella chiesa sono stati salvati.
Lo spettacolo
Mi nutro, non ceno. Mordo affamato un trancio di pizza bollente, mi scotto e per tutta la durata dello spettacolo sentirò il palato bruciarmi — il riflesso fisico di un malessere tutto interiore. Perché soffro per lei, soffro per lei sin dal momento in cui entro nella sala e la vedo: è già sul palco, gettata nella penombra, con gli arti molli e il mento appoggiato al petto: un burattino senza burattinaio. È ancorata alle assi attraverso una complessa rete circolare di maglie che, come vele agganciate al suo vestito, la lasciano scoperta soltanto dalla vita in su: sembra trovarsi in ginocchio, in una posizione infantile tra il rigido e il compìto che dev’essere molto faticoso sostenere.
E mentre Elena Duse giace costretta in quell’abbandono forzato e innaturale, la gente prende posto con una lentezza soffocante. Mi rendo conto che alcuni nemmeno la notano, che si raccolgono in capannelli di chiacchiere fuori luogo — lo spettacolo è già iniziato, vorrei farglielo notare, vorrei quasi gridarglielo, non vedete attraverso l’oscurità, non vedete che è già lì per noi?!
Osservo con stizza quel pubblico disattento mentre un vivo, pungente senso di disagio mi lega alla poltroncina. So che Elena Duse sceglie spesso di interpretare parti che coinvolgono la fisicità, che implicano il sacrificio del corpo, lo so e me lo confermerà nell’intervista, ma non basta a tranquillizzarmi. Prendo allora a fissarla, ripetendomi che ci si sarà abituata, che durante le prove avrà trovato il modo di rilassarsi, ma non posso smettere di pensare che quell’apparente distacco dal corpo dev’essere molto stancante. Come riesce a fingere che quelle persone vocianti a pochi metri da lei non esistano? O meglio ancora, come riesce a fingere di non esistere? In quali spazi si reca con la mente? Come può mantenere quella concentrazione, essere altrove rimanendo vigile, come riesce a non smarrirsi nel conto dei secondi, dei minuti, dell’intero quarto d’ora che deve trascorrere prima che tutti si siedano e le luci finalmente si spengano?
La guardo e mi sembra di entrare in sintonia con lei, di stabilire un tenue rapporto telepatico, rafforzato dal costante contatto visivo. Soffro della sofferenza che immagino lei soffra e che mi sembra di essere l’unico a percepire — ma non può essere così, devono esserci altri da qualche parte, forse seduti dietro di me, forse dove io non vedo, altri che rabbrividiscono in silenzio.

La fatica di quell’immobilità forzata mi irrigidisce, genera una tensione di cui non riesco a liberarmi per tutto lo spettacolo, eppure le sue mani, appoggiate sul grembo, sono rilassate: sembra che si stia riposando. Comincio a leggere in quel suo afflato masochistico un atto sadico nei confronti del pubblico: ne siamo vittime, non testimoni. È allora che ne riconosco l’insostenibile, perversa bellezza, come la bellezza di una cicatrice, l’icona di un dolore passato ma in qualche modo ancora presente — ed io, che ho la presunzione di dirmi scrittore, non vedo bellezza senza dolore, non intendo arte senza sacrificio. Come quel che scrivo (quel che de-scrivo) passa attraverso di me, e io lo sento e lo vivo in prima persona, così quel che Elena Duse porta in scena deve sentirlo, deve viverlo, deve apprezzarlo mentre le scorre nelle membra. Perché, allora, sceglie questi ruoli di donne che soffrono e si lasciano soggiogare, queste parti che spossano realmente anche l’attrice? Perché si fa legare a un palcoscenico, perché si sottopone a diete che lasciano il segno sulla pelle? Forse soltanto perché può farlo: perché conosce il dolore e riesce a strumentalizzarlo. Forse il suo bisogno di creare passa attraverso la distruzione del sé, fisica oltre che mentale: una destrutturazione, una scomposizione dell’ego che si realizza attraverso il (ri)modellamento del corpo. E in fondo è proprio questo il compito dell’artista: scomporre e ricomporre, decomporre la realtà in tasselli verosimili per riassemblarli poi in modo nuovo e apparentemente improbabile — e in questo processo scomporre anche la propria coscienza, per darle una nuova forma e raggiungere una più spiccata sensibilità.

Il palco finalmente si illumina e in pochi secondi cala il silenzio. Elena Duse si lancia all’improvviso nel suo lungo, farfalleggiante monologo, agitando il corpo e le braccia come un naufrago in balìa delle onde. Nella voce, impostata su un tono infantile, rimane solo il ricordo del fare posato con cui mi parlava al telefono, e io la riconosco eppure non la riconosco: il personaggio schiaccia la personalità, ne rimuove ogni traccia dietro a una mimica facciale accentuata da un pesante trucco di scena. Davanti a questa trasformazione radicale, capisco il lavoro di Elena Duse: ha interiorizzato la maschera, l’ha imparata, e il ciak o l’accendersi dei riflettori l’attivano come una sorta di anisotropia. È lei ma non è lei: è lei che dall’interno modella la maschera, la plasma e poi la espone, pronta comunque a liberarsene con la facilità con cui ci si sfila un costume.
Sotto le mie dita, per tutto il tempo, il velluto rasposo delle poltroncine.
Rimango ad aspettarla fuori dal teatro, sotto una pioggerella gentile che trasforma la visione attraverso gli occhiali in un quadro pointillisme. Mi tengo in disparte rispetto agli altri, gli amici, per evitare i commenti retorici e le chiacchiere di rito: voglio preservare e coltivare le sensazioni che lo spettacolo ha lasciato in me.
Quando esce dal camerino, è sorridente ma visibilmente affaticata. Applauso, baci e abbracci, gli inevitabili fiori. Indossa i tacchi alti, un paio di scarpe arancione lucide e démodé. È ancora troppo magra.
La saluto per ultimo, rapidamente. Mentre torno a casa, la pioggia si fa intensa e mi purifica dall’ansia che avevo accumulato. Mi sento in armonia con tutte le cose. Una volta nella mia stanza, avverto la necessità imperiosa di annotare ogni momento della giornata, ogni singola impressione, ogni dettaglio che mi ha colpito. Scrivo già pensando a un racconto: ne immagino i temi centrali, i personaggi. Stendo una quantità di idee, lottando contro la stanchezza fino a che gli occhi, irrimediabilmente, mi si chiudono.
Elena Duse
 È puntualissima. Nei suoi occhi, nel sorriso, scorgo l’ombra di un conflitto tra lei e l’aria che la circonda. Forse, comunque, è solo una mia suggestione.
È puntualissima. Nei suoi occhi, nel sorriso, scorgo l’ombra di un conflitto tra lei e l’aria che la circonda. Forse, comunque, è solo una mia suggestione.
Attraversiamo un teatro completamente vuoto e ci sistemiamo nel foyer tappezzato di rosso. Cominciamo subito, il tempo è limitato e io devo chiederle del suo impegno come attrice, del suo modo di vivere l’arte, di come vede la situazione del cinema e del teatro italiani. Parlare con lei è piacevole: la sua voce è di nuovo come al telefono, le sue espressioni risultano stranamente familiari e, benché sia perfettamente consapevole del proprio talento, non pecca né di falsa modestia né di immodestia. L’intervista procede con un ritmo proprio, le domande concatenate l’una all’altra in modo coerente, equilibrato e consequenziale. In principio avverto una tensione, uno sforzo costante in lei, che mi conferma la nostra disparità, la pesantezza delle aspettative che i nostri ruoli di intervistatore e di intervistato ci impongono. Presto, però, mi accorgo che si lascia coinvolgere, che le piace il modo in cui dirigo il discorso e la stimolo a raccontarsi. Le mie domande formano un corpus organico in cui la singola risposta acquista un senso soltanto se posta in relazione con le altre, e l’intera intervista si presenta come una richiesta d’apertura. Elena Duse la accetta, mi accetta, e mi sembra che si conceda senza mentire, senza recitare.
La mia prima intervista.
Uscendo dal teatro mi coglie un desiderio di scrivere intenso e impaziente. Distinguo l’ispirazione e glielo dico; mi risponde che non ama gli scrittori, replico che non importa, che avrei scritto di lei. Non dà peso alle mie parole, che devono sembrare lo sproloquio di un ammiratore: è già oltre, lontana, e anch’io sono già oltre, concentrato sul momento che si sta per concludere e sul modo in cui lo descriverò. Sento nella mente la voce narrante, impegnata a raccontare le nostre presenze in quel luogo carico di energie, che vedo deformarsi nel passaggio alle due dimensioni della carta: sono consapevole che, esattamente come ha fatto il cinema, anch’io creerò una nuova Elena Duse, ne farò un personaggio, lo intrappolerò in un racconto. Muterò irreversibilmente il nostro incontro in una storia, e questa storia non sarà necessariamente una storia vera, sarà soltanto una storia possibile, una storia il cui unico legame con la realtà sarà la propria plausibilità. Perché tutto ciò che conta è l’arte, e la semplice rappresentazione della realtà risulterebbe essere soltanto un’inutile riduzione. L’arte non può essere oggettiva, nemmeno quando persegue l’oggettività: è sempre e per propria stessa natura soggettiva. Come il fotografo non dovrebbe mai mostrare quel che i suoi occhi vedono, bensì qualcosa che emerge solo attraverso le lenti dell’apparecchio fotografico, così la mia sensibilità filtrerà il ricordo e le parole lo interpreteranno, assegnandogli un significato nuovo, soggettizzandolo. E se qualcuno si chiederà quanto ci sia di vero nel racconto che emergerà, dirò semplicemente: è tutto vero ed è tutto falso, non ho inventato nulla e allo stesso tempo ho cambiato tutto. E se un giornalista un giorno venisse da me, microfono alla mano, e mi chiedesse qual è il rapporto tra realtà e fantasia, potrei rispondergli che è come in un’intervista: si cerca di indagare attraverso la finzione, attraverso una finzione di ruoli e di maschere. In fondo la verità non interessa a nessuno, la gente vuole solo del materiale su cui costruirsi un proprio credo, e le interviste, come tutto il resto, potrebbero anche essere tutte inventate. Non esistono domande adeguate e domande inadeguate, esistono solo due persone e la loro volontà di comunicare. Perciò non so se ho conosciuto Elena Duse, non so se ho davvero colto il segreto del suo talento, ma mi sono specchiato in lei e ho imparato qualcosa di me. E allora io ho posto le domande, ma chi ha intervistato chi?
 Una volta fuori mi saluta con un abbraccio energico e sentito, come se ci conoscessimo da una vita. Quell’abbraccio mi infonde una sensazione di speranza, perché se due estranei possono incontrarsi, parlare e poi scambiarsi un abbraccio così, senza riserve, significa che siamo tutti meno soli di quel che crediamo.
Una volta fuori mi saluta con un abbraccio energico e sentito, come se ci conoscessimo da una vita. Quell’abbraccio mi infonde una sensazione di speranza, perché se due estranei possono incontrarsi, parlare e poi scambiarsi un abbraccio così, senza riserve, significa che siamo tutti meno soli di quel che crediamo.
Prima che si allontani le faccio un’ultima domanda: ti è piaciuta l’intervista?
Mi risponde: molto.













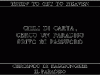




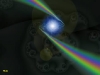


















Commenti
Non ci sono ancora commenti