 Fabrizio Gatti, editorialista dell’Espresso che deve la sua fama di giornalista d’inchiesta alla capacità di agire direttamente sul campo, mimetizzandosi con l’ambiente e tra le stesse persone che ci vivono, ha ricevuto recentemente il Premio Terzani 2008, uno dei riconoscimenti più prestigiosi per chi fa il mestiere del reporter. Un premio che gli è stato assegnato per il libro Bilal, il mio viaggio da infiltrato nel mercato dei nuovi schiavi: l’incredibile testimonianza di un occidentale che, spacciandosi per medio orientale, ha percorso quel viaggio che è spesso normalità per gli immigrati clandestini che incrociamo con indifferenza lungo le vie delle nostre città. Dal Senegal alla Libia, passando per Mali e Niger, il deserto perde, via via, sfumature mitiche, per assorbire quelle più amare della violenza e di ingiustizie senza fine. Il centro di accoglienza di Lampedusa, i campi di pomodori nelle Puglie, il mercato della prostituzione e dei manovali assunti in nero, nel nord Italia. Il ritorno in Libia, per accompagnare gli espulsi dal nostro paese, lungo il viaggio di ritorno nel deserto. Tutto questo solo per fare del giornalismo e fornire servizio alla verità, in tutti i suoi aspetti. Una verità giornalistica ben lontana da qualsiasi luogo comune o dalla superficialità, ben patinata, dei linguaggi politici.
Fabrizio Gatti, editorialista dell’Espresso che deve la sua fama di giornalista d’inchiesta alla capacità di agire direttamente sul campo, mimetizzandosi con l’ambiente e tra le stesse persone che ci vivono, ha ricevuto recentemente il Premio Terzani 2008, uno dei riconoscimenti più prestigiosi per chi fa il mestiere del reporter. Un premio che gli è stato assegnato per il libro Bilal, il mio viaggio da infiltrato nel mercato dei nuovi schiavi: l’incredibile testimonianza di un occidentale che, spacciandosi per medio orientale, ha percorso quel viaggio che è spesso normalità per gli immigrati clandestini che incrociamo con indifferenza lungo le vie delle nostre città. Dal Senegal alla Libia, passando per Mali e Niger, il deserto perde, via via, sfumature mitiche, per assorbire quelle più amare della violenza e di ingiustizie senza fine. Il centro di accoglienza di Lampedusa, i campi di pomodori nelle Puglie, il mercato della prostituzione e dei manovali assunti in nero, nel nord Italia. Il ritorno in Libia, per accompagnare gli espulsi dal nostro paese, lungo il viaggio di ritorno nel deserto. Tutto questo solo per fare del giornalismo e fornire servizio alla verità, in tutti i suoi aspetti. Una verità giornalistica ben lontana da qualsiasi luogo comune o dalla superficialità, ben patinata, dei linguaggi politici.
Abbiamo incontrato Fabrizio, a Udine, nell’ambito del Premio Terzani, e abbiamo scoperto, oltre al giornalista etico, una persona estremamente disponibile, pronta ad ascoltare chiunque, di una generosità traboccante. L’intervista che presentiamo è il frutto di una mezz’ora rubata durante il palinsesto della manifestazione, e conclusasi grazie alle sue telefonate in redazione. Proponiamo solo parte del materiale, perché a metterlo in rete per intero, ne salterebbe fuori un’intervista a puntate. La costante attenzione per gli ultimi, che siano immigrati o precari del lavoro, lo confermano meritoriamente uno dei giornalisti più onestamente vicini a quella base sociale che regge ancora in piedi il nostro paese.
PGM: Premio Terzani, Udine, occasione meravigliosa per incontrare un viaggiatore, Fabrizio Gatti. Apro con un quesito che mi sembra doveroso: con il tuo mestiere stai recuperando e riportando in auge la figura di un giornalista d’altri tempi, dedito all’inchiesta e all’analisi approfondita nel sociale. Qual è la tua formazione e dove si radica questa esigenza?
FG: La mia formazione è quella di tanti ragazzi: ho fatto il liceo scientifico, poi mi sono iscritto all’università, dove ho studiato geologia, senza finirla. Per un breve periodo sono stato in Accademia Aeronautica perché il mio sogno era quello di fare il pilota di caccia o il giornalista. Mi avevano anche preso, ma dopo circa un mese, proprio nella fase iniziale, mi sono reso conto che la vita forse meritava qualche viaggio in più e qualche volo in meno.
Poi lo spartiacque: una mattina, aprendo il Corriere della Sera , in terza pagina, c’era un reportage di Luca Goldoni che raccontava l’Africa, dopo aver raggiunto dei villaggi nel cesto di una mongolfiera. In qualche modo mi sono identificato in quel viaggio; mi sono detto: se da giornalista posso vedere il mondo in questo modo, da militare ne vedrei sicuramente molto meno. Quindi ho cominciato come corrispondente per un quotidiano locale, e poi, dopo 3 anni, sono stato assunto al Corriere della Sera , dove ho passato altri quindici anni. Ora lavoro per L’Espresso .

Il mio percorso è stato soprattutto un percorso a colpi di fortuna. Certo, uno ci mette anche del suo ma, indubbiamente, ho avuto una gran fortuna: quella di iniziare a fare il giornalista in un particolare momento storico, ad esempio, o finire in redazioni accanto a grandi giornalisti, più o meno conosciuti — la notorietà non definisce mai la persona, in nessun settore — persone da cui ho cercato di apprendere onestà, umiltà e curiosità. Curiosità che poi è un sentimento innato: mi ricordo che da bambini risalivamo i torrenti perché eravamo curiosi di scoprire quale fosse il sasso più alto; una volta siamo rimasti bloccati tra una cascata e un dirupo e abbiamo impiegato un’ora per uscire da quel pasticcio: questa è la curiosità.
Poi va aggiunta un’esperienza tecnica che a mano a mano si sviluppa. La grande opportunità che ho avuto, se dovessi confrontarmi con colleghi che iniziano oggi o che hanno cominciato da qualche anno, o con chi non riesce neppure ad averla un’opportunità, è quella d’essere stato messo alla prova.
Il mondo del lavoro oggi non dovrebbe sfruttare i giovani con contratti a termine, ma dovrebbe semplicemente metterli alla prova: è da lì che escono i talenti; io ho cercato di dare il meglio di me, ma l’ho potuto fare perché qualcuno mi ha messo alla prova. Io ho avuto il mio primo contratto a tempo indeterminato al Corriere della Sera a ventiquattro anni, ci sono giornalisti che a trentatre anni sono ancora con contratti a termine, ancora con la vita sospesa tra una scelta e l’altra; sono perfettamente consapevole che se avessi tentato di fare il giornalista in un periodo simile a quello odierno, probabilmente farei un altro mestiere, perché a trentatre anni non mi sarei potuto permettere di avere ancora un lavoro precario.
Il giornalismo, tra l’altro, è un caleidoscopio, perché a volte riesci a ribaltare la realtà. Faccio un esempio: i giovani giornalisti, ma non solo, sfruttati nelle redazioni senza contratto di lavoro, vengono chiamati abusivi, come se fossero loro i colpevoli della propria situazione, come se fossero loro gli abusivi, mentre in realtà si tratta di lavoro nero. Ripeto: sono capitato in un momento buono, sono stato molto fortunato, soprattutto nell’aver incontrato grandi maestri che si sono messi sotto l’ala un pivellino che non conoscevano e gli hanno detto: prova a fare questa notizia, sviluppa questa storia e vediamo cosa succede. In una situazione del genere ti tremano le mani, perché senti addosso una gran responsabilità.

PGM: Passiamo al viaggio: Senegal, Mali, Niger; al principio il libro prende l’abbrivio di un racconto di viaggio; lo si nota principalmente dal ritmo dettato dai passi brevi, dalle veroniche attente. Lì c’è ancora il Fabrizio viaggiatore a parlare, pronto ad aprirsi, a diluire i propri confini personali per incontrare la realtà del continente nero in movimento verso l’Europa. Da dove è partita l’idea di un viaggio del genere e quali sono state le motivazioni? Perché all’inizio del libro si denota il ritmo di un viaggio qualsiasi…
FG: È vero. All’inizio sembra un viaggio qualsiasi, con dei mezzi di trasporto un po’ faticosi ma normali: il treno, l’autobus, il taxi de brousse, una sorta di pulmino molto affollato con cui si viaggia e ci si sposta. Ma devo tornare all’Italia per spiegarti la motivazione del viaggio: ho sempre avuto la consapevolezza che i mezzi di informazione italiani (anche europei, ma parliamo dell’Italia ora) sono responsabili di una deformazione nel rappresentare l’immigrazione. Se ne parla spesso, ne ho parlato anch’io nel giornale per cui lavoravo prima, il Corriere della Sera , quando gli immigrati sono responsabili di reati, ma il reato è un fatto che a volte è legato proprio all’immigrazione; non dimentichiamo, ad esempio, che gli italiani hanno esportato la mafia nel mondo, non tutti, ma una parte sì. Insomma, mi ero reso conto che, a forza di parlare di immigrati soltanto in occasione dei reati compiuti, eravamo innanzitutto disonesti nei confronti dei lettori; ne parlai per la prima volta al mio caporedattore di allora, al Corriere della Sera , Giangiacomo Schiavi — un bravissimo caporedattore — e gli spiegai questo problema.
Lui se ne rendeva conto e mi disse: va bene, ma cosa proponi? Dissi che oltre alle interviste — spesso umilianti, perché vai a chiedere a una persona di raccontarti quelle condizioni di vita che solitamente vorrebbe nascondere — dovevo trovare una baraccopoli e finirci dentro: se mi dai una decina di giorni, io te la racconto di giorno e di notte. Se io faccio l’intervista, la sera vado a casa a dormire; se invece sto dentro alla braccopoli a dormire, secondo me, scopriamo cose che non ci immaginiamo nemmeno. Quello è stato l’inizio, e da quel momento è iniziato un percorso interminabile, perché dopo la baraccopoli, c’è il centro di detenzione, dove i giornalisti non li fanno entrare. Allora incominci a fare piccoli tratti, per scoprire che c’è un percorso pazzesco, mostruoso, che affronta degli spazi che sono nel mito, non sono nemmeno nella realtà.
Il deserto: che cos’è il deserto? Il deserto è sabbia, è vuoto, ma il deserto è anche un viaggio nella testa. Vedevi arrivare persone, le vedevi sbarcare, le vedevi morire. Un altro enorme quesito, è stato: ma noi, cosa conosciamo di questo viaggio? Nessuno l’aveva fatto, se non i protagonisti, e mi rendevo conto che quando chiedevo spiegazioni, racconti, testimonianze ai protagonisti di questo viaggio, persone sbarcate a Lampedusa, ad esempio, mi rendevo conto che tentavano di nascondere gli aspetti più violenti dell’esperienza. Io intuivo — soltanto — l’esistenza di certi aspetti violenti.
Se poi insistevo con le mie domande diventavo un guardone, un voyeur, quasi pretendendo che loro si aprissero con me nel giro di pochi minuti o di qualche ora. Giunta sera, io me ne andavo a dormire a casa mia, loro se ne andavano a dormire sotto i ponti, oppure in quaranta in uno scantinato, come accade a Milano, e alla fine mi chiedevo: sono un guardone io? No, devo essere un osservatore: noi non sappiamo nulla.

Così cominciai a studiare i percorsi che nessuno conosceva con precisione. Mi sono studiato le carte del deserto e con qualche domanda mirata sulle loro provenienze, ho potuto sapere da dove si parte, e così via. Ad un certo punto la mia testa viaggiava; ed è quello che racconto nel libro: la separazione tra corpo e testa. La mia testa era già in viaggio, vedevo gli sbarchi e le persone inquadrate a Lampedusa, e quasi, quasi – in un contesto di conoscenza — li invidiavo perché sapevo che loro conoscevano l’esperienza epica del loro viaggio, mentre io ero ancora un somaro da quel punto di vista.
Tutti noi non sapevamo nulla delle sofferenze di quel viaggio. Era un viaggio che dal punto di vista fisico valeva milioni di Coppe dei Campioni: noi celebriamo lo sforzo fisico di un certo tipo, ma applicando la legge diamo delle punizioni severe, come l’espulsione o l’arresto, a persone che hanno compiuto un viaggio senza nemmeno chiedergli che cosa sia quel viaggio. Se non volevo essere un guardone, se volevo fare il giornalista fino in fondo, se volevo conoscere e in qualche modo ripercorrere il fiume fino alla sorgente, dovevo andare alla sorgente e seguire il fiume.
Poi c’è stata una motivazione personale: il libro è un’altra cosa, estende i reportage; il libro è molto di più: sono emozioni, è scritto con un taglio narrativo, come se fosse un romanzo. Però dentro non ci sono personaggi: ci sono persone. Quando qualcuno muore, muore davvero. Questo per prendere per mano il lettore e dirgli: vieni a vedere che cos’è questo viaggio. Non voglio interferire con le tue idee politiche, pensa come vuoi, però secondo me è importante che tu sappia, che tu conosca. Ti prendo per mano e ti porto con me dentro le piccole cose. Nel mio intimo, intraprendere il viaggio significava pagare un prezzo personale per poter guardare negli occhi le persone che lo facevano davvero, con un minimo di dignità da parte mia, altrimenti li avrei dovuti abbassare ogni volta.

Io mi considero privilegiato due volte; primo perché da giornalista ho avuto modo di vivere in prima persona emozioni drammatiche, forti, terribili, e a volte bellissime; e secondo, perché durante il viaggio non ho messo in gioco la mia vita. Certo qualche rischio me l’ero preso, però nell’intraprenderlo sapevo che stavo tornando a casa.
È sorta, inoltre, una domanda fondamentale: perché quando si arriva in Libia, o in Tunisia, e si vedono delle barche che hanno dei buchi giganteschi sul fondo dello scafo, o delle crepe, oppure ci sono già ammassate sopra trecentocinquanta persone, c’è qualcuno che sale lo stesso? Qual è la spinta che fa dimenticare la paura di morire annegati? Mi sono convinto, allora, che alle spalle ci fosse una paura ancor più forte della paura della morte, che è quella di provare la morte da vivi, o quella di aver visto vicino a sé la morte da vivi. Da quello che ho visto, quando non si ha più modo di andare avanti, quando si ha fame, ci si trova dinnanzi a una morte ben peggiore, perché essendo vivi si prova sofferenza. Si crea questo distacco mostruoso tra il corpo e la mente: la mente vuole andare, sogna ancora: vorrebbe essere in Francia, in Gran Bretagna — qualcuno anche in Italia, o almeno in Libia, a lavorare — invece il corpo ha delle sue necessità: deve mangiare, deve essere sano, deve bere; e per mangiare bere ed essere sani servono soldi. Servono soldi anche per spostare il corpo. La mente viaggia da sola, per spostare il corpo bisogna pagare dei trafficanti.
Quando i soldi, vero carburante del viaggio, sono finiti è finita: si è stranded. Questa è una cosa che avevo intuito prima di partire, ma non pensavo che fosse così determinante; quando sali sul camion è come se tu consegnassi la tua vita al trafficante, all’autista, ci stai sopra e aspetti; quando arrivi a destinazione lui te la restituisce. Non è un gesto visibile, è un gesto simbolico: te ne riappropri quando salti dal camion e sei per terra, per terra su un punto d’arrivo, non nella sabbia. Nella sabbia sei ancora in sospensione. Così ho scoperto, in questo viaggio, che non esiste un’immigrazione, ma che esistono degli individui, dei singoli.
Noi forse sbagliamo a parlare di immigrazione, e non ci sarà nessuna norma, nessuna legge che possa risolvere il problema,mantenendo, tra l’altro, un’economia illegale nel nostro paese che richiama lavoratori comunque al di là della legge. È impensabile provare a chiudere le frontiere, perché il viaggio diventerà più duro, più costoso, più mortale, ma continuerà: non è un viaggio di disperati — noi spesso lo chiamiamo così — si è disperati all’inizio, ma quando parti per superare quella fatica immane ed epica del trasferimento nel deserto, non bisogna aver paura, e per superare la paura ci vuole coraggio. Ma se questa non é speranza, cos’altro deve esserlo?
Quindi ho cominciato a ribaltare il mio punto di vista culturale. Non si tratta degli ultimi, non si tratta di immigrazione o di solidarietà, si tratta di una questione di diritto, storica ed economica. Diritto perché è una questione di rispetto della dignità delle persone e dei diritti degli individui; storica perché è la storia di questo momento che ha messo in moto le masse nel mondo, come è successo in passato tante altre volte; economica perché noi, con la nostra economia illegale, richiamiamo persone che comunque vogliono migliorare la loro condizione.
All’inizio del viaggio, quindi, sono Fabrizio Gatti, ma poi arrivato là in mezzo sono Bilal. Ad un certo punto succede che non so più nemmeno io che cosa sono: sono là in mezzo come se fossi un registratore o una telecamera. Avevo salvato una piccola digitale, cercavo di memorizzare, mi scrivevo degli appunti di nascosto. L’aspetto più drammatico, quello di cui nessuno, nemmeno i miei compagni di viaggio, aveva consapevolezza, è che quando sei in mezzo al deserto scopri che non sei tu a fare il viaggio, ma è il viaggio che sta facendo te. A quel punto sei come in balia della corrente: vai, vai, e vai, e non sai neanche dove stai andando.

PGM: Mi ha colpito una frase del libro, quando dici che in questo momento, in Africa, si sta mettendo in atto la diaspora della migliore generazione africana. L’opinione pubblica italiana ha sempre l’idea che queste persone migranti siano gli ultimi, i disperati; invece sono persone di grande qualità. Potresti descrivere, fare una sorta di affresco, della miglior gioventù, della miglior generazione africana?
FG: Possiamo benissimo fare un parallelo con i friulani che sono andati nel mondo. Io, dalla parte friulana della mia famiglia, ho degli zii che sono emigrati, mia madre stessa è partita dal Friuli. C’è stato un momento della loro vita, così come ho visto spesso in Africa, in cui c’è uno spartiacque: ti rendi conto che il tuo futuro non può più essere lì dove sei nato, dove hai cominciato. Perché è la migliore gioventù? Certo, non vuol dire che chi resta sia peggiore, però è quella che, per fare una scelta del genere, ha dei progetti, una testa e delle idee talmente forti e radicate, che se va via è perché mancano i mezzi per realizzarle. O manca libertà. Oppure mancano le condizioni culturali: in alcune zone rurali dell’Africa, le donne partono per uscire dalla chiusura culturale dei loro villaggi. Poi c’è la preparazione personale: io ho incontrato, nel viaggio africano, studenti e laureati.
Un aspetto formidabile è il fatto che tutti abbiano consapevolezza di esistere in un villaggio globale: la dimostrazione sta nel fatto che quando si parlava, ci si presentava, ci si parlava per conoscersi. Anche se io me ne stavo intabarrato in un turbante verde e nel boubou, il camicione lungo da tuareg — nonostante io sia piccolino, non certo alto come un tuareg — alla fine vedevano le mie mani bianche e si incuriosivano, mi spiegavano i loro progetti o i motivi che li spingevano a partire: Perché sono il solo uomo di famiglia. Perché qualcosa dovevo fare per i miei figli o per mia moglie. Chi non aveva una famiglia, partiva semplicemente perché aveva delle idee da realizzare; un ragazzo mi diceva: siccome l’Italia ha un’ottima produzione di abbigliamento, mentre in Nigeria, dove sto io, non ce n’è, vorrei venire da voi, lavorare un po’ e poi aprire un’attività di import-export con la Nigeria, in modo da portare, nel mio paese, le scarpe e i vestiti italiani. Altri avevano un diploma di studi professionali superiori.
Chi non aveva studiato aveva comunque l’idea di realizzare qualcosa, perché per partire ci vuole una grande idea, un grande progetto. Chi dorme sul posto e non ha nemmeno i mezzi di sussistenza non può nemmeno elaborare l’idea di un mondo di fuori, anche perché non ha i mezzi per conoscerlo, mentre chi viaggia lo conosce attraverso internet. Una delle prime cose che mi venivano chieste era il mio indirizzo e-mail, da parte di chi mi lasciava il suo. Certo era un posto virtuale, ma comunque una casa fissa; molto spesso mi sono sentito dire: così mi mandi le foto, e se muoio durante il viaggio la mia famiglia mi potrà vedere e ricordare; oppure: mi mandi le foto, in modo che possa conservare un ricordo di questo viaggio, che altrimenti non avrei; o più semplicemente per tenersi in contatto, per farsi dare una mano se fossero arrivati in Italia. Ho imparato che non esiste un solo motivo all’immigrazione: le motivazioni sono molteplici.
Non esiste un’immigrazione, ne esistono tante, e tantissime persone esprimono con il viaggio la loro ambizione o la voglia di fuga da una realtà. Se vado indietro negli anni a rivedere le esperienze di viaggio degli italiani, vedo che si tratta di persone che avevano grandissimi progetti; poi qualcuno, dal Friuli magari no, ma dall’Italia è scappato perché aveva delle attività criminali da nascondere, può capitare: anch’io ho incontrato criminali nel mio viaggio, ma questo non vuol dire che tutta l’immigrazione sia criminale. È l’umanità: la criminalità fa parte dell’umanità; una parte piccola, ma c’è. Ma c’è soprattutto quest’idea grandissima di costruire un futuro da qualche parte che non conoscono nemmeno bene, di cui hanno appreso in maniera un po’ superficiale, attraverso, che ne so, George Weah, il calciatore liberiano, la TV che arriva, i giornali, il calcio in genere, i turisti. Il turismo è un punto di contatto pazzesco, perché i turisti creano legami che spesso si sviluppano: legami di amicizia, di aiuto, a volte anche di pagamento del viaggio. Ho incontrato un ragazzo che aveva addirittura ricevuto per vaglia i soldi per il viaggio, grazie al regalo di una ragazza bulgara che non aveva mai conosciuto. L’aveva incontrata su una chat, e lì le diceva che il suo sogno era arrivare in Europa, finché lei non gli ha mandato i soldi con Western Union, e lui è partito.
 PGM: Mi piacerebbe ritornare al ritmo e allo stile del libro, perché secondo me è una cartina di Tornasole del viaggio stesso. C’è un punto fondamentale, quando subisci il furto, in cui qualcosa cambia, e per motivi insondabili ti affidi — scusa se lo cito, ma questo lo faceva anche Kapuscinsky — alle persone più semplici. Sono loro che ti insegnano quello che sta accadendo nei dintorni del viaggio — mi viene in mente il tuo discorso sugli sceicchi che vanno a caccia di antilopi e ghepardi in via d’estinzione nell’Air — In questo libro non esiste un “pezzo grosso”: ci sono persone trascurate dal mondo infame che è, di fatto, questa nuova tratta degli schiavi, e tu riesci ad avvicinarti proprio a quelli. Traspare una grande umanità, ma ti è venuto naturale, oppure ti sei preparato prima per indirizzare la tua attenzione verso gli ultimi?
PGM: Mi piacerebbe ritornare al ritmo e allo stile del libro, perché secondo me è una cartina di Tornasole del viaggio stesso. C’è un punto fondamentale, quando subisci il furto, in cui qualcosa cambia, e per motivi insondabili ti affidi — scusa se lo cito, ma questo lo faceva anche Kapuscinsky — alle persone più semplici. Sono loro che ti insegnano quello che sta accadendo nei dintorni del viaggio — mi viene in mente il tuo discorso sugli sceicchi che vanno a caccia di antilopi e ghepardi in via d’estinzione nell’Air — In questo libro non esiste un “pezzo grosso”: ci sono persone trascurate dal mondo infame che è, di fatto, questa nuova tratta degli schiavi, e tu riesci ad avvicinarti proprio a quelli. Traspare una grande umanità, ma ti è venuto naturale, oppure ti sei preparato prima per indirizzare la tua attenzione verso gli ultimi?
FG: Guarda: questa è una mia convinzione. Tra un’intervista a un ministro e l’intervista a un operaio della Fincantieri che lavora e suda tutti i giorni con contratti a termine, ho sempre preferito intervistare l’operaio, mai l’ufficialità. Secondo me la realtà sta lì. Questa era un po’ un’impostazione del mio lavoro che avevo già in Italia, quando ero andato a vivere nelle baraccopoli. Ecco perché è importante che questo racconto provenga da un italiano che parla soprattutto agli italiani, e non solo da un protagonista del viaggio; perché se riesco a raccontarti il viaggio secondo le categorie di pensiero e le emozioni “nostre”, magari una tazza da thé ricevuta in regalo da un ragazzo prima di partire, come racconta di se stesso Stephen, una delle persone che ho incontrato, mentre per lui è solo una tazza da thè, per me è un ponte: tutti noi alla mattina prendiamo una tazza da thè, da caffé, ma per lui quella è l’unico contatto con le sue radici, con la sua casa, la sua fidanzata. Lui era stato derubato di tutto dai militari: gli era rimasta solo questa tazza da thè.
Vado a cercare le piccole cose perché, ad esempio, nell’arte mi piace l’impressionismo: piccole pennellate che da sè non dicono nulla, ma nell’insieme danno un quadro formidabile. Prima di partire avevo paura, ho passato delle notti insonni perché mi dicevo: ma se muoio nel deserto, se resto senz’acqua? Poi mi sono preso delle precauzioni studiando diari di viaggio di vecchi esploratori, Heinrich Barth nel 1845, però avevo paura. Quando sono arrivato in Senegal ero ancora alle prime armi; dopo tre giorni e tre notti di viaggio, alla terza notte, c’è l’attacco al treno e mi sparisce una parte importante per il mio lavoro: la macchina fotografica con i rullini. Mi son detto: se alla terza notte mi è già successo questo, dopo un mese sparisco io.
A quel punto non mi sono nemmeno arrabbiato: sarebbe stato ridicolo; ero io a dover accettare le regole del gioco. Quello è stato lo scossone che mi ha fatto capire di non essere più in Europa: ero in una realtà in cui mi giocavo tutto, momento per momento. È forse in quel momento che sono diventato finalmente Bilal: è stato proprio il momento in cui non mi sono più sentito Fabrizio Gatti, perché casualmente mi chiamo così, perché hanno deciso di chiamarmi così, con un cognome così… Bilal ho scelto io di esserlo. Durante il viaggio e in quelle condizioni, di pezzi grossi non ne avrei mai trovati; ho incontrato Madama Hope, la grande boss dell’organizzazione del traffico, però il mio scopo era far parlare più persone possibili. Ecco perché parto da Dakar: facendo questa rotta Ovest-Est, in realtà volevo intercettare altre rotte.
È da quel momento che il viaggio ha cominciato a fare me stesso, e a quel punto dovevo rivolgermi semplicemente alle persone che avevo intorno: non ce n’erano altre. Era un mio tentativo far parlare queste persone, ma assolutamente non avevo alternative, e tra l’altro non l’avrei nemmeno fatto: soltanto lì dentro, in quel momento, dovevo giocarmi il mio viaggio e dovevo semplicemente accettare — secondo uno spirito africano — il non dire caspita quanti problemi sto incontrando, ma sostituirlo col quante soluzioni sto trovando. È un modo di essere che davanti a tante difficoltà aiuta moltissimo.
PGM: Ho sentito dire da qualcuno che non ricordo, che i buoni non temono di fronte all’abisso. In questo libro, che parte come libro di viaggio, ma diventa un’inchiesta, ci sono due figure che mi piacciono tantissimo e che hanno anche due lettere molto belle per iniziali. Una elle maiuscola che ripeti spesso come una Lei, e la ipsilon di Yaya. La Lei diventa nel libro quasi un’ideale àncora di salvataggio, anche se lontana, mentre a Yaya, il tuareg, ti affidi quasi per istinto ad Agadéz. Volevo chiederti se la scelta di un tuareg come guida, è partita dal fatto di sapere che sono uomini di grande onorabilità.
FG: No, Yaya è semplicemente una persona. Io mi sono affidato a lui, ma nel contempo lui si è ciecamente affidato a me, perché per un lungo periodo abbiamo condiviso la stessa esperienza, abbiamo corso gli stessi rischi.

PGM: L’avevi conosciuto prima?
FG: No, no, l’ho conosciuto durante il viaggio di andata, l’ho conosciuto in quella circostanza, anzi, lui forse ha corso qualche rischio in più, quando, ad esempio, siamo incappati nei mujaheddin di Alkeida, lì ha corso un rischio che nessuno gli aveva chiesto, per cui non è perché sia tuareg che l’ho scelto. A un certo punto avevo bisogno di qualcuno che conoscesse quelle piste, non sapevo bene a chi rivolgermi e mi è venuta l’idea di provare a chiedere al gruppo di tuareg che avevano combattuto negli anni precedenti in quella zona, e quindi la conoscevano bene. Yaya innanzitutto è un uomo che, ripeto, ha forse rischiato di più, perché se lui era per me uno sconosciuto, io lo ero per lui.
PGM: . E invece di Lei cosa mi dici? C’è una bellissima frase che a un certo punto ti rivolge via sms: avrò un bel da fare per farti guarire da questa follia. È una figura invisibile che diventa punto cardinale, sia per Fabrizio che per Bil Al.
FG: Ciascuno dei viaggiatori che ho incontrato aveva la sua ancora mentale o il suo punto cardinale da qualche parte. Per me… era la mia famiglia, casa insomma. Tra l’altro io stavo viaggiando verso nord, quindi verso casa, mentre i miei compagni di viaggio si stavano allontanando da casa loro. L’idea di usare la lettera maiuscola, oltre che un’evidenza grafica rispetto al resto, mi è servita proprio per indicarla come se fosse un punto di riferimento, ma non è mia. L’avevo già vista usare in questo modo da quel grandissimo scrittore italiano che è Ennio Flaiano, in un libro stupendo sulla guerra che si chiama Tempo di uccidere. Lui, soldato in Africa orientale, ogni tanto scrive alla sua Lei; del resto dentro di noi non serve ripetere un nome, già sappiamo chi è, ciascuno di noi, anche chi legge, ha la sua Lei e ovviamente se è una lettrice avrà il suo Lui, ma insomma fa poca differenza saperne il nome, l’importante è che ci sia un punto di riferimento.
PGM: Su questa lunga via migratoria che dal deserto tira verso il Mediterraneo il tagelmust, il velo usato dai Tuareg, aiuta a nascondere le tristezze che vivi. Però mi ha colpito una cosa: ripeti spesso, durante il viaggio, questo paragone, tra le navi dell’Ottocento, cariche di italiani che andavano verso la fortuna e queste generazioni, questi nuovi emigrati. C’è qualcosa nel tuo DNA che ti ha portato a ripetere spesso questo paragone?
FG: Non credo sia una questione di DNA. È semplicemente un paragone importante, un confronto, o più che un confronto, un riferimento importante da fare per far capire che quanto stanno vivendo ora altri come luogo di arrivo, l’abbiamo fatto anche noi da protagonisti, portando fuori il bene e il male della nostra società. L’atto di muoversi e viaggiare, quando le condizioni di un luogo non consentono più di restare, sarà sempre parte del DNA degli uomini; il concetto di stanzialità, spesso, è soltanto un particolare nella vicenda storica dell’umanità. Perché gli uomini sanno essere anche nomadi quando è necessario.
 PGM: Dopo aver letto il libro di Bil Al e di Fabrizio, è possibile guardare negli occhi sempre allo stesso modo i ragazzi che incontriamo nelle nostre città?
PGM: Dopo aver letto il libro di Bil Al e di Fabrizio, è possibile guardare negli occhi sempre allo stesso modo i ragazzi che incontriamo nelle nostre città?
FG: Non lo so, io l’ho scritto, bisognerebbe chiederlo a chi l’ha letto! Io mi sento privilegiato per aver fatto questo viaggio e, soprattutto — anche se non so se questa sfumatura verrà colta — per aver avuto l’opportunità di far vedere come ciascuno di noi, sia che sia un viaggiatore, sia che abbia la fortuna di non muoversi mai da casa sua, porta comunque dentro di sé un libro di racconti. Noi dovremmo imparare — la scuola qualche volta lo ha fatto, ma spesso non lo fa — a considerare ogni persona come un libro di storia e chiunque di noi, anche se ha fatto un lavoro che è considerato poco avventuroso o poco interessante, in realtà è il libro della propria vicenda personale, per cui il mio viaggio è stato un continuo cercar di sfogliare le pagine delle storie degli altri. Così mi succede che, guardando negli occhi una persona — ma questo mi accadeva anche prima, è anche il mio lavoro che mi porta a fare questo, o la mia curiosità stessa — io vedo ogni persona come un libro della propria storia. Conto nel concetto fondamentale che è il restituire personalità a chi fa il viaggio, e spero che anche chi legga viva questa grande opportunità, perché è un’opportunità formidabile: trovarsi davanti alla storia di qualcun altro e saperla leggere, o perlomeno rispettare.
PGM: Il tuo libro è sicuramente qualcosa che analizza anche situazioni socio-politiche. Ritorno ai tuareg, nel senso che in questo mondo così chiuso, pieno di confini, che ostacola i viaggi, i tuareg si sono da sempre abituati a non aver confini, esempio ne siano le loro carovane del sale. In un tratto del racconto, affermi che quando uno parte nel deserto, non gli è possibile incontrare ostacoli, perché deve arrivare a destinazione. Oggi i tuareg sono ritornati a combattere per questo diritto; perché se ne parla così poco, soprattutto in Italia, mentre in Francia o in altri Paesi lo si fa di più, considerando che la popolazione tuareg è un dichiarato patrimonio dell’umanità?
FG: Secondo me se ne parla poco in Italia, perché in Italia si parla poco di tutto, se non del proprio ombelico. È come se il nostro Paese, da un certo punto in poi della sua storia recente, avesse cominciato a disinteressarsi del mondo intorno, ritenendo i problemi interni superiori a quelli di tutti gli altri.
PGM: Torniamo un po’ allo stile del libro; è come se ci fosse una sorta di metamorfosi che, dal viaggiatore, dove parli in prima persona, lasci la voce agli altri. È incantevole la parte dove Bilal si è incarna in Fabrizio e lascia spazio e voce alle mail, soprattutto a quelle di Joseph e James. Quanto peso dovremmo dare, e in che modo potremmo dare più peso alle voci di questi ragazzi incredibili, che tu definisci giustamente eroi? C’è la possibilità di imbastire una comunicazione più profonda, più diretta, più umana?
FG: Guarda, la questione di fondo è che siamo noi la causa della loro clandestinità, perché noi abbiamo stabilito delle norme che, tra l’altro, proprio in questi giorni vengono rese più difficili da rispettare. È in base a queste norme che noi stabiliamo se una persona ha diritto o no di esistere, ma nello stesso tempo approfittiamo della presenza di queste norme. Io non ne condivido l’idea, il principio. Secondo me va rivista, innanzitutto, la centralità dell’uomo e della donna, cominciando a restituire umanità, e quindi identità e personalità, a chi ha fatto un viaggio del genere. Partendo da questo differente punto di vista, si può cominciare a capire il perché è stato fatto questo viaggio, analizzare come la nostra economia incida, e in quale modo richiami persone attraverso la diga della clandestinità, ma senza offrire alternative. La dimostrazione è il “pacchetto sicurezza” di questi giorni: è inevitabile parlare delle nostre decisioni politiche, laddove si punisce con il carcere il clandestino, si punisce addirittura con il carcere chi ospita un clandestino — o giustamente potremmo anche dire — ma non si prevede nessuna punizione nei confronti di chi sfrutti il clandestino.
Nel diritto italiano, tra la violazione amministrativa, nel maggiore dei casi quella d’impiego di manodopera non regolare che si riduce in sostanza a una multa, e la riduzione in schiavitù — e purtroppo si sono verificati anche di questi fatti — che però comporta la manifesta intenzione a considerare l’altro, a trattare il dipendente come schiavo, quindi privandolo di documenti, del passaporto, della libertà, a volte perfino con azioni violente, c’è un vuoto legislativo che ancora una volta la politica non ha voluto riempire con delle norme. Perché? Perché questo vorrebbe dire mettere in crisi la nostra economia, soprattutto agricola ed edile. Bisognerebbe partire, invece, da un aspetto filosofico importantissimo; restituire, cioè, personalità e umanità — anzi — riconoscere più che restituire, perché in fin dei conti non dobbiamo restituire proprio nulla, se è qualcosa che abbiamo rubato, no? Riconoscere, quindi, che l’umanità a cui appartengono gli individui dopo che hanno intrapreso questo viaggio, non è fatto di clandestini ma di persone. Da qui andare a sviscerare anche gli aspetti tecnici, ossia andare a vedere qual è il motore che muove tutto.

PG: L’ultima parte del libro, è la più dolorosa per noi, in quanto fai un’analisi obiettiva, ma acuta e spietata, di quella che è la nostra coscienza collettiva; nel senso che metti a nudo la scarsa civiltà che, spesso, aldilà delle retoriche, come popolo italiano dimostriamo. C’è un punto dove dici, nel 1992 sono stati chiusi gli zoo grazie all’indignazione della gente, ma si è aperta la più grande opera di tensione e deportazione mai avvenuta, dopo la seconda guerra mondiale, nella società civile. Ti faccio una domanda difficilissima…mostruosa..: siamo realmente una società civile?
FG: Ritengo di sì, perché comunque siamo una democrazia, e la fortuna o sfortuna di una democrazia è che ci dobbiamo guadagnare, giorno per giorno, la nostra libertà e le regole chiave che permettano il buon funzionamento della nostra società. Per cui ritengo che noi siamo una società civile, ma che dentro una società civile vi siano molte persone incivili. Ci sono dei momenti in cui le regole vengono dettate da… la chiamerei, inciviltà: inciviltà proprio nel senso diseducativo, dell’ignoranza e della violenza.
In questo viaggio ho visto che la violenza è sempre lì pronta, in agguato, a intervenire nelle reazioni, negli stati d’animo, e in qualche modo ha coinvolto anche me in certi frangenti del viaggio. La civiltà è una specie di conquista, che parte dal riconoscimento dell’inciviltà in ogni essere umano. In ciascuno di noi, insomma, esiste civiltà e non civiltà, ed esiste un’inciviltà dei comportamenti. Non và mai perso di vista il fatto che il sistema sociale che ci siamo dati è perfettibile, lo diceva anche Popper: inventatene uno migliore, se non ce ne sono di buoni!
PGM: Però abbiamo sempre più paura; al di là del tuo libro, la nostra società sembra evidenziare sempre più un senso di timore dell’altro, del diverso, che finisce quasi per alimentare questa paura.
FG: Se pensiamo alle parole di Sigmund Baumann, la fine della guerra fredda avrebbe dovuto portare un grande cambiamento. Viviamo in un mondo che non dovrebbe avere assolutamente alcuna paura; è finita la guerra fredda, è finita la minaccia nucleare, le frontiere sono aperte. Proprio ruotando su questi cardini è cambiata la realtà del mondo. Io mi chiedo sempre, e questo forse emerge anche dal libro, quanto un popolo sia vittima delle decisioni dei suoi rappresentanti, e quindi debba in qualche modo accettare decisioni prese da una ristretta cerchia, o quanto sia responsabile delle decisioni che poi vengono delegate ai suoi rappresentanti. Be’, questa è una sorta di circolo vizioso al quale spesso non riesco a cavare una risposta: quanto la xenofobia è il risultato dell’ignoranza o di una scelta consapevole?
La xenofobia è un risultato di una propaganda propensa alla paura, per cui, alla fine, è la scelta consapevole di poche persone, che sfrutta l’ignoranza degli altri, a traghettare il senso comune verso la xenofobia, oppure è una scelta motivata dalla massa delle persone? A volte trovo risposta in un senso, a volte trovo risposta nell’altro. Questo è uno dei grandi dilemmi storici, se guardiamo alla storia tremenda dell’Europa del fascismo e del nazismo; è ciò che Primo Levi chiama la zona grigia. Perché alcune persone che si comportano secondo comportamenti civili e di altruismo, all’improvviso sono disposte a trattare degli uomini peggio che gli animali, le stesse persone che sono state ospitate nella loro città? Questo è un grandissimo dilemma; in realtà le risposte ci sono e ci sono anche risposte sperimentali. Secondo me, la grande responsabilità è di poche persone, ben consapevoli che usando la paura si può guadagnare potere; persone che altrimenti sarebbero rimaste semplicemente dei cialtroni da bar, e lo si è visto in parecchie occasioni, ma allo stesso tempo c’è anche una grande responsabilità del popolo: quella di lasciarsi fregare, non essere sufficientemente attento, perché il popolo ha una tremenda, feroce responsabilità in tutto questo.

PGM: Che poi sposta sempre questo tipo di responsabilità e la demanda ad altri; chi nei politici, chi alla stampa che non denuncia. Questo lo scrivi anche nel libro: emblematico il passaggio della telefonata di quella ragazza, simpatizzante di una certa politica di destra, ma che fidanzata di un extracomunitario, sposta la responsabilità dei guai che assieme devono affrontare, non su se stessa, o su una propria scelta elettorale, ma sui giornalisti che non denunciano la presenza, nella legislazione italiana, di regole inique ed insufficienti in tal senso.
FG: In realtà quella telefonata, ma soprattutto la chiusura di quella telefonata, attribuisce alla ragazza l’estrema responsabilità per quello che sta accadendo. Quella ragazza è un piccolo campione singolo della cosiddetta opinione pubblica, per cui lei ha dato un assegno in bianco alla politica, ma soltanto quando la politica è entrata in casa sua per espellerle il fidanzato se ne è accorta, tanto da non voler nemmeno ammettere d’averlo staccato quell’assegno in bianco, anzi, pretendendo e dando la colpa, infatti, ai mezzi d’informazione, per non averla informata a sufficienza. Democrazia, però, non vuol dire solo stare ad aspettare le informazioni, ma significa anche andarsele a cercare. Insomma, io l’ho fatto, facendo un viaggio molto lungo.
PGM: E sicuramente in forma non così inosservata e inosservabile. In tal senso volevo farti una domanda: tu non sei sicuramente un personaggio che passa inosservato, nonostante il tuo lavoro sia spesso sotto copertura, e anche il tuo libro credo che non sia passato inosservato. Allora, di fronte a fatti del genere, di fronte a dei dolmen così potenti, c’è stata qualche autorità, sindacato, chiesa, organizzazione umanitaria, che ti ha contattato per dirti: ma è davvero così, possiamo fare qualcosa?
FG: Sì, questo sì, adesso non mi chiedere di farti un elenco…devo dire che il fatto di lavorare all’Espresso mi rende facilmente rintracciabile. Io non ritengo di aver scritto o di aver pensato un dolmen. È un’esperienza così, mi ritengo più fortunato d’altri per aver vissuto e averla vista in diretta. Insomma, in qualche modo mi ci sono anche spinto io per vederla.
PGM: Nel senso che non c’è tanta gente che fa quello che fai tu?
FG: Be’, ma per fortuna insomma, ognuno è responsabile delle proprie azioni, e per fortuna nessuno ti obbliga a fare una cosa del genere, per cui io credo — ripeto — di non aver fatto una cosa straordinaria. So che il viaggio è stato duro, l’esperienza lunga, ma ho semplicemente fatto il giornalista e quando ho cominciato ad aprire delle porte, ho continuato ad aprire, e se la realtà è fatta di tanti corridoi e di tante porte, non è che l’ho costruita io. Semplicemente l’ho seguita per raccontarla. Per cui non ritengo di aver fatto un dolmen. Per quanto concerne la parte finale della domanda che mi hai posto, invece, penso che il Premio Tiziano Terzani sia già, di per sé, la massima risposta, una cosa che nemmeno immaginavo; mai avrei pensato che il libro, il viaggio, potesse ricevere un riconoscimento, e tra l’altro, un premio così importante, intitolato a una persona che è una fondamentale linea/vita di riferimento per tutti noi; anzi, se ne sente la mancanza, e ci sarebbe bisogno d’altri suoi scritti in questo momento.
Un riconoscimento importante che mi dà il senso di quanto la portata, non tanto della mia esperienza, quanto quella di chi il viaggio lo compie davvero, non sia caduta nel vuoto. Uno dei disagi più pesanti che ho provato, una volta tornato alla normale quotidianità, è stata l’estrema solitudine, perché mi rendevo conto quanto fosse impossibile far comprendere alle persone, soltanto parlando con loro, la violenza e la gravità di tutto quello a cui avevo assistito. Soltanto grazie alla forza della parola scritta, e accompagnando migliaia di persone, ormai, lungo lo stesso cammino, posso dire di sentirmi meno solo in quanto condividiamo lo stesso viaggio.

PGM: Una domanda un po’ provocatoria. Fatte le debite proporzioni, la situazione dei tanti Bil Al che vivono in Italia, non sono forse l’estremizzazione di un vivere comune, da normali cittadini, nella nostra società? Mi spiego meglio: se oggi parliamo con un maestro, un piccolo artigiano, un operaio, un poliziotto, un impiegato, ripetono tutti la stessa solfa, nel senso che tutti denunciano una certa fatica nel tirare avanti… lavorare, e rimanere fedeli a un comportamento etico, a certe regole di eticità, apprese magari dai genitori. Rimanere fedeli a un comportamento etico nel lavoro, fedeltà che finisce per creare ostacoli in più, fa la vita più dura? Condividi questa impressione?
FG: Io ribalterei la situazione. L’etica mi sembra che sia stata tirata ed adattata come un vestito, per cui abbiamo visto in pochi anni come, ad esempio, la posizione di antifascismo, da posizione etica, sia stata trasformata, grazie all’abilità di qualche politico, in una posizione politica, per cui — per par condicio — visto che siamo in democrazia, se ci sono degli antifascisti devono pur essere visibili anche i fascisti, che hanno ottenuto, così, vetrina e diritto d’asilo. Se penso alla Gran Bretagna, so che esiste una destra radicale nell’economia, basti pensare a Margaret Thatcher, ma Margaret Thatcher mai e poi mai si sarebbe sognata di farsi salutare dai propri elettori con il braccio alzato — anzi — avrebbe condannato un tale atteggiamento.
Da noi, invece, l’etica un po’ stiracchiata che passa è purtroppo quella della necessità, è quella del dire: sono dei poveracci, d’accordo, ma noi che ci possiamo fare? Secondo me c’è anche un altro aspetto da considerare, e temo che abbia molta influenza, e sul quale vorrei sbagliarmi. È un aspetto che vivo da osservatore diretto, e cioè quello di un’etica eccessivamente positiva e discriminante: il fatto di considerare ultima una determinata fascia di umanità, cosa che mi sento spesso ripetere sul mio lavoro: ah, ma tu ti occupi degli ultimi. A parte che faccio fatica a capire come si possano considerare ultimi, persone che sopravvivono a un’area deserta; se lo facessero per una ragione sportiva probabilmente sarebbero dei campioni di pentathlon, decathlon, cose di questo genere insomma, perché lo sforzo profuso è maggiore a quello di un qualsiasi partecipante alle olimpiadi, in qualsiasi disciplina.
Al tempo stesso, questo tipo di discorso viene inquadrato in un concetto di carità, che ha una funzione formidabile laddove deve sopperire e sostituire l’assenza di una normalità; questo può portare a pensare che si possano risolvere questioni come l’immigrazione con la carità, e quindi, favorire un atteggiamento che possa provocare una reazione del tipo: beh, insomma, in fondo, ma che cosa vogliono, mica possiamo aiutare tutti, quando in realtà la trasformazione è strutturale. La società, da adesso in poi, sarà ben diversa dalla società nazionale degli anni passati. È in crisi lo stato nazionale, tanto è vero che lo cogliamo nei movimenti autonomisti, lo vediamo nella pubblica amministrazione che fa fatica a dare risposte ai cittadini. Nel contempo c’è bisogno di una normalizzazione del mondo del lavoro, nell’assegnare dei documenti, in modo che le persone possano avere dei diritti.
Ti racconto un aneddoto capitato in Francia: è successo che la polizia sia andata in alcune scuole a prelevare i figli di immigrati clandestini, quando i genitori di questi bimbi avevano un lavoro in nero. Ebbene: i genitori dei compagni di classe hanno protestato con la polizia, chiedendo di far liberare gli immigrati, e sostenendo questo tesi: bene, il governo francese dice che le tasse pubbliche non possono farsi carico dell’immigrazione clandestina? Noi vi dimostriamo che dare un pezzo di carta, che poi è un permesso di lavoro e di soggiorno, a due persone che hanno già un lavoro, la casa e dei figli che vanno a scuola, costa infinitamente meno che pagare il viaggio di tre persone fino in Africa, in quanto nella maggioranza dei casi si tratta soprattutto di immigrati africani. Ecco, questo è un pragmatismo che va direttamente alla radice, intacca la struttura del problema.

Forse la soluzione caritatevole sarebbe la compassione, e quindi una condivisione della sofferenza, però anche l’ammissione che davanti a queste cose non si possa fare nulla, se non allungare qualche soldo o qualcosa da mangiare, trova il tempo che trova. Ricordo il papà di un bimbo — erano clandestini albanesi — che mi confessava di temere l’arrivo dei doni nella sua baracca alla periferia di Milano: questi doni rischiano di bloccarci qua. Un signore mi regalò quaranta quintali di legna — ed è la storia di Vicky, l’altro libro che ho scritto, e mi diceva: con 40 quintali di legna, quanti mesi devo rimanere qua? Io ho bisogno dei documenti, perché con quelli poi divento indipendente. Perché la carità, addirittura, vista dal punto di vista xenofobo, è quasi motivo della reazione xenofoba. In realtà la risposta non dovrebbe essere caritatevole, ma dovrebbe consistere in una risposta del diritto: siamo tutti uguali e siamo uguali davanti alla legge, per cui chi vìola la legge, anche se è un datore di lavoro, deve finire in galera.
PGM: Il momento più rischioso del tuo viaggio, è quando, volendo dar testimonianza anche al percorso degli espulsi, che dalla Libia riattraversano per la seconda volta il deserto, a ritroso, verso Agadez, cade il velo che nasconde Bil Al, e si scopre il volto di Fabrizio, questo ragazzo italiano che diventa, suo malgrado, protagonista di un processo quasi senza via di uscita. La domanda è provocatoria ma devo fartela: chi ci metteresti al posto tuo in quel punto, ovviamente qualcuno che possa cambiare le cose, in modo da permettergli di comprendere quello che succede in quei frangenti, e provare, così, l’esperienza diretta?
FG: Chi ci metterei al posto mio, dove? Là nel deserto, al momento del processo? Ma non ci metterei nessun altro, perché quando sei là in mezzo e credi che ti vogliano ammazzare, ma veramente, non lo auguri al peggior nemico. Poi in realtà finisci per scoprire che non ti volevano ammazzare, ma soltanto parlare. Tra l’altro sono molto contento che nella lettura scenica che è stata fatta a Udine, da Massimo Somaglino e Riccardo Maranzana, Gianni Cianchi abbia scelto proprio questa parte per concludere il lavoro: perché proprio lì sta la differenza; in quel viaggio ancora lungo, in quello spartiacque del prima e del dopo, via di mezzo tra la partenza e il rimanere, proprio lì c’è stato uno spartiacque fra le parole e la violenza. In quella mia esperienza, e io non lo sapevo ancora, quegli uomini, alla fine, volevano soltanto parlare. Quando me ne sono reso conto, paradossalmente, non ho trovato più parole per giustificare il comportamento nostro, mio, del mio Paese, dell’Europa.

PGM: Proprio quelle parole che poi hai ritrovato nello scrivere il libro, ma come hai fatto a ricordarti tutto? Perché a volte ha dell’incredibile pensare che hai scritto un libro di quasi 500 pagine con una precisione e con un’attenzione che porterebbero ad immaginare chili di appunti nei taccuini.
FG: Be’, per ricordarmi tutto durante il viaggio, mi appuntavo quello che avevo visto o sentito, le mie impressioni, le emozioni o quello che era successo, di nascosto ogni notte, quando passavo inosservato, una volta ogni due o tre giorni. Per quanto riguarda i nomi, che sono un po’ più difficili da ricordare, soprattutto se sono nomi stranieri, ci scambiavamo gli indirizzi per le email, cosa che avveniva frequentemente; quello era il momento in cui su un bigliettino di carta scrivevo i nomi delle persone che avevo di fronte. Per cui, alla fine, al nome delle persone, aggiungevo quello che mi avevano raccontato. Nel libro, poi, qualche nome l’ho modificato perché non mi sono mai dichiarato come giornalista. A Lampedusa o in Puglia, invece, non ho preso appunti. Sono comunque esperienze talmente forti che restano impresse, e per le quali non è necessario prendere appunti, ti restano in testa, sono sulla pelle, anzi, fai fatica a toglierle, forse non vuoi nemmeno togliertele, e non se ne vanno lo stesso.
PGM: Da uomo di buona volontà, che scrive, cerca di definirmi qual è la speranza che è riservata ancora alle parole, proprio come hanno fatto i bravissimi attori alla fine dello spettacolo, nella serata conclusiva del premio Terzani. Da te, mi piacerebbe sentire qualcosa di tradotto in un messaggio augurale per le parole, perché spesso se ne scrivono tante, e sembra che sia solamente un ciarlare a vanvera, vero?
FG: Le parole sono tutto, le parole fanno la differenza, perché senza le parole il vuoto che resta rischia di venir colmato dalla violenza. Senza parole si fanno le guerre, mentre il parlare è sempre una reazione alla guerra o a qualsiasi fenomeno del genere che significhi far morire altre persone o lasciarle morire; vuol dire imporre delle condizioni a chi provocherà altri morti, come succederà ancora quest’estate. Abbiamo solo le parole, l’alternativa è imbracciare il fucile. Questo, infatti, è un grande dubbio che mi assilla e che arrivando in fondo al mio viaggio, a un certo punto ha quasi rischiato di scapparmi via. Io l’ho confessato a me stesso, e poi l’ho messo nel libro, in quanto mi ero imposto di metterci assolutamente tutto. Il dubbio è quello d’aver paura che la più grande menzogna sia far credere che tutto questo possa essere cambiato con le parole. Le parole sono uno strumento lento, più difficile rispetto ad altri, ma sicuramente meno sanguinario e molto più radicale.
 PGM: Hai mantenuto ancora i contatti con qualcuno dei ragazzi incontrati, magari via mail?
PGM: Hai mantenuto ancora i contatti con qualcuno dei ragazzi incontrati, magari via mail?
FG: Sì, ho contatti con James e Joseph, e con Stephen. Con altri ho avuto dei contatti sporadici, alcuni proprio non hanno mai risposto, e di molti non so cosa gli sia capitato. So che qualcuno era bloccato in Libia, e poi non ci siamo più sentiti. Non ho mai ritrovato nessuno, tranne Stephen, come racconto nel libro, non ho mai più ritrovato i miei compagni di viaggio. Ho conosciuto tantissime persone che hanno percorso lo stesso itinerario, e in qualche modo — quando capita casualmente di trovare persone pronunciare la parola magica Dirkou, il deserto e così via — ci si guarda un po’ diversamente, nasce un po’ quello spirito da reduci, insomma, ci si sente appartenenti a una sorta di club, ecco. Io ho usurpato questo ruolo perché in effetti non avevo nessun diritto a farne parte, ma insomma, avendo fatto il viaggio un po’ mi sento così.
PGM: Volevo dirti una cosa, perché è quella che mi ha commosso di più quando hai ricevuto il Premio Terzani… eri commosso tu, e la tua commozione ha fatto commuovere me: hai dedicato ai tuoi genitori tutto questo, e allora voglio chiederti cosa ti hanno detto i tuoi genitori quando sei tornato, cosa ne pensano di quello che hai fatto, di queste cose in cui ti sei messo?
FG: Guarda… non gliel’ho mai chiesto.
PGM: Ma loro non ti hanno mai detto niente?
FG: Loro sono stupendi perché non mi trasmettono alcuna preoccupazione prima di qualsiasi partenza, e al ritorno sono contenti di rivedermi. Però io non gli ho mai chiesto come si siano sentiti. Come dire…basta vedere come ci si guarda negli occhi, non serve dire nulla, non servono le parole in questo caso.



























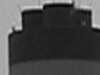




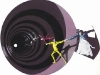




Commenti
Non ci sono ancora commenti