 Il punto di vista di questa relazione vuole essere formale, e cioè portato sullo stile che i film manifestano e, attraverso lo stile, sulle pratiche che li hanno prodotti.
Il punto di vista di questa relazione vuole essere formale, e cioè portato sullo stile che i film manifestano e, attraverso lo stile, sulle pratiche che li hanno prodotti.
Questo significa che l’aspetto storico-sociologico normalmente collegato al discorso sulla modernità e sulla postmodernità non sarà l’elemento guida di questa relazione. Anche se ad un certo punto sarà recuperata la domanda storico-sociologica e politica.
Collocare il discorso a un livello formale implica anche che questa relazione non sarà orientata alla divisione della storia del cinema in insiemi materiali, alla costruzione, per dir così, di teche in cui conservare il cinema moderno e di teche riservate al cinema postmoderno. Il mio vorrebbe essere piuttosto il tentativo di mettere a punto una domanda da rivolgere ai testi, per cogliere le differenze che in questi film rinviano a pratiche, a operazioni e concezioni del cinematografare, diverse tra loro. Si tratta insomma del tentativo di ritagliare, tra i vari possibili, un tipo di domanda da porre ai film, piuttosto che dell’incasellamento di un insieme di opere sotto un’etichetta.
Non quindi la domanda: è, questo, un film moderno o no? (postmoderno o no?), che sottende normalmente un criterio cronologico e una sorta di tassonomia. Bensì la domanda: ci sono indici della modernità (della postmodernità) in questo film? Domanda più agile, in qualche misura indipendente dal tempo e dal luogo della realizzazione dell’opera.
Lo stile della modernità: l’interdipendenza di riproduttività e metalinguaggio. Dobbiamo chiederci allora se sia possibile parlare di uno stile della modernità cinematografica, e in che senso vada intesa questa parola, “modernità”, nel cinema.
Negli anni Sessanta ci fu un dibattito, soprattutto in Francia, in cui si misero in evidenza alcuni indici stilistici nei film che, allora, venivano detti “moderni”. Al pianosequenza e alla profondità di campo, che già da più di dieci anni erano stati al centro del dibattito critico sul “moderno”, si aggiunsero altre formule: si parlò di cinema di regia contrapposto al cinema di sceneggiatura, di “sdrammatizzazione” (la “tendenza Antonioni”), o in generale di frantumazione del racconto, e poi di cinema d’improvvisazione (il “cinema-verità”, il “cinema diretto”), di cinema della “messa in presenza” (aperto a letture multiple) contrapposto al cinema della “messa in scena” classica (basata sul concatenamento narrativo, tendenzialmente univoco), di “cinema di poesia” (secondo la formula di Pasolini) contrapposto al cinema di prosa, spettacolare e narrativo.
Riassumendo questo dibattito a pochi anni di distanza, Christian Metz ne rilevava l’insufficienza, mostrando l’infondatezza teorica di queste formule, e salvandone una soltanto: “Le migliori opere del nuovo cinema (…) offrono spesso ai loro spettatori un certo tipo di verità che assai di rado si trovava nelle grandi opere del passato, verità infinitamente difficile da definire, ma che si localizza istintivamente. Verità di un atteggiamento, di un’inflessione di voce, di un gesto, giustezza di un tono… (…) Non è illecito pensare che questi istanti di verità (…) resteranno, nella loro fragilità, le conquiste più preziose del cinema che, nel 1966, chiamiamo cinema ‘moderno’ ” .
 Qualche anno dopo, Gilles Deleuze, applicando al cinema la filosofia di Bergson, indicava nella rappresentazione della temporalità la caratteristica fondamentale dell’immagine cinematografica moderna, riprendendo in un corpo teorico coerente e articolato tutta una tradizione critica francese del secondo dopoguerra (cui va aggiunto, per parte italiana, il nome Zavattini), che aveva sottolineato questo elemento nelle pratiche di Renoir, di Rossellini, e di una quantità di autori della modernità cinematografica: la tradizione, per fare solo qualche nome tra i più noti, dei vari Auriol, Ayfre, Cauliez, Daney, e soprattutto Bazin, le cui elaborazioni teorico-critiche, peraltro, non sempre sono state colte in tutta la loro produttività, neppure da Deleuze.
Qualche anno dopo, Gilles Deleuze, applicando al cinema la filosofia di Bergson, indicava nella rappresentazione della temporalità la caratteristica fondamentale dell’immagine cinematografica moderna, riprendendo in un corpo teorico coerente e articolato tutta una tradizione critica francese del secondo dopoguerra (cui va aggiunto, per parte italiana, il nome Zavattini), che aveva sottolineato questo elemento nelle pratiche di Renoir, di Rossellini, e di una quantità di autori della modernità cinematografica: la tradizione, per fare solo qualche nome tra i più noti, dei vari Auriol, Ayfre, Cauliez, Daney, e soprattutto Bazin, le cui elaborazioni teorico-critiche, peraltro, non sempre sono state colte in tutta la loro produttività, neppure da Deleuze.
Io credo che tra gli “istanti di verità” di cui parlava Metz e l'”immagine-tempo” di Deleuze ci sia una relazione stretta. E credo che ci sia una relazione anche tra queste due formule e le altre messe in gioco dalla critica di allora.
Guardando i film nei quali sono stati colti ora l’uno ora l’altro di questi indici stilistici (la sdrammatizzazione, l’improvvisazione, ecc.), si vede, io credo, che questi indici sono la manifestazione, nei diversi testi, di un’unica operazione di fondo, che si può riassumere così: un recupero esplicito e consapevole, da parte di questi film, della riproduttività insita nel dispositivo cinematografico e, insieme con questo recupero, attraverso questo recupero, con lo stesso gesto di questo recupero, lo svolgersi di un’operazione metalinguistica, la presa di posizione rispetto al cinema come linguaggio e alla sua storia.
In altre parole: attraverso l’assunzione esplicita, in funzione estetica, del cinema come riproduttore, la critica della norma stilistica dominante, quella del découpage classico hollywoodiano.
I due elementi di questa definizione — cioè il recupero della riproduttività e l’operazione metalinguistica — non sono da intendersi come giustapposti ma come interdipendenti: l’uno si attua attraverso l’altro, l’uno manifesta l’altro. È in questa interdipendenza diriproduttività e metalinguaggio che si definisce, a mio parere, la “modernità” cinematografica.
Si è parlato molto dell’operazione metalinguistica come elemento che definisce il moderno, non solo cinematografico. Operazione che si esprime di volta in volta in forme diverse, come la mise en abyme, le varie forme di intertestualità (citazioni, inclusioni), l’autoreferenzialità.
Ma questo non è sufficiente per definire la modernità cinematografica.
 Tanto cinema classico presenta l’elemento metalinguistico, che di per se stesso, dunque, non viola la norma linguistica. Un esempio lo troviamo in Singin’ In The Rain di Donen e Kelly, dove a breve distanza appaiono una riflessione sul cinema come fabbrica dei sogni (nella sequenza in cui Don fa la sua dichiarazione d’amore a Kathy nello studio hollywoodiano) e, in forma autoriflessiva sofisticata, l’identificazione del sonoro con il musical, in un’implicita ma precisa dichiarazione di poetica (nella sequenza, di poco successiva, del maestro di dizione).
Tanto cinema classico presenta l’elemento metalinguistico, che di per se stesso, dunque, non viola la norma linguistica. Un esempio lo troviamo in Singin’ In The Rain di Donen e Kelly, dove a breve distanza appaiono una riflessione sul cinema come fabbrica dei sogni (nella sequenza in cui Don fa la sua dichiarazione d’amore a Kathy nello studio hollywoodiano) e, in forma autoriflessiva sofisticata, l’identificazione del sonoro con il musical, in un’implicita ma precisa dichiarazione di poetica (nella sequenza, di poco successiva, del maestro di dizione).
L’operazione metalinguistica della modernità cinematografica si attua attraverso un’altra via: il recupero, come si è detto, della riproduttività propria del dispositivo cinematografico.
Riproduttività di che cosa? Del reale fenomenico, certamente, secondo la lezione di Renoir e del miglior neorealismo italiano, in particolare di Rossellini e di Zavattini (lo Zavattini teorico, quello del “cinema del soggetto pensato durante”), lezione che apre la strada al “cinéma-vérité” di Rouch e alla parte migliore della Nouvelle Vague. Ma riproduttività, anche, di altri testi, appartenenti sia al cinema sia ad altri linguaggi, secondo la lezione messa in evidenza da Bazin nel rapporto tra Bresson e Bernanos per Le Journal d’un curé de campagne, e in quello tra Clouzot e Picasso per Le Mystère Picasso.
La relazione del cinema-riproduttore con il pre-testo esplicitata da Bazin in questi due film è esattamente della stessa natura di quella che troviamo nelle opere di Straub-Huillet e di Godard. E non a caso il film che, tra quelli di Godard degli anni Ottanta, tematizza più esplicitamente la storia del cinema si intitola Passion.
 In esso Godard fa un discorso sulle due anime del cinema: la riproduttiva e la finzionale, dove anche la finzionale è ricondotta alla riproduzione (i tableaux vivants), ed entrambe sono ricondotte alla metafora della luce e alla capacità di riorganizzare il mondo che è propria del cinema (la “ripianificazione semantica del mondo” di cui parlava Tynjanov negli anni Venti). Il titolo ci riporta a questo momento iniziale della narrazione-organizzazione — le “Passioni” dell’inizio del cinema narrativo — in un interrogativo radicale sul cinema e sulla sua storia. E il successivo Scénario du film Passion si spinge ancora oltre, in un gioco di associazioni di idee sul cinema che prelude alle Histoire(s) du cinéma che, realizzate nel corso degli ultimi anni, stanno per uscire nelle sale.
In esso Godard fa un discorso sulle due anime del cinema: la riproduttiva e la finzionale, dove anche la finzionale è ricondotta alla riproduzione (i tableaux vivants), ed entrambe sono ricondotte alla metafora della luce e alla capacità di riorganizzare il mondo che è propria del cinema (la “ripianificazione semantica del mondo” di cui parlava Tynjanov negli anni Venti). Il titolo ci riporta a questo momento iniziale della narrazione-organizzazione — le “Passioni” dell’inizio del cinema narrativo — in un interrogativo radicale sul cinema e sulla sua storia. E il successivo Scénario du film Passion si spinge ancora oltre, in un gioco di associazioni di idee sul cinema che prelude alle Histoire(s) du cinéma che, realizzate nel corso degli ultimi anni, stanno per uscire nelle sale.
Gioco moderno, questo di Straub e di Godard, perché, appunto, la riproduzione vi si dà come luogo dell’interrogazione del cinema, come luogo dell’operazione metalinguistica (in modo più esplicito, vorrei aggiungere, ma non più consapevole di quanto era accaduto in Paisà o in India, matri bhumi di Rossellini).
In questo gioco, il referente — sia esso la realtà fenomenica sia un altro testo appartenente a un qualsiasi linguaggio — viene riprodotto nella sua materialità dal testo filmico, e quest’ultimo acquista il carattere di un testo critico di testi preesistenti individuati, dichiarati. Non troppo diversamente da quanto, in poesia, avviene con “The Waste Land” di Eliot, che è considerato uno dei capisaldi della modernità e al tempo stesso un modello nella letteratura anglo-americana postmoderna. Il che a mio avviso è significativo delle intersezioni tra moderno e postmoderno e anche di una qualche incomprensione da parte della critica postmoderna sulla reale portata del gioco intertestuale nel moderno.
Questa materialità del profilmico rinvia alla materialità del set. Quella che troviamo nel cinema di Renoir, per esempio: la profondità di campo a 360° sottolineata da Rivette, la presa diretta e in continuità del sonoro, la tendenza all’inquadratura lunga, alla temporalità reale dispiegata sullo schermo; e questa stessa materialità di un set-teatro della vita la troviamo in Rivette, o in Eustache, o in Garrel; e la troviamo nel “cinema del soggetto pensato durante” di Zavattini (l’argomento stesso del film pensato durante le riprese), come nel “cinéma-vérité” di Rouch (un’antropologia dell’ “osservazione partecipante” attraverso la cinepresa); e ancora nel viaggio indiano di Rossellini o nell’erranza dei personaggi di Robert Kramer; o nel gioco associativo di Godard, che viaggia stando al tavolo su cui ha accumulato, nel corso della sua vita, un numero incredibile di materiali visivi e sonori, e il viaggio sta nel far incontrare questi materiali tra loro, in un interrogativo sulla nascita del senso.
Ora accade che in tutti questi film troviamo la pratica di un dubbio radicale portato insieme sul mondo e sullo sguardo; sulle cose, sulla realtà fenomenica e culturale, e insieme sul cinema che questa realtà “ripianifica” riproducendola.
Tutto è sottoposto a questo dubbio radicale, così ben tematizzato da Antonioni e dalla Duras. Radicale perché accompagna in ogni passo queste pratiche della sperimentazione, dove sperimentare significa fare esperienza della nascita del senso al cinema.
Ecco allora che trova una sua legittimità questo aggettivo di “moderne”, con il quale queste pratiche sono state definite in un periodo della storia del cinema in cui si sono affermate con la loro carica trasgressiva. Pratiche che tuttavia troviamo ben prima di quel periodo (basti pensare a certe inquadrature di Antoine a cavallo tra gli anni Dieci e i Venti, o alla battigia del porto di Le Havre in L’Atalante di Vigo), e ancora oggi (l’esempio di Godard valga per tutti).
“Moderne” perché realizzano in se stesse le caratteristiche della “condizione moderna”, quella sospensione sul vuoto, quella perdita del centro, quell’esposizione esistenziale al nulla, che si definisce nel corso dell’era moderna, dalla rivoluzione copernicana in poi, e che si manifesta nel relativismo delle scienze, nella crisi dei grandi sistemi di pensiero, nella frattura freudiana del soggetto.
È qui che possiamo reintrodurre la dimensione storico-sociologica che il mio approccio formale aveva messo da parte.
Non dunque al livello del rispecchiamento, della tematizzazione, che il cinema farebbe dei processi della modernizzazione: il cinema che parla della città, dell’urbanizzazione, dei fenomeni di massa, dei problemi esistenziali dell’uomo di oggi; o anche, semplicemente, il cinema che èmoderno in quanto arte tecnologica, che dipende da un dispositivo ottico-meccanico-chimico.
Tutto questo ha la sua rilevanza, ma non è sufficiente a descrivere certe differenze tra modi di pensare e di fare il cinema.
Solo alcune delle pratiche cinematografiche, non tutte, sono pratiche del dubbio, sono la modernità vissuta in proprio dal cinema.
Verso il postmoderno: la teoria e il contesto
 Negli anni in cui il cinema “moderno” s’impone all’attenzione del pubblico e della critica — ricordo a puro titolo di esempio che Cronaca di un amore di Antonioni e Le Journal d’un curé de campagne di Bresson sono del 1950, Le Mystère Picasso di Clouzot è del 1956, India di Rossellini è del 1958, Chronique d’un été di Rouch e Morin è del 1960; e che poi, negli anni Sessanta, si afferma il cosiddetto nuovo cinema internazionale, in buona misura attraversato da pratiche della modernità —, in questi anni si assiste come a un’esplosione, nella teoria, innescata in gran parte dal moderno, sia cinematografico sia letterario sia figurativo (la crisi del romanzo moderno, il nouveau roman, l’Action Painting, l’Informale).
Negli anni in cui il cinema “moderno” s’impone all’attenzione del pubblico e della critica — ricordo a puro titolo di esempio che Cronaca di un amore di Antonioni e Le Journal d’un curé de campagne di Bresson sono del 1950, Le Mystère Picasso di Clouzot è del 1956, India di Rossellini è del 1958, Chronique d’un été di Rouch e Morin è del 1960; e che poi, negli anni Sessanta, si afferma il cosiddetto nuovo cinema internazionale, in buona misura attraversato da pratiche della modernità —, in questi anni si assiste come a un’esplosione, nella teoria, innescata in gran parte dal moderno, sia cinematografico sia letterario sia figurativo (la crisi del romanzo moderno, il nouveau roman, l’Action Painting, l’Informale).
Questa esplosione teorica da un lato porta alle logiche conseguenze le problematiche del moderno e dall’altro ha importanti connessioni con il postmoderno. Si tratta del decostruzionismo e delle sue anticipazioni. Il grado zero della scrittura di Barthes esce nel 1953, la prima formulazione di “Opera aperta” di Eco è una conferenza del 1958 (il libro esce nel 1962), “Storia della follia” di Foucault è del 1961, “Per Marx” di Althusser esce nel 1965, gli “Scritti” di Lacan sono del 1966, “La scrittura e la differenza” di Derrida è del 1967, “Semeiotiké” della Kristeva è del 1969.
Al tempo stesso, si registra un complesso di fenomeni sociali decisivo per il contesto che viene indicato con il termine di postmoderno. Diviene centrale il dibattito sul cosiddetto Terzo mondo; la penetrazione della cultura orientale nell’Occidente diviene più sensibile; l’emigrazione dai Paesi sottosviluppati verso l’Europa si fa più consistente. Nuovi soggetti sociali appaiono prepotentemente alla ribalta: i giovani e le donne, in primo luogo; e poi minoranze di vario genere, da quelle etniche (gli afroamericani) a quelle sessuali (i gay).
La teoria registra tutto questo puntualmente, come vedremo affrontando però anzitutto il tema degli indici stilistici del postmoderno e delle pratiche di regia e spettatoriali che essi manifestano e richiedono.
Qui la tentazione di assumere un criterio cronologico nel discorso è grande, a causa del collegamento del postmoderno con il contesto; un collegamento che appare così forte che più di uno studioso ha parlato del postmoderno in termini di contesto più che di stile. Un contesto caratterizzato, come ho accennato, da un lato dall’afflusso di diversità dei soggetti sociali emergenti, e dall’altro dalle elaborazioni teoriche del poststrutturalismo.
Un contesto che induce a nuovi tipi di letture, a nuovi modelli d’interpretazione.
Per quanto concerne il cinema, ritengo che questo punto di vista storico-sociale e contestuale, per molti versi produttivo e che rimetterò io stesso in gioco tra poco, non debba essere né l’unico né il primo dei criteri da adottare. Potrebbe infatti portarci a considerare il postmoderno semplicemente come il superamento del moderno, lungo una linearità sulla quale proprio il nostro secolo — e lo stesso postmoderno — ha steso una sana ombra di dubbio, e a non accorgerci di quanto lega il cinema postmoderno al cinema classico.
Come pure potrebbe spingerci a identificare il postmoderno con il cinema delle minoranze di cui ho fatto cenno, cosa che non sembra corretta, dal momento che, se è “postmoderna”, per così dire, la presenza simultanea di una molteplicità consistente di soggetti sociali diversi che prima non si davano come protagonisti, non è affatto detto che le produzioni di questi soggetti siano di per sé “postmoderne”. La carica politica di diversi di questi prodotti farebbe pensare piuttosto al contrario. E di fatto la teoria americana elaborata da queste minoranze (per esempio, la femminista, la nera, la gay) critica duramente diverse delle pratiche postmoderne, mettendone in evidenza il collegamento con i modelli culturali dominanti (si veda per esempio la critica del cinema di Lucas e Spielberg come Reaganite Entertainment fatta da autori come Arnold Britton e Susan Aronstein o gli analoghi discorsi di Robert Torry e Patricia Zimmermann su quel cinema come espressione del puritanesimo e della nuova destra statunitense).
È bene partire dunque, ancora una volta, dallo stile.
Lo stile del postmoderno: l’immersione nel film-concerto e il virtuale
In un libro recente , lo studioso francese Laurent Jullier riassume gli indici stilistici del cinema postmoderno: riciclaggio di figure; allusioni e “strizzatine d’occhio” allo spettatore, di cui l’enunciatore sa “che è capace di identificare l’allusione e di apprezzarla”; e soprattutto sollecitazione di “sensazioni forti” nello spettatore, attraverso l’adozione di quello che Jullier chiama “film-concerto”, caratterizzato dalla presenza decisiva della musica come principio fondamentale della sua costruzione (per Jullier Star Wars segna, nel 1977, la nascita del cinema postmoderno anche perché è il primo film presentato commercialmente con il sistema Dolby), e caratterizzato da un insieme di figure stilistiche tendenti a provocare nello spettatore un “bagno di sensazioni”.
 Figure che Jullier chiama “dell’immersione”, riprendendo il termine da Frank Biocca, come il carrello in avanti, di cui abbiamo un esempio nella sequenza iniziale di Le grand bleu di Besson, esempio principe di film-concerto, secondo Jullier.
Figure che Jullier chiama “dell’immersione”, riprendendo il termine da Frank Biocca, come il carrello in avanti, di cui abbiamo un esempio nella sequenza iniziale di Le grand bleu di Besson, esempio principe di film-concerto, secondo Jullier.
Figure che non hanno alcuno scopo diegetico ma soltanto quello di immergere lo spettatore in un bagno di sensazioni e di suoni dotato di un forte onirismo. “L’effetto di bagno procurato dai film-concerto”, scrive Jullier, “dà allo spettatore la sensazione di galleggiare al centro di un magma i cui suoni, soprattutto i suoni gravi dalla grande dinamica, toccano direttamente, come l’acqua del bagno — e anche in un modo molto più intrusivo di essa — il suo corpo intero”.
Di qui l’importanza, per il cinema postmoderno, di proiezioni ad altolivello tecnico: schermo grande, immagine perfettamente definita, sistema acustico perfetto. Di qui anche il fatto, rilevato da uno studioso come Tony Wilson , che “l’immagine postmoderna è sprovvista di punto di vista”, e che “un’immagine senza punto di vista non può generare un giudizio sul mondo. La parola d’ordine è: dove sono? I luoghi hanno un’aria di déjà-vu, come nei sogni”.
Le figure stilistiche e le tecniche più recenti (per esempio, l’insistenza dello zoom e del carrello in avanti, e l’invenzione della steadycam), secondo Jullier vanno proprio in questa direzione di svincolare il rapporto tra spettatore e film dalla diegesi, dalla proiezione spettatoriale in un universo di finzione, che era propria del cinema classico. Lo spettatore postmoderno si identifica alla cinepresa come “entità dai poteri sovrumani” indipendentemente dalla “proiezione in un mondo di finzione”; e i poteri sovrumani della cinepresa hanno a che vedere con le sensazioni, e con il recupero di stati primitivi della formazione della personalità, come per esempio lo stadio, precedente a quello dello specchio, in cui il bambino si avvicina al seno materno sprofondandovi per la poppata.
L’orientamento del cinema di oggi in questa direzione della sensazione e del piacere (con una forte componente di oralità) è rinforzato dall’utilizzazione delle immagini di sintesi. La realtà virtuale, infatti, è in ogni senso improntata all’immersione, in quanto, grazie anche all’eliminazione del fuori campo e del montaggio, rende pressoché esclusivo l’ambiente presentato dal medium rispetto a quello reale che circonda colui che percepisce l’immagine, predominanza che Jonathan Steuer chiama “telepresenza” . (Noto per inciso che su questa immersività del virtuale gioca anche l’arte figurativa contemporanea, come è mostrato dall’esempio del padiglione scandinavo della Biennale Arte dell’anno scorso a Venezia, dove in una saletta si faceva l’esperienza di un video tridimensionale accompagnato ad un certo punto anche da un’emissione di profumi: un’immersione che voleva essere dunque non soltanto di suoni e luci ma anche olfattiva).
Coerentemente con questa identificazione del postmoderno con il distacco dalla diegesi e con l’immersione nel bagno di suoni e di sensazioni, Jullier parla di “non-discorso” o di “discorso di defezione” da parte del cinema postmoderno.
La teoria degli anni Sessanta e l’immanenza del senso
 Personalmente trovo che le indicazioni di Jullier sullo stile del cinema postmoderno siano convincenti, anche se non credo che siano esaustive di una produzione cinematografica che mi sembra più variegata di quella implicata dalla nozione di film-concerto. Anche Jullier, d’altra parte, sembra rendersene conto, quando accenna, ma solo di passaggio, a certi film minimalisti e ai “film d’erranza postmoderni” al modo di Wenders o di Jarmusch.
Personalmente trovo che le indicazioni di Jullier sullo stile del cinema postmoderno siano convincenti, anche se non credo che siano esaustive di una produzione cinematografica che mi sembra più variegata di quella implicata dalla nozione di film-concerto. Anche Jullier, d’altra parte, sembra rendersene conto, quando accenna, ma solo di passaggio, a certi film minimalisti e ai “film d’erranza postmoderni” al modo di Wenders o di Jarmusch.
A quest’ultimo proposito, devo osservare che questa dell’erranza è una figura che mi sembra appartenere piuttosto al moderno che al postmoderno, se pensiamo proprio alla trilogia della strada di Wenders o ai primi film di Jarmusch, o agli ultimi di Robert Kramer. E d’altra parte Wenders sembra tematizzare il passaggio dal cinema moderno al postmoderno in termini non lontani da quelli che assumiamo qui, in un film come Until The End Of The World.
Il fatto è che la domanda sull’immersione nel film-concerto non esaurisce lo spettro delle possibili domande “postmoderne” al cinema.
L’immersione nel film-concerto è in realtà una specificazione, in direzione puramente sensoriale, di un motivo più generale, presente da sempre nell’arte, ma che trova il punto di massima esplicitazione teorica negli anni Sessanta: l’immanentismo della parola e dello sguardo, cioè la consapevolezza che non esistono punti esterni al discorso, dai quali osservare e “parlare”.
Questo motivo ci riporta al contesto e alla teoria degli anni Sessanta, ponendosi come un ponte tra le pratiche del moderno e quelle del postmoderno.
Credo che la caratteristica principale della teoria di allora, degli scritti dei vari Eco, Barthes, Lacan, Derrida, Kristeva, Althusser, Foucault, sia stata quella di aver insistito, ciascuno per la propria via, su questo punto, che mi sembra decisivo, e che apre alle pratiche teoriche e critiche successive: la necessaria autoreferenzialità del discorso critico e l’immanenza del senso di questo discorso, come espressione di una generale immanenza del senso in ogni manifestazione testuale, artistica, filosofica, matematica che sia.
In questa direzione può portare, in definitiva, il lavoro di Eco su Joyce e la nozione di “opera aperta”.
E in questa direzione porta il discorso di Derrida sul Logos che, nella storia, “si differisce per riappropriarsi”, attraverso “la deviazione di una scrittura”, cioè la “differanza” che Derrida legge nel discorso di Freud sulla traccia mnestica e, a livello filosofico, in Husserl. Ed è noto come proprio alla lezione di Derrida si rifaccia tutta una parte della teoria decostruzionista americana, che più di altre ha elaborato il concetto di postmoderno, prevalentemente in campo letterario.
Come pure in questa direzione porta la critica che Julia Kristeva fa della separazione operata dalla cultura occidentale tra segno e pratica, e la conseguente messa a punto, da parte della stessa Kristeva, della nozione di gesto. E le conseguenze epistemologiche del “sistema della moda” tracciato da Barthes. E l’attualità irripetibile della singola relazione analitica proposta dalla rilettura lacaniana di Freud, e la stessa scrittura fenomenologica del Lacan psicoanalista (scienziato?, artista?).
E anche il concetto di ideologia come rapporto reale, vissuto, che Althusser sostituisce al concetto di ideologia come falsa coscienza della tradizione marxista. E la critica della centralità del soggetto umanistico propria di Foucault, insieme con la sua concezione delle “fratture epistemologiche” con cui procede la sua storiografia antiumanistica.
E, vorrei aggiungere, sia pure in un contesto culturale diverso, ma con implicazioni teoriche non meno decisive, il concetto di “operazione” elaborato dall’epistemologo Emilio Garroni, e di “operazione a dominante metaoperativa” che egli propone per una definizione dell’arte, nell’ambito di una revisione critica della semiotica, alla metà degli anni Settanta.
Immanentismo del senso e postmodernità
 Questo richiamo insistito all’immanenza del senso e all’implicazione del soggetto all’interno del discorso ha come conseguenza una ridefinizione del posto dell’autore (meglio: del concetto stesso di autore), del posto dello spettatore e di quello del critico.
Questo richiamo insistito all’immanenza del senso e all’implicazione del soggetto all’interno del discorso ha come conseguenza una ridefinizione del posto dell’autore (meglio: del concetto stesso di autore), del posto dello spettatore e di quello del critico.
Non credo si tratti di una rivoluzione copernicana operata dal postmoderno, ma piuttosto di una più adeguata formulazione di istanze già presenti nell’arte, nella critica, nella teoria e nell’epistemologia del Novecento.
Come non sono precipui del postmoderno i giochi intertestuali, le rivisitazioni e gli attraversamenti culturali. Pensiamo, per tutti, al già citato “The Waste Land” di Eliot, che viene pubblicato nel 1922, e alla definizione di autore che viene data da Sklovskij nel 1923: “un semplice punto geometrico di intersezione di linee, di forze generate al di fuori di lui”.
Quanto all’immanentismo del senso, esso coincide in parte con ciò che, a proposito dell’arte, è stato indicato con i termini di “ambiguità”, “polisemia”, “connotazione” dalla tradizione strutturalista, o “funzione poetica” da Jakobson e dai praghesi, sulla linea indicata dal formalismo russo, o “contestualità organica” da Della Volpe.
Ma solo in parte, perché, in più, esso trascina con sé la necessità di rivedere radicalmente lo stesso sistema di riferimento, le stesse categorie critiche, anche le più generali, quelle che hanno a che fare con le altre discipline, con le scienze, con la società e la storia (vedi il discorso derridiano sugli “indecidibili” ).
Inoltre, con Derrida, Lacan e la Kristeva, questo immanentismo estende il suo dominio, per dir così, oltre il campo della poesia e dell’arte e diviene il percorso stesso del senso nella storia. E qui, soprattutto in Derrida, accanto a un approccio fenomenologico, c’è probabilmente un residuo idealistico di qualche rilievo, assente, mi sembra, dalle elaborazioni di Eco e di Garroni.
Un residuo idealistico che riconduce al farsi della storia (alla storia come realizzazione del Logos) le disarticolazioni aperte dalla modernità, la perdita del centro che costituisce l’asse di sviluppo del pensiero moderno, da Copernico in poi, e che approda alla parcellizzazione del mondo contemporaneo.
In antropologia, questa messa in gioco fenomenologica del soggetto che percepisce si era tradotta nella rivoluzione operata negli anni Venti dall’ “osservazione partecipante” di Malinowski, e poco dopo dal metodo documentario della Mead e di Bateson, che mettevano in gioco il posto dell’osservatore e ridiscutevano lo sguardo dell’antropologo.
Nel cinema degli anni Cinquanta, Rouch riprendeva le danze di possessione mettendo in discussione così l’occhio del cineasta e la stessa presenza, non indifferente, della cinepresa nel rito. E il set di Renoir, soprattutto a partire dagli anni Trenta, si dava come una sorta di palcoscenico teatrale su cui giocava il gruppo degli attori insieme con il regista, occhio, testimone, attore anch’esso del work in progress delle riprese.
Neppure la critica cinematografica era insensibile a questi segni dei tempi, come mostra la storia dei “Cahiers du Cinéma” degli anni Cinquanta.
Ma la piena consapevolezza di non poter guardare da un luogo esterno alla scrittura arriverà proprio con le elaborazioni dei teorici degli anni Sessanta e successivi.
 Questa esplosione della teoria coincide con lo stadio finale della crisi delle narrazioni di cui parlerà Lyotard nel suo “rapporto sul sapere” del 1979 , con l’espansione del sistema dei media e dell’interazione al suo interno. E coincide con i fenomeni sociali cui ho fatto prima riferimento.
Questa esplosione della teoria coincide con lo stadio finale della crisi delle narrazioni di cui parlerà Lyotard nel suo “rapporto sul sapere” del 1979 , con l’espansione del sistema dei media e dell’interazione al suo interno. E coincide con i fenomeni sociali cui ho fatto prima riferimento.
Il cinema registra tutto questo, e lo fa anche prima e diversamente da Star Wars.
Temi e stili del cinema postmoderno: i frammenti, la perdita del centro, il cinema come centro
 Una tematizzazione della perdita del centro, della parcellizzazione delle esperienze e delle conoscenze, e della nuova presenza del corpo nella società postmoderna la troviamo, nel 1970, nel film americano di Antonioni: Zabriskie Point. La moltiplicazione dei corpi in amore nel deserto e l’esplosione finale al ralenti apparvero allora come una sorta di consuntivo del ’68, e oggi appaiono come anticipazioni di tutto un cinema del dopo-l’esplosione da un lato (i rifiuti, i residui dei vari Mad Max, ma non soltanto) e dall’altro della derealizzazione virtuale del corpo postmoderno.
Una tematizzazione della perdita del centro, della parcellizzazione delle esperienze e delle conoscenze, e della nuova presenza del corpo nella società postmoderna la troviamo, nel 1970, nel film americano di Antonioni: Zabriskie Point. La moltiplicazione dei corpi in amore nel deserto e l’esplosione finale al ralenti apparvero allora come una sorta di consuntivo del ’68, e oggi appaiono come anticipazioni di tutto un cinema del dopo-l’esplosione da un lato (i rifiuti, i residui dei vari Mad Max, ma non soltanto) e dall’altro della derealizzazione virtuale del corpo postmoderno.
 Qui si aprirebbero due discorsi, cui posso solo accennare: il primo sulla linea che porta al corpo del cinema di Cronenberg, alla “nuova carne” televisiva di Videodrome (1983) come alla protesi meccanico-consumistica di Crash (1996); il secondo sulla linea dell’Apocalisse di Coppola (1979), tematizzazione della perdita del centro, e, nella pratica realizzativa, espressione di un’enfatizzazione imperialistica del cinema che attraversa la New Hollywood nel tentativo, riuscito, di riconquista del mercato internazionale dopo la depressione degli anni Sessanta. Un’enfatizzazione che recupera il “centro”, collocandolo nel cinema stesso. Il corpo del cinema, il corpo virtuale, diviene la risposta al bisogno di un centro conseguente alla frattura e al relativismo della modernità.
Qui si aprirebbero due discorsi, cui posso solo accennare: il primo sulla linea che porta al corpo del cinema di Cronenberg, alla “nuova carne” televisiva di Videodrome (1983) come alla protesi meccanico-consumistica di Crash (1996); il secondo sulla linea dell’Apocalisse di Coppola (1979), tematizzazione della perdita del centro, e, nella pratica realizzativa, espressione di un’enfatizzazione imperialistica del cinema che attraversa la New Hollywood nel tentativo, riuscito, di riconquista del mercato internazionale dopo la depressione degli anni Sessanta. Un’enfatizzazione che recupera il “centro”, collocandolo nel cinema stesso. Il corpo del cinema, il corpo virtuale, diviene la risposta al bisogno di un centro conseguente alla frattura e al relativismo della modernità.

La relativizzazione operata dalla cultura moderna e l’eccesso di frantumazione e parcellizzazione proprio della società postmoderna troverebbe, per così dire, una nuova soluzione metafisica nel corpo virtuale del sistema dei media, di cui il cinema degli effetti speciali appare come la manifestazione esemplare.
Gli esempi potrebbero moltiplicarsi, segnalandoci una quantità di temi “postmoderni”. Sarebbe utile e interessante, ma la scelta di questa relazione è un’altra.
E allora, avviandomi a concludere, preferisco tornare a un discorso formale, con un esempio di “immersione” un po’ diverso da quelli di matrice “realtà virtuale” assunti da Jullier: il non-montato delle eveline e il contenitore “Fuori orario”.
Partirò da una suggestione antonioniana: non è forse un caso che tra Zabriskie Point e l’esplicita riflessione sullo sguardo e sul cinematografare di Professione: reporter, che è del 1975, Antonioni realizzi il suo lungo reportage sulla Cina. Ai materiali esplosi del consumo occidentale fanno da contrappunto i materiali di documentazione di un mondo sconosciuto. E non è un caso che, dopo il lasciarsi uccidere di Jack Nicholson reporter occidentale stanco di vedere, Antonioni giri Kumbha Mela, immagini grezze e quasi non montate di un rituale indù. Questo credo ci introduca alle eveline.
A differenza degli effetti speciali del film-concerto, nelle eveline non si tratta di immagini di sintesi, ma proprio del loro opposto. E tuttavia anche qui, come nel film-concerto, siamo fuori dal montaggio e fuori da una diegesi classica.
A differenza dal film-concerto, non troviamo nelle eveline la sofisticazione delle tecniche, non vi troviamo le figure stilistiche dello zoom vertiginoso e del carrello (spesso aereo o di sintesi) in avanti. E tuttavia non siamo fuori dal piacere; solo, sentiamo che questo piacere dipende da qualcosa di diverso, dal nostro essere spettatori di situazioni lontane da noi, con le quali, in virtù delle eveline, entriamo in contatto, attraverso una virtualizzazione che ripropone tuttavia la materialità del referente.
C’è qui qualcosa che ha a che fare con il piacere della conoscenza. Ma che tuttavia non è il piacere del reportage documentaristico o dello special televisivo.
Il non-montaggio e il non-commento hanno qui un valore decisivo. Essi segnalano una sospensione del discorso che è altra cosa dal discorso di defezione del film-concerto. Quest’ultimo si dà come programmatico ritiro dal discorrere, a vantaggio della sensazione e del piacere, mentre la sospensione del discorso propria delle eveline appare come una estremizzazione parossistica del dubbio della modernità: all’interno dell’autonarrazione ridondante della televisione, i materiali tendono a riacquistare una sorta di valore autonomo, un valore ancora non messo in atto, una possibilità di valore, una possibilità di senso. Questa sospensione dei discorsi noti ci riporta, mi sembra, al dubbio del moderno. Ma, per la dimensione che acquista, per la sua collocazione nel contenitore televisivo, per la molteplicità e varietà dei materiali presentati, questo rifiuto sistematico del commento sembra andare nella direzione della frantumazione, della perdita definitiva del centro, che, come si è detto, diviene dominante nel postmoderno.
“Fuori Orario” può essere guardato, probabilmente, come un grande testo postmoderno decostruzionista, per il suo esplicito gioco intertestuale, che fa dell’intertestualità il principio stesso della sua costruzione, per la particolare forza proiettiva che ha esercitato su più di una generazione di telespettatori, una proiettività fatta di “immersione”, ma anche di ricerca, la ricerca in atto di coloro che fanno la trasmissione, che assemblano pezzi, ristrutturandoli secondo attraversamenti che sono percorsi di senso, e soprattutto, mi sembra, la ricerca in progress di Ghezzi, di cui “Fuori Orario” è l’opera. Questo enorme testo decostruzionista, programmaticamente aperto, è guidato dal piacere, certamente, ma da un piacere molto selettivo, che dipende da un gusto preciso, il gusto per un cinema caratterizzato dal gesto esistenziale della sperimentazione, dalla messa in gioco del cineasta e del linguaggio, dalla messa in gioco dell’immagine come formalizzazione cinematografica del reale.
 L’esempio di “Fuori Orario” mi sembra sufficiente ad ampliare i confini dello stile postmoderno, oltre l’immersione del travelling aereo della sequenza di apertura di Le grand bleu e oltre la citazione e l’allusione cinefilistica.
L’esempio di “Fuori Orario” mi sembra sufficiente ad ampliare i confini dello stile postmoderno, oltre l’immersione del travelling aereo della sequenza di apertura di Le grand bleu e oltre la citazione e l’allusione cinefilistica.
Questi indici ci sono, ma c’è sempre, e ben esibita, l’istanza che li raccoglie e li ri-costruisce dopo averli decostruiti. All’illusoria onnipotenza spettatoriale cui invitano i film del “bagno di sensazioni” di cui parla Jullier, si contrappone qui il gesto — più timido e più narcisistico e gratuito, più esistenzialmente e paradossalmente “autoriale” — della proposta al pubblico. Una proposta che sta a mezza strada tra l’offerta del seno materno (ricordate il neonato della bellissima sigla di Schifano per La magnifica ossessione, nel 1985?) e il gioco degli scacchi; una proposta che investe l’intera personalità dello spettatore.
I concetti di autore, spettatore, superficie, classicità, nel moderno e nel postmoderno
Per concludere, vorrei accennare molto schematicamente ai concetti di autore, spettatore, superficie, classicità, in relazione alla domanda sul moderno e a quella sul postmoderno.
1) Il concetto di autore. Il moderno mette in discussione l’autore nell’accezione di creatore ereditata dalla tradizione romantica e idealistica. Nell’interrogare le cose e lo sguardo, il gesto della modernità cinematografica rimette in discussione tutto, anche il posto dell’autore, che si decentra, si autocritica, si frantuma in quanto soggetto idealistico.
È difficile trovare un’eguale operazione nel postmoderno. Il progetto che sorregge i testi che si offrono all’immersione spettatoriale è spesso, più o meno esplicitamente, istituzionale: il suo funzionamento assomiglia molto a quello del cinema classico hollywoodiano, talvolta semmai con un’esplicita introduzione della chiave autoriale, com’è il caso di Titanic.
Vi è tuttavia un limite, nel postmoderno, oltre il quale il gioco immersivo e quello intertestuale arrivano al punto di attenuare fortemente il riferimento a un autore. Nei casi in cui questo avviene, la differenza con il moderno mi sembra consista nel fatto che il cinema dell’autore vacillante e autonegantesi della modernità esibisce, al di là di tutto, un’istanza comunicativa basata sul “senso comune”, nell’accezione kantiana di fondamento trascendentale di una universalità di giudizio; laddove invece il cinema dell’autore inesistente della postmodernità esibisce un’incredulità, vera o presunta che sia, nei confronti del “senso comune”, un’incredulità giocata a volte sul piano del collage intertestuale, e non priva talvolta di un aspetto filosofico.
 È il caso, per esempio, delle immagini subliminali del demonio in Natural Born Killers di Oliver Stone, esempio forte di autoreferenzialità postmoderna, di immanenza del senso realizzata attraverso l’offerta, da parte di Stone, di uno spazio autonomo al Medium demoniaco: il Medium è il diavolo, dice in sostanza Stone, e queste immagini, più di cento in dodici secondi, sono la sua epifania. In questo caso è la sensazione che diviene luogo del “senso comune”, in accordo con la generale defezione del discorso postmoderna.
È il caso, per esempio, delle immagini subliminali del demonio in Natural Born Killers di Oliver Stone, esempio forte di autoreferenzialità postmoderna, di immanenza del senso realizzata attraverso l’offerta, da parte di Stone, di uno spazio autonomo al Medium demoniaco: il Medium è il diavolo, dice in sostanza Stone, e queste immagini, più di cento in dodici secondi, sono la sua epifania. In questo caso è la sensazione che diviene luogo del “senso comune”, in accordo con la generale defezione del discorso postmoderna.
2) Quanto allo spettatore, il senso comune che nonostante tutto sorregge l’autore moderno postula uno spettatore dubbioso, investito dal film sia a livello sensoriale sia, e maggiormente, a livello intellettuale. Lo stesso gioco intertestuale della modernità, portato su testi individuati, è un invito allo spettatore, perché prenda posizione sull’interpretazione che il film fa di quell’altro testo, o di quegli altri testi, che critica riproducendoli. Un esempio può essere ancora una volta Godard.
Lo spettatore postmoderno, invece, sembra investito principalmente, come dicevo, a livello sensoriale. Questo è vero in particolare per il cinema “immersivo”, ma in forma più attenuata vale anche per i giochi intertestuali della postmodernità, che sembrano distinguersi da quelli della modernità nel fatto che il cinema postmoderno manipola non questo o quel testo definito, ma elementi che hanno ormai abbandonato i testi di partenza e sono diffusi nel sociale, fanno parte del patrimonio iconografico, letterario o sonoro di una certa cultura. Il gioco cui lo spettatore è invitato, in questo caso, appare di carattere più ludico che critico.
3) Quanto alla superficie, se pensiamo l’immanenza del senso come una consapevolezza propria dell’intera cultura fenomenologica del Novecento, il moderno ci apparirà come cinema della superficie, in quanto esibisce autoriflessivamente l’interrogazione sull’atto stesso del cinematografare.
D’altra parte, la linea, “moderna” per eccellenza, Renoir-Rossellini-Bazin è esplicitamente la linea di un cinema dell’ “epidermide”.
Nel postmoderno, invece, il gioco delle superfici, non meno di quello immersivo, citazionale e allusivo, mi sembra rinviare talvolta a una profonda nostalgia di un centro, a una profonda nostalgia del classico.
Il cinema moderno non è nostalgico. Vuole liberarsi di “Dio”, e lo fa, e resta con un fondamento trascendentale che è l’opposto della certezza fideistica, ed è come l’esibizione del problema stesso dell’uomo, piuttosto che la sua soluzione metafisica.
Il cinema postmoderno oscilla invece tra una piena vita senza “Dio” (per intenderci, la tendenza “Fuori Orario”) e un gran bisogno di ritrovarlo, “Dio”, l’arca perduta della classicità.
In ogni caso, questa operazione, questa ricerca rinnovata del classico, presenta di norma un alto grado di coscienza, e segna anch’essa un momento alto di consapevolezza dello stadio attuale del sistema dei media.














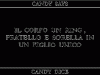






















Commenti
Non ci sono ancora commenti