 Quinto potere è un film che costituisce una base fondamentale per il discorso che seguirà alla proiezione, incentrato sul rapporto cinema-televisione. È fondamentale per due motivi: innanzitutto per quello che è il film, per quello che dice, per i suoi contenuti, per quanto racconta della realtà televisiva americana; protagonista ambientale è infatti una rete televisiva, fittizia ma fedele ai modi di conduzione delle tre grandi reti statunitensi (il titolo originale dell’opera infatti è “Network” che significa rete televisiva, in Italia tradotto in Quinto potere con un richiamo al film di Orson Welles Citizen Kane, che fu tradotto con Quarto potere).
Quinto potere è un film che costituisce una base fondamentale per il discorso che seguirà alla proiezione, incentrato sul rapporto cinema-televisione. È fondamentale per due motivi: innanzitutto per quello che è il film, per quello che dice, per i suoi contenuti, per quanto racconta della realtà televisiva americana; protagonista ambientale è infatti una rete televisiva, fittizia ma fedele ai modi di conduzione delle tre grandi reti statunitensi (il titolo originale dell’opera infatti è “Network” che significa rete televisiva, in Italia tradotto in Quinto potere con un richiamo al film di Orson Welles Citizen Kane, che fu tradotto con Quarto potere).
Dicevo che il film è interessante sia per quello che dice, sia per le intenzioni con le quali è stato fatto, per il modo con cui si pone come prodotto della cultura di massa. Per quanto riguarda quello che dice il film, mi limito a pochi riferimenti con la possibilità di riprendere il discorso dopo la proiezione.
È un film che mostra come dietro il fenomeno televisivo si agiti il background di una collettività massificata e di un capitalismo infido. Le scelte dominanti che riguardano la programmazione televisiva sono quelle delle leggi di ascolto più ancora di quelle delle leggi di gradimento: il punto di riferimento è cioè costituito dalla quantità del pubblico. Il tutto sullo sfondo di una grande dittatura finanziaria, che domina il destino di questa rete. Nello stesso tempo, lo schermo televisivo agisce appiattendo tutta quanta la realtà (e questo sarà uno dei temi fondamentali del nostro discorso successivo): tutti gli eventi più tragici, le guerre, le morti, i delitti, sono portati ad una dimensione insignificante, sono deprivati della loro intensità, della loro dimensione di forza drammatica, del loro spessore; sono annullati in una frantumazione ridicola dello spazio e del tempo. Tutto, sul televisore, diventa equivalente. Vedrete nel film, addirittura, come movimenti rivoluzionari, contestatori, vengano facilmente strumentalizzati dal capitale e adeguati alle intenzioni politiche ed economiche della rete. Una rete che fa mercato anche del rimorso di alcuni protagonisti della sua gestione e del sermone.
 Protagonista del film è un telecronista in crisi perché il suo indice di ascolto si è notevolmente abbassato: egli annuncia in televisione che si suiciderà. A quel punto, la notizia crea nella “marmellata” televisiva generale un istante d’interesse da parte del pubblico e allora il capitale ne approfitta: una donna, responsabile della programmazione e carica d’aggressività caratteristica, vuole trasformare questo individuo ormai rotto psicologicamente in un nuovo strumento di aggancio spettacolare. Il nostro si mette a fare alla televisione dei discorsi a metà strada tra il sermone religioso o etico e il qualunquismo politico, esibendosi in interventi che hanno immediatamente un grande successo popolare.
Protagonista del film è un telecronista in crisi perché il suo indice di ascolto si è notevolmente abbassato: egli annuncia in televisione che si suiciderà. A quel punto, la notizia crea nella “marmellata” televisiva generale un istante d’interesse da parte del pubblico e allora il capitale ne approfitta: una donna, responsabile della programmazione e carica d’aggressività caratteristica, vuole trasformare questo individuo ormai rotto psicologicamente in un nuovo strumento di aggancio spettacolare. Il nostro si mette a fare alla televisione dei discorsi a metà strada tra il sermone religioso o etico e il qualunquismo politico, esibendosi in interventi che hanno immediatamente un grande successo popolare.
Dopo un po’ di tempo questo programma stanca il pubblico e il sistema non può far altro che eliminare, con un’operazione che qualche critico ha definito di eutanasia, il personaggio. Si oppone però il capo di tutta la rete che è interessato a portare avanti la trasmissione pensando di compensare le eventuali perdite economiche in altro modo. Così proprio il capo della rete si muove contro la struttura generale della produzione televisiva in quel paese, che obbedisce ad un modello applicato ormai in tutto il mondo e va contro alle leggi fondamentali del fenomeno televisivo: deve quindi essere sconfitto, a sua volta, con l’uccisione dell’ex presentatore sermoneggiante.
È un film in cui si manipola la rabbia americana da parte di speculatori televisivi. C’è un solo personaggio che conserva una dimensione umana e infatti viene licenziato dall’esercizio televisivo: si tratta di un protagonista critico e autocritico nei confronti dell’apparato, che ha coscienza di trovarsi di fronte “ad un’intera generazione di persone che hanno conosciuto e conoscono la vita attraverso la televisione”. Il film sostiene una tesi di cosmologia del dollaro: il mondo appare trasformato in un grosso universo di affari. È un film corale, che integra la vicenda centrale, di cui sono protagonisti il cialtrone che fa discorsi alla TV e la donna che lo sfrutta, in un quadro d’ambiente popoloso e piuttosto acuto. È una realtà molto tragica quella che mostra il film, quella di un mondo di umanoidi, incapaci di vivere al di fuori della dimensione televisiva.
Qualcuno ha letto questo film come un pamphlet polemico contro la televisione realizzato dal cinema-cugino. Si tratta di un discorso, ha detto qualcuno, fatto dall’interno del mondo televisivo, un discorso inquietante, filtrato d’angoscia. l protagonista e la sua malattia sono sfruttati per produrre rubriche nuove, che coinvolgano, che facciano esplodere la frustrazione e lo scontento delle masse incollate al video, che ne sappiano interpretare gli umori e la tensione. Libello satirico contro la televisione, qualcuno sostiene.
A mio parere, è invece un film che s’integra alla perfezione nel sistema delle comunicazioni di massa, almeno in quello dell’audiovisivo. È un film al quale nuoce l’ambizione di far emergere, dal paradosso che ci presenta, un apologo sulla fine dell’individuo e della democrazia in un mondo trasformato in una vasta, ecumenica società finanziaria. È un attacco duro del cinema alla cugina-televisione? A mio parere, solo in superficie. In realtà il discorso è molto più complesso e i problemi che il film ci pone sono molto semplificati, al punto da falsificare addirittura alcune procedure tipiche del rapporto fra televisione e pubblico.
Il pubblico televisivo non è certamente quello che ci propone questo film ed è molto più variegata la sua reazione. La TV di Lumet, cioè, è una specie di baraccone, il frutto di una spettacolarizzazione forzata, a volte al limite dell’inverosimile: è più sfruttata in questo film, che non affrontata; un po’ come Bill, il protagonista, che è più sfruttato dalla UBS (il nome inventato per la compagnia televisiva) che non criticamente affrontato.
Il film, come avete visto nei titoli di testa, è del 1976; si può dire che l’universo delle comunicazioni di massa, dal punto di vista tecnologico, e di conseguenza sociale e antropologico, corre molto rapidamente, nel senso che questo film puzza già di antiquariato nei confronti di quanto succede oggi nel mondo delle comunicazioni di massa, nell’universo elettronico della televisione.
Invitato a tenere una conversazione sui rapporti fra cinema e televisione, caratterizzerò subito i due mezzi, dicendo forse delle banalità, ma costituendo comunque una base di presupposti comuni tra di noi. Col nome cinema s’intende un apparato, generalmente industriale, che produce racconti a livello enunciativo su pellicola, per una distribuzione internazionale (almeno, la tendenza è questa), che si svolga in sale pubbliche. Il cinema si può caratterizzare come un produttore di eventi ancora marcati da una caratteristica di festività) cioè d’interruzione della quotidianità, della norma. Lo spettatore che va al cinema interrompe la sua giornata, sceglie un determinato film, si colloca in un determinato ambiente e vede, o almeno può rivedere più volte, una pellicola; può andarsene ad un certo punto, anche se di solito ha pagato un biglietto e si ferma sino alla fine del film.
Questo circuito industriale cinematografico caratterizzato festivamente (che ha quindi, da questo punto di vista, rapporti stretti con l’esperienza teatrale) ha comportato per decenni, dall’inizio del secolo fino a pochi anni fa, la costruzione di un immaginario collettivo, universale, internazionale. I divi dello schermo, i modelli e le situazioni proposte dallo schermo erano beni comuni ad individui appartenenti a società diverse. I film più importanti della produzione hollywoodiana — Hollywood è stata l’industria più esemplare da questo punto di vista — hanno costituito dei veri e propri modelli di fruizione, di valore, di comportamento; sono modelli socio-culturali, modelli etici, per il mondo intero.
La televisione si caratterizza invece per una serie di elementi completamente differenziati rispetto a quelli del cinema, proponendo su di uno schermo delle immagini in movimento: dal punto di vista tecnico, dal punto di vista di quello che tradizionalmente si definiva come linguaggio, la televisione è molto vicina al cinema, almeno apparentemente. Le origini della televisione in ogni stato, in ogni situazione sono sempre state caratterizzate da discorsi sulla filiazione del nuovo mezzo da parte del cinema. Tutti i saggi che parlano di linguaggio televisivo, in tutto il mondo, fino ad una quindicina di anni fa, parlano sempre di rapporto analogico fra cinema e televisione: l’unico elemento che avrebbe potuto differenziare i due mezzi sarebbe consistito nella caratterizzazione del montaggio elettronico da una parte e del montaggio alla moviola per il cinema dall’altra.
Il montaggio elettronico comporta, nel caso specifico della diretta, una rincorsa dell’evento, della situazione, quindi la necessità di avere a disposizione più telecamere e di passare da un’immagine all’altra direttamente. Poi, evolvendosi, la televisione ha inventato le tecniche di registrazione su nastro magnetico che hanno consentito sempre più sofisticati interventi di montaggio, per cui oggi elettronicamente si gira, più o meno, come si gira cinematograficamente. La caratterizzazione fondamentale dell’esercizio televisivo si è rivelata per anni non tanto quella di una ripetizione delle modalità del cinema, quanto piuttosto l’aggancio diretto con la realtà o un apparente aggancio diretto con la realtà, con la quotidianità dello spettatore. Da qui deriva quella “marca” feriale della televisione che in un primo momento si rivela come una caratteristica banale, esteriore (lo spettatore che vive la sua giornata documentato dall’esercizio televisivo, da uno dei tanti esercizi televisivi ai quali può accedere). Ma in un secondo momento questa ferialità diventa proprio piattezza, omogeneità, eliminazione reciproca fra un canale e l’altro, fra una trasmissione e l’altra, delle punte, delle emergenze.
 Procediamo con ordine. All’inizio degli anni Ottanta, possiamo dire che tutto quanto è stato detto a proposito del cinema e lo stesso cinema inteso come fenomeno festivo siano decisamente in crisi. È in crisi lo stesso immaginario collettivo creato dal cinema e non tanto perché la gente non frequenta più le sale, quanto perché proprio l’uso aberrante della televisione ha comportato una saturazione di immagini, di linguaggio audiovisivo, che ha finito per emarginare quella caratterizzazione festiva, tipica del rapporto fra spettatore e cinema. Oggi possiamo dire che l’audiovisivo si caratterizza in virtù di fenomeni di continuità, di serialità, appunto di quotidianità, di secolarizzazione. Pensiamo, per esempio, alle dimensioni dei testi presentati dal cinema o dalla televisione: come sapete, il cinema (parlo del cinema industriale narrativo, perché esistono tanti altri tipi di cinema, come quello pubblicitario, quello industriale, quello scolastico, ecc.) il cinema dunque aveva stabilito una durata specifica per i suoi film, durata che ha subito poche variazioni nella sua storia, salvo episodi eccezionali. Pensate a Bertolucci, che gira Novecento e che divide però il testo in due parti, perché non era normale e non lo è tuttora passare cinque ore di fronte ad uno schermo. Ma la storia del cinema presenta molti altri episodi analoghi: pensate a Von Stroheim, che gira in America Greed e lo monta in una pellicola di otto ore; a quel punto la produzione hollywoodiana licenzia il regista e monta il film in due ore; oggi Greed circola nelle cineteche in un’edizione che non è quella stabilita dal regista, nonostante ne mostri la firma.
Procediamo con ordine. All’inizio degli anni Ottanta, possiamo dire che tutto quanto è stato detto a proposito del cinema e lo stesso cinema inteso come fenomeno festivo siano decisamente in crisi. È in crisi lo stesso immaginario collettivo creato dal cinema e non tanto perché la gente non frequenta più le sale, quanto perché proprio l’uso aberrante della televisione ha comportato una saturazione di immagini, di linguaggio audiovisivo, che ha finito per emarginare quella caratterizzazione festiva, tipica del rapporto fra spettatore e cinema. Oggi possiamo dire che l’audiovisivo si caratterizza in virtù di fenomeni di continuità, di serialità, appunto di quotidianità, di secolarizzazione. Pensiamo, per esempio, alle dimensioni dei testi presentati dal cinema o dalla televisione: come sapete, il cinema (parlo del cinema industriale narrativo, perché esistono tanti altri tipi di cinema, come quello pubblicitario, quello industriale, quello scolastico, ecc.) il cinema dunque aveva stabilito una durata specifica per i suoi film, durata che ha subito poche variazioni nella sua storia, salvo episodi eccezionali. Pensate a Bertolucci, che gira Novecento e che divide però il testo in due parti, perché non era normale e non lo è tuttora passare cinque ore di fronte ad uno schermo. Ma la storia del cinema presenta molti altri episodi analoghi: pensate a Von Stroheim, che gira in America Greed e lo monta in una pellicola di otto ore; a quel punto la produzione hollywoodiana licenzia il regista e monta il film in due ore; oggi Greed circola nelle cineteche in un’edizione che non è quella stabilita dal regista, nonostante ne mostri la firma.
Fra l’altro, questa riduzione ad una formula oraria precisa ha comportato anche, necessariamente, scelte di determinati tipi di temi e, soprattutto, di determinate formule di linguaggio: il film corrisponde quasi sempre al romanzo breve, alla novella, se vogliamo stabilire un rapporto con la produzione letteraria; il grande racconto, il grande romanzo, può passare in un film, ma si riduce quasi sempre ad una struttura vuota di eventi, in cui si perde tutto lo spessore del commento presente nel testo. La televisione, da questo punto di vista, ha maggiori possibilità, perché può ricorrere all’appuntamento a puntate con lo spettatore: però scattano altri procedimenti di normalizzazione, altre abitudini di uso dell’immagine da parte dello spettatore, per cui la suddivisione in puntate non comporta automaticamente una qualità del prodotto tratto da un’opera letteraria superiore a quella della produzione cinematografica.
L’avvento della televisione ha comportato invece una frattura delle tradizionali unità di misura del cinema, sia all’interno del suo stesso esercizio, dove si va da pièces di dieci minuti a pièces di un’ora, un’ora e mezzo (in genere, però, si tende a non superare l’ora, soprattutto nei paesi in cui i prodotti sono finanziati direttamente dagli sponsor pubblicitari), sia soprattutto nell’ambito del cinema almeno dagli anni ’60 in poi: vi si producono infatti testi disomogenei quantitativamente, dal punto di vista della durata, rispetto a quelli tradizionali, per cui si va da film molto brevi, generalmente settoriali e specifici (cinema di ricerca, di avanguardia, cinema pubblicitario, ecc.) a film molto lunghi, film d’immagine sul territorio, per esempio, film scientifici, la cui destinazione non è più quella del pubblico di massa, ma solitamente un’utenza precostituita, omogenea al suo interno. Ciò nonostante l’impatto fra elettronica e pellicola ha comportato una massificazione universale ancora più marcata, nel senso che quello che era il mercato del cinema è diventata oggi il mercato della televisione, il mercato del videotape: assistiamo all’invasione dei telefilm angloamericani, di serial che passano sia attraverso le televisioni private sia attraverso quella pubblica, ma siamo ancora alle origini del fenomeno.
I giapponesi inviano già i loro cartoni animati gratuitamente all’Europa perché sanno che una volta che un loro prodotto passa sul teleschermo diventa elemento trainante di circuiti economici, commerciali molto ampi: le magliette, i pupazzi, i dischi, i libri… non c’è miglior pubblicità per i contenuti di quei cartoni animati che il passaggio su una rete.
Il rapporto fra televisione e film si è manifestato in quattro fasi diverse, di cui noi stiamo oggi vivendo l’ultima. In un primo momento, la televisione ha sentito il cinema come qualcosa di molto importante ma non direttamente interessante la propria attività e quindi si è servita del cinema come di un riempitivo per propri vuoti di programmazione. È quello che è avvenuto agli inizi delle emissioni RAI e che sta avvenendo ancora in molte emittenti private d’Italia: è necessario riempire un palinsesto e si va alla ricerca di un film e poi di un altro ancora con una casualità d’impatto notevolissima.
In un secondo momento, la situazione della televisione nei confronti del cinema si manifesta invece in un ruolo di sudditanza psicologica e culturale. La televisione sente il cinema come un universo storicizzato e legittimato nel contesto sociale e non si limita più a fare dei prelievi casuali, ma cerca di organizzarsi in una specie di cineclub popolare: ecco allora le serie, gli autori, i periodi, le scuole, gli attori, le schede critiche quasi sempre piuttosto noiose. A parte gli esiti, il tentativo è quello di considerare il cinema come un universo antecedente quello televisivo, in cui la televisione si poteva in certo qual modo rispecchiare e che la televisione utilizzava con grande rispetto. Questa è, più o meno, la situazione degli anni ’60, che si rispecchiava, anche, nell’ambito dell’impegno professionale. Chi faceva televisione, allora, la considerava come un gradito intermedio per arrivare al cinema: a tutti i livelli, dal tecnico al regista, dall’autore al programmista; oppure come riempitivo professionale. Qualche importante regista cinematografico poteva lavorare per la televisione, ma con la mano sinistra, nell’attesa di girare il grande film.
La terza fase, in cui la televisione ha cominciato ad acquistare una dimensione anche socialmente molto importante, una legittimazione addirittura eccessiva, ha comportato invece un rapporto inverso. Il cinema si è sentito emarginato rispetto la televisione: nella grande crisi cinematografica degli anni ’70, la televisione, gli enti televisivi tendono a produrre film essi stessi, non tanto per il loro mercato, ma per il normale circuito cinematografico. In realtà i film prodotti dalla RAI in Italia negli anni ’70 sono destinati al grande schermo, senza alcun tentativo da parte dei loro autori di adattamento allo schermo televisivo e alle sue esigenze di ritmo e di linguaggio. In questa terza fase la televisione diventa una specie di banca (si tratta di un fenomeno che non riguarda solamente l’Italia) e, nello stesso tempo, una fucina di idee per il cinema, anche perché la televisione non condiziona i registi attraverso quei limiti commerciali ai quali il produttore privato subordina solitamente le proprie istanze.
Rileggendo le interviste di Fellini, di Antonioni e di tutti quelli che hanno lavorato per la televisione italiana, ci si accorge come rimarchino il fatto di non essersi mai sentiti così liberi come in queste loro esperienze. La RAI è infatti un produttore che per statuto non può guadagnare e che quindi non aveva alcun tipo di progetto sulle possibilità economiche di questi film. Nella terza fase s’inverte dunque il rapporto precedente: la televisione diventa un universo di riferimento, molti personaggi dell’ambiente cinematografico cominciano a pensare alla televisione non più come ad un riempitivo occasionale, ma come al vero fine della loro ricerca o del loro impegno culturale e professionale.
 La quarta fase infine, quella che stiamo vivendo attualmente, consiste in una decisa sovrapposizione dei due universi. Oggi non si può più parlare correttamente di cinema o di televisione: stanno perfezionando un nuovo tipo di televisione, definita “ad alta definizione”,che comporterà la possibilità di proiettare l’immagine televisiva su di un grande schermo con una definizione analoga a quella della pellicola a 35 mm. A quel punto anche le sale cinematografiche, quelle che sopravviveranno, potranno ricevere impulsi da videotape, impulsi videomagnetici, e quindi la pellicola non sarà più necessaria. Una stessa emittente potrà collegarsi con più sale e non sarà più necessario girare i film su pellicola (tra l’altro, l’uso del tape è più economico e, soprattutto, il prodotto del nastro magnetico è controllabile immediatamente, mentre nel cinema bisogna aspettare le fasi dello sviluppo e della stampa. Antonioni ha girato Il mistero di Oberwald elettronicamente, cioè su videotape, proprio per poter controllare con la sua sensibilità cromatica i colori dell’immagine direttamente alla fine di ogni ripresa; poi, però, volendo portare questo prodotto nelle sale cinematografiche ha dovuto riversare il nastro magnetico su pellicola cinematografica, con ingenti spese aggiuntive per la RAI). È ormai assurdo distinguere tecnologicamente la base elettronica da quella in pellicola, l’universo del cinema da quello della televisione. Ma è anche abbastanza difficile distinguerli a livello operativo concreto e a livello culturale: le più grandi case di produzione americane ormai girano serial televisivi con opportuni raccordi per ricavarne dei film; si tratta di prodotti che nascono già per due circuiti, quello televisivo e quello delle sale cinematografiche. La decisione di fare uscire la pellicola più o meno contemporaneamente alla serie dipende da ricerche di mercato.
La quarta fase infine, quella che stiamo vivendo attualmente, consiste in una decisa sovrapposizione dei due universi. Oggi non si può più parlare correttamente di cinema o di televisione: stanno perfezionando un nuovo tipo di televisione, definita “ad alta definizione”,che comporterà la possibilità di proiettare l’immagine televisiva su di un grande schermo con una definizione analoga a quella della pellicola a 35 mm. A quel punto anche le sale cinematografiche, quelle che sopravviveranno, potranno ricevere impulsi da videotape, impulsi videomagnetici, e quindi la pellicola non sarà più necessaria. Una stessa emittente potrà collegarsi con più sale e non sarà più necessario girare i film su pellicola (tra l’altro, l’uso del tape è più economico e, soprattutto, il prodotto del nastro magnetico è controllabile immediatamente, mentre nel cinema bisogna aspettare le fasi dello sviluppo e della stampa. Antonioni ha girato Il mistero di Oberwald elettronicamente, cioè su videotape, proprio per poter controllare con la sua sensibilità cromatica i colori dell’immagine direttamente alla fine di ogni ripresa; poi, però, volendo portare questo prodotto nelle sale cinematografiche ha dovuto riversare il nastro magnetico su pellicola cinematografica, con ingenti spese aggiuntive per la RAI). È ormai assurdo distinguere tecnologicamente la base elettronica da quella in pellicola, l’universo del cinema da quello della televisione. Ma è anche abbastanza difficile distinguerli a livello operativo concreto e a livello culturale: le più grandi case di produzione americane ormai girano serial televisivi con opportuni raccordi per ricavarne dei film; si tratta di prodotti che nascono già per due circuiti, quello televisivo e quello delle sale cinematografiche. La decisione di fare uscire la pellicola più o meno contemporaneamente alla serie dipende da ricerche di mercato.
Ma tutto questo non mi sembra ancora significativo per definire le conseguenze dell’impatto di un nuovo universo audiovisivo nel contesto sociale. Siamo di fronte ad una serie ricchissima di innovazioni tecnologiche: dalle televisioni via cavo, che sono spesso a pagamento e comportano la possibilità di avere a disposizione una specie di self-service giornaliero di programmi, dall’uso del televisore domestico come terminale (in Inghilterra, in Francia, in Germania, negli Stati Uniti, in Giappone, si è già superata la fase sperimentale; in Italia, a Milano, è già in corso in questi giorni una sperimentazione con mille abbonati al Videotel) alla possibilità non del tutto utopica di avere il film a casa facendo riferimento a banche cinematografiche, a banche di videotape; dal videodisco, che già esiste e non viene messo sul mercato perché rovinerebbe quello del disco normale, alla teleconferenza…
Mi sembra che un elemento caratterizzante questa società contemporanea, soprattutto dal punto di vista dell’uso dell’audiovisivo, potrebbe essere individuato nella moltiplicazione speculare, nella riproduzione, nella memoria, intesa non nel senso individuale e personale ma in quello elettronico del terminal, nel senso cioè del computer, del cervello elettronico: memoria come accumulo, magazzino dei dati. Siamo di fronte ad un’epoca che memorizza tutto; le sedi televisive si stanno trasformando in spazi che accumulano videocassette. Fino a qualche anno fa dominava la mania della distruzione, nel cinema per esempio, dove molti film sono andati perduti. Oggi questa grande follia è stata sostituita da un’altra, quella della non selezione, per cui tutto sembra trasformarsi in elemento memorizzabile, tutto sembra già trasformarsi in storia. Viviamo in un’epoca di archeologia in divenire.
 Pensate a quanto sta avvenendo nel campo della pratica fotografica: non si è mai fotografato tanto come in questi anni e i libri di fotografia vengono venduti in grandi quantità. I libri di fotografia ci sono sempre stati, ma fino ad oggi si appoggiavano quasi sempre a testi, poetici o illustrativi; ora vengono invece più spesso venduti libri in cui la fotografia ha una sua pregnanza, una sua autonoma significatività: e finché le cose stanno così va tutto bene; purtroppo, però, l’uso della fotografia assume un senso stravolgente la sua natura. Ogni clic agito nei confronti della realtà viene vissuto come una presa di possesso, si crede di più alla fotografia che alla realtà stessa. C’è un film di Godard molto interessante, Les carabiniers, in cui due poveracci vengono presi e mandati in guerra con la promessa di un grande bottino. Tornano a casa dopo la fine della guerra con due grandi valigie, e quando le mogli chiedono “dov’è il bottino?” aprono le valigie e tirano fuori cartoline di tutto il mondo: “il nostro bottino è S. Pietro a Roma — e mostrano delle fotografie — Place Pigalle, il grattacielo di Manhattan, la statua della Libertà…”.
Pensate a quanto sta avvenendo nel campo della pratica fotografica: non si è mai fotografato tanto come in questi anni e i libri di fotografia vengono venduti in grandi quantità. I libri di fotografia ci sono sempre stati, ma fino ad oggi si appoggiavano quasi sempre a testi, poetici o illustrativi; ora vengono invece più spesso venduti libri in cui la fotografia ha una sua pregnanza, una sua autonoma significatività: e finché le cose stanno così va tutto bene; purtroppo, però, l’uso della fotografia assume un senso stravolgente la sua natura. Ogni clic agito nei confronti della realtà viene vissuto come una presa di possesso, si crede di più alla fotografia che alla realtà stessa. C’è un film di Godard molto interessante, Les carabiniers, in cui due poveracci vengono presi e mandati in guerra con la promessa di un grande bottino. Tornano a casa dopo la fine della guerra con due grandi valigie, e quando le mogli chiedono “dov’è il bottino?” aprono le valigie e tirano fuori cartoline di tutto il mondo: “il nostro bottino è S. Pietro a Roma — e mostrano delle fotografie — Place Pigalle, il grattacielo di Manhattan, la statua della Libertà…”.
In una mostra che ho organizzato a Venezia un anno e mezzo fa sul tema del tempo nella società contemporanea, ho scoperto persone che fotografano e non stampano e abbiamo così esposto questi rullini segnati con luogo e data: non c’è il tempo di vedere le fotografie, ma addirittura nemmeno quello di stamparle. Questo atteggiamento nei confronti della realtà, di distacco completo dalla realtà, è un po’ un tema sotterraneo, e neanche troppo, del film al quale abbiamo assistito: quando Bill dice in uno dei suoi interventi “voi credete alla televisione, ma dimenticate la vostra realtà”, dal suo discorso emerge prepotentemente qualche cosa di vero, così come quando la protagonista Diane si trasforma in pupazzo che non ha nessun aggancio con la realtà. Ebbene, questo atteggiamento filtra attraverso tutte le comunicazioni di massa, soprattutto attraverso le comunicazioni elettroniche. La radio sembra sempre più portata sia a livello privato che a livello pubblico, ad applicare il modello dominante del “calcio minuto per minuto” che consiste in più collegamenti con più reti in diretta, per produrre una sensazione di dominio nei confronti della realtà; la realtà non è tanto quel fatto, quell’evento, quel sentimento, quel rapporto diretto con le cose, ma è l’immagine, sonora, visiva e audiovisiva.
La televisione ha fatto dell’informazione il suo modello dominante per cui il teatro è scomparso dalla sua programmazione, regge ancora il. teleromanzo ma sarà presto scalzato dai serials fatti in Italia secondo i modelli americani. La televisione imposta il modello dell’attualità in qualsiasi sua trasmissione e il cinema, quello non tradizionale, per reggere il confronto è costretto ad impegnarsi in quanto la televisione non può concedersi. Il cinema americano ha prodotto grandi show ricchi di effettistica — non è un caso che la serie della fantascienza sia nel momento di maggior contrasto con la televisione, di maggior interazione emersa da parte della televisione nei confronti del cinema: Incontri ravvicinati di terzo tipo, Guerre stellari sono prodotti che si pensava la televisione non potesse fare. Ma oggi la televisione può, elettronicamente, produrre trucchi molto superiori a quelli del cinema, e a minor costo, tant’è vero che Lucas, regista cinematografico di molti di questi film di fantascienza, si è impegnato come produttore sfruttando il trucco elettronico applicato all’immagine cinematografica.
Non si possono più separare i due universi: c’è, a proposito della fotografia una frase di Susan Sontag che mi sembra molto significativa per qualificare questa situazione nel campo degli audiovisivi. Dice la Sontag che viviamo sotto la minaccia continua di due prospettive ugualmente spaventose: una banalità ininterrotta e un terrore inconcepibile; gli audiovisivi tendono ad unificare tutto, ad anestetizzare tutto con la banalità; oppure ,per attrarre e coinvolgere lo spettatore, devono trovare occasioni di rottura, di drammaticità violenta. La visione attraverso lo schermo suggerisce allo spettatore il controllo della realtà: attraverso la televisione, le contraddizioni più esasperanti, i disordini più brutali, i conflitti più tremendi -lo si è visto anche in questo film — si dispongono lungo un filo narrativo suggerito appunto dalla visione, spesso costruito dallo stesso telespettatore. In fondo, una letteratura e un cinema dell’orrore esistono già, e il rischio è che anche la realtà assuma sul teleschermo la dimensione di una storia dell’orrore: ci si abitua a tutto, un terremoto è già stato visto molte volte attraverso la televisione, una disgrazia è stata vista molte volte; non è un caso che le televisioni indipendenti americane facciano in questo momento la guerra alle tre grandi reti — non sono quattro come si diceva nel film — presentando nel telegiornale soprattutto fatti della quotidianità, l’incendio e i cadaveri dei bambini con la madre che piange, tutti gli eventi che i telegiornali ufficiali scartano perché non assurgono al ruolo di notizia determinante al livello nazionale.
Si dice che la tecnologia elettronica abbia ucciso il cinema e con il cinema anche l’immaginario collettivo che questo aveva costruito. In realtà, questo immaginario vive ancora con la sovrapposizione di tanti piccoli immaginari collettivi che si chiamano Radici, Fonzie, Goldrake, Mazinga, Dallas con buona pace dei sociologi sempre all’erta, fra i quali c’è anche chi consente questo stato di cose, perché scompaiono i grandi miti di riferimento e lo spettatore è molto più libero di scegliersi quanto vuole dal menu televisivo.
La realtà è un’altra, lo spettatore non è affatto libero; si è verificato, attraverso ricerche, che lo spettatore medio italiano, per esempio, è molto suggestionato ad un livello di superficialità esteriore nel contatto con i programmi televisivi; la sua soglia d’interesse è determinata solo dalla noia, ma da una noia critica: non appena la trasmissione pretende un impegno critico, lo spettatore cambia canale, ricorrendo a quell’apparecchietto che tutti conosciamo e che consente di farsi un montaggio personale attraverso tutti i diversi segnali che il teleschermo riceve. La letteratura ha costruito buona parte del suo impero culturale basandosi sul racconto: soprattutto dopo l’evento dell’industria culturale, dopo l’invenzione della stampa, è stata portata avanti l’istanza narrativa. Anche il cinema si è immediatamente imparentato con la narrativa letteraria, mutandone i propri modelli; è difficile vedere film che non abbiano struttura narrativa se non nel campo dell’avanguardia, della ricerca, o in quello della pubblicità, nell’ambito scientifico, ecc.
 Anche molti film di ricerca presentano un testo narrativo: per esempio, i primi due film surrealisti di Buñuel, L’age d’or e Un chien andalou. Televisione e cinema hanno costruito i loro imperi sulla istanza narrativa e non è un caso che alla crisi del libro, soprattutto del libro di narrativa, abbia corrisposto anche la crisi del cinema, del cinema industriale. Cosa significa raccontare? Usare nei confronti della realtà un punto di vista, mettersi in un’ottica analoga a quella prospettiva rinascimentale. Il racconto — il racconto vero — implica la presenza di uno sguardo che conosca tutte le cose, lo sguardo della storia o di un narratore personalizzato, o di un personaggio…
Anche molti film di ricerca presentano un testo narrativo: per esempio, i primi due film surrealisti di Buñuel, L’age d’or e Un chien andalou. Televisione e cinema hanno costruito i loro imperi sulla istanza narrativa e non è un caso che alla crisi del libro, soprattutto del libro di narrativa, abbia corrisposto anche la crisi del cinema, del cinema industriale. Cosa significa raccontare? Usare nei confronti della realtà un punto di vista, mettersi in un’ottica analoga a quella prospettiva rinascimentale. Il racconto — il racconto vero — implica la presenza di uno sguardo che conosca tutte le cose, lo sguardo della storia o di un narratore personalizzato, o di un personaggio…
Ma all’origine del discorso narrativo c’è sempre un unico punto di vista, che è anche quello che sta all’origine del cinema tradizionale, soprattutto di quello hollywoodiano. La televisione e la radio nascono nel periodo di dominio dell’industria letteraria e del cinema e ne imitano all’inizio le formule narrative: producono testi teatrali, e molti sceneggiati, e riproducono secondo le regole del linguaggio audiovisivo le strutture narrative della letteratura, come già faceva il cinema. In questa situazione rimangono istanze privilegiate del campo sociale; ma quando la radio e la televisione scoprono la loro vera natura, che non è tanto quella di raccontare, ma quanto quella di mostrare, mettono in crisi la logica narrativa del punto di vista unificante nei confronti della realtà. Aprono i loro discorsi a più punti di vista e determinano quell’intreccio tra logiche diverse, che stiamo vivendo proprio in questi anni. Perché con un interlocutore che mi parla da un suo punto di vista posso dialogare, posso contestare e contrapporre il mio punto di vista…
Fino a che in Italia la televisione era una sola, la RAI, si poteva odiarla, detestarla, ma esisteva un rapporto con un soggetto preciso, tant’è vero che non si parlava mai di RAI, ma generalmente di televisione. Quando comincia ad aumentare il numero delle emittenti e quando va in crisi il punto di vista unificante della cultura di massa tradizionale, il punto di vista narrativo (le due cose si verificano quasi sempre contemporaneamente), salta tutto il sistema della comunicazione e dell’informazione. Siamo di fronte ad un universo di segnali che ci colpiscono da tutte quante le parti e non sappiamo effettivamente da dove provengano. È difficile stabilire oggi le iscrizioni ideologiche di certi discorsi, è difficile stabilire chi parla in televisione e chi parla nel cinema. È difficile, perché da una parte c’è una grande confusione dal punto di vista dell’emittenza, ma anche perché sta diffondendosi l’uso del teleschermo che è superficiale, consumistico; un uso che riduce enormemente tutte le capacità di dialogo con il teleschermo da parte dello spettatore, a favore di un atteggiamento di completa passività. Si guarda la televisione come si mangia un gelato. Non è difficile applicare a questa società le categorie che Heidegger applicava alla sua, quella della chiacchiera, che non ha nulla a che vedere con la conversazione, della curiosità e dell’equivoco.
Il boom elettronico ha comportato non soltanto una sovrapposizione tra cinema e televisione, ma una spersonalizzazione dell’emittente favorita dalla proliferazione delle fonti. Va quindi in crisi la logica visiva, monovisiva, della cultura di massa, la logica del discorso e della comunicazione intenzionale; nasce una nuova logica che, per quanto falsificante, più illusoria dell’altra, perché non sostituisce al discorso la realtà, ma una confusione, una marmellata di discorsi, finisce per metterne fuori gioco i prodotti. Potremmo definirla come una logica del doppio che si ripete all’infinito, logica di un’archeologia che non necessita di selezione. Una logica di cancellazione totale del tempo: il passato non interessa più, il futuro interessa solo per averlo già qui e per predeterminarlo. Tutto ha la possibilità di accedere alla storia.
In un racconto breve molto bello di Borges, alcuni cartografi volevano fare un piacere all’imperatore, producendo una carta dell’impero molto precisa, perfetta: studiarono tanto finché fecero una carta in scala 1 : 1; tutto l’impero era ricoperto da questa carta geografica ed erano convinti di aver fatto una grande invenzione. In realtà quella carta geografica non serviva a nessuno, perché non consentiva alcun tipo di approccio conoscitivo alla realtà di quello stato. I frammenti di quella carta intralciavano ancora molti anni dopo i passi dei viandanti, non solo non serviva a niente, ma costituiva un ostacolo alla vita quotidiana. La sovrabbondanza dell’informazione, l’esplosione del sistema elettronico comportano l’impossibilità di un accesso conoscitivo al mondo, sia dal punto di vista di chi fa i messaggi, sia soprattutto dal punto di vista di chi li usa, che finisce per immergersi in un mondo attraversato da echi, ricco di specchi; ma sono echi e immagini di cui non si conosce la provenienza e di cui, soprattutto, non si conosce il fine.
Il presente articolo è tratto da CIN&MASSMEDIA, Storia, linguaggio e relazioni tra mezzi di comunicazione contemporanei.
Corso di storia del cinema per insegnanti. Trieste 23 novembre 1981-31 maggio 1982.![]() A cura di Annamaria Percavassi e Stella Rasman
A cura di Annamaria Percavassi e Stella Rasman![]() Edito da La Cappella Underground con il contributo della Provincia di Trieste (marzo 1983)
Edito da La Cappella Underground con il contributo della Provincia di Trieste (marzo 1983)












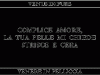

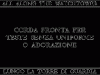























Commenti
Non ci sono ancora commenti