Mai come negli ultimi anni il videogioco, nella sua corsa ad un’interattività spesso millantata, nelle sue evoluzioni estetiche e stilistiche, nel supporto tecnologico sempre più adeguato al perseguire l’azzeramento delle lacune più evidenti, rappresenta il trait d’union tra la ripresa dal vero e il mondo simulato, tra la sospensione dell’incredulità e l’accettazione piena dell’incredibile, tra la linearità della narrazione ed il testo che si produce in fieri, tra l’adesione affettuosa dello spettatore e la rivendicazione di un protagonismo quasi assoluto da parte del giocatore.
E possiamo con pari convinzione affermare che, se ne accettiamo la prospettiva, è stato lo stesso videogioco a più riprese a sondare prima, e a rinforzare poi, il terreno preparatorio sul quale il cinema ha potuto con maggiori certezze appropriarsi di un linguaggio non suo, e dove il suo rapporto con la computer graphics e i relativi corollari ha assunto la forma di una relazione, se non paritaria, evidentemente biunivoca.
 Se non altro, almeno inizialmente, da un punto di vista commerciale: laddove Tron rappresentò un insuccesso per la Disney, ad esempio, fu il popolo dei giocatori a rivalutarlo e a renderlo oggetto di culto, così come — non conosco l’entità di tale apporto, ma non è questo il punto — sarà un videogioco di successo del 1988 (mi riferisco a Neuromancer) a portare nelle case degli adolescenti e dei pre-adolescenti il termine “cyberpunk”, che probabilmente tra prodotti per home computer e giochi di ruolo sopravvivrà nel loro immaginario anche più a lungo dell’omonimo e sin troppo breve movimento della letteratura fantascientifica.
Se non altro, almeno inizialmente, da un punto di vista commerciale: laddove Tron rappresentò un insuccesso per la Disney, ad esempio, fu il popolo dei giocatori a rivalutarlo e a renderlo oggetto di culto, così come — non conosco l’entità di tale apporto, ma non è questo il punto — sarà un videogioco di successo del 1988 (mi riferisco a Neuromancer) a portare nelle case degli adolescenti e dei pre-adolescenti il termine “cyberpunk”, che probabilmente tra prodotti per home computer e giochi di ruolo sopravvivrà nel loro immaginario anche più a lungo dell’omonimo e sin troppo breve movimento della letteratura fantascientifica.
In altri termini, se non è lecito affermare che ogni videogiocatore è potenzialmente un cinefilo o un letterato (qualcuno avrà sicuramente giocato a Neuromancer senza leggere il libro, ma andando però a vedere Johnny Mnemonic), non è falso asserire che parte degli spettatori — specie di fantascienza in senso lato — di oggi è stata motivata dai giochi di ieri.
Se le fantasmagorie degli eccessi info-cinematografici degli ultimi tempi rafforzeranno la visione di un legame fondamentalmente economico tra le due arti in questione, è tuttavia indubbio che gli scambi più interessanti, e qui oggetto di indagine, si consumino sul territorio del simbolico, del significato profondo, del linguaggio e del testo.
Possiamo a grandi linee delineare, consultando i testi sull’argomento, alcuni percorsi di ricerca in cui la forza dialettica del confronto si esprime con maggior slancio:
Le compilazioni di tipo storico: la nascita di Pong e l’esplosione finanziaria dell’Atari, gli arcade e i personal computer, l’età dell’oro del Commodore 64, l’avvento dei 16 bit, il PC come macchina da gioco, le console… e su queste basi il rapporto con il cinema che verrà in parte affrontato anche sotto questa luce (1)
Le indagini sociologiche e antropologiche: la stratificazione dell’utenza e la prassi del consumo del videogioco, i luoghi e le modalità di aggregazione o la fruizione individuale, i fenomeni di identificazione e di divismo nel videogame, dalla donna oggetto di valore al protagonismo femminile (ma sempre per un pubblico maschile, vedi Lara Croft), e via discorrendo
Le ricerche di nuove configurazioni del diritto d’autore: legata più che altro all’ambito dell’immagine infografica in senso stretto, la questione andrà ad ogni modo ad investire l’intero ambito di produzioni che si avvalgono di determinate tecnologie
Gli studi di matrice testuale: dal testo lineare al testo interattivo, dalla passività del lettore (e dello spettatore, ovviamente; ma in buona parte questi studi hanno considerato come base il testo scritto e si sono orientati sulle sue possibili evoluzioni) alla sua partecipazione nella costruzione del testo finito, fino al ripensamento del concetto stesso di testo
Gli interrogativi di stampo narratologico: fino a quale punto il videogioco è in grado di raccontare, ovvero dove e in quale misura, data la sospensione evenemenziale rispetto all’intervento del giocatore, è possibile parlare di presenza autoriale e di prassi enunciativa
Le teorizzazioni sul piano pedagogico: dalla demonizzazione operata dai mass media e dall’evidente preoccupazione causata dalle preponderanti tematiche violente alla possibilità — dal costruzionismo (2) in poi — di adoperare il gioco come strumento educativo e di analisi critica. Questo filone di studi è tra i più fertili nel nostro Paese. Da notare che tutti i percorsi finora indicati, se orientati verso una prospettiva psicanalitica, potrebbero dirci molto sulle modalità di immedesimazione da parte del videogiocatore, che vedremo a tratti differenti dall’omologo processo cinematografico
In linea con l’ultimo punto, il videogioco diventa, una volta letto tra le pieghe delle sue conseguenze meno evidenti, il campo di una discussione di tipo ideologico: ad esempio, quali contenuti si trasmettono se lo scopo del gioco è l’uccisione di un essere umano, che quindi è giudicata positivamente dal programma in esecuzione? O quando si tenta la simulazione della vita quotidiana in base a soli cinque parametri (mi riferisco a The Sims)? In base a quali proporzioni vengono calibrate la capacità di intrattenimento e l’invito alla riflessione e alla lettura critica di cinema e videogioco?
Nel rapporto tra computer graphics in senso lato e cinema tradizionale intervengono, naturalmente, gli studi di Bettetini e della scuola francese, con diverse sfumature e livelli di lettura. Ristretto — senza alcuna accezione negativa del termine — allo spazio videoludico, il tema assume connotazioni diverse, perché differente è lo spirito con cui l’impatto nel cinema della grafica di sintesi viene accolto, specialmente dalle nuove generazioni, che forse vivono con maggior partecipazione l’avvento della digitalizzazione dell’immagine filmata nel videogioco, e come logica prosecuzione delle proprie passioni (il giocatore è anche colui tra i primi si è mostrato sensibile ai progressi della computer graphics in senso stretto) l’utilizzo dei cosiddetti “effetti speciali” di ultima generazione nel cinema..

I riscontri possibili nell’ambito di un raffronto, su questi come su altri presupposti, lasciano presumere che, con il progredire in un senso o nell’altro del rapporto tra cinema e videogioco, un legame intrinseco tra l’uno e l’altro si sia già stabilito, pur potendo affermare che, nelle forme oggi più evidenti, esso si esprima ancora allo stadio embrionale; o che ciò accada, almeno, nei termini in cui si parla con eccessiva frequenza di film interattivo, di realtà virtuale, di interi mondi a portata di mouse.
Ma allora, come possiamo definire il videogioco nel proprio contesto di appartenenza (la sfera ludica) e nella rete di contaminazioni che attraverso di esso si sono venute a stabilire?
In breve — poiché l’operazione è semplice, ancorché basilare, e non costituisce certo una novità — vediamo di aggiornare la categorizzazione dei giochi proposta nel 1967 da Roger Caillois (3), che individua quattro dimensioni fondamentali ulteriormente definite dall’eventuale presenza di regole codificate più o meno esplicite. Esemplificando:
Si noterà come la classificazione, forse ancor più che nei giochi tradizionali, non risulti particolarmente rigida: ad esempio, quando si accenna all’assoluta casualità non ci si riferisce certo a giochi basati su questo esclusivo principio. Si tratta, fondamentalmente, di particolari elementi random che ne costituiscono una fase, o il presupposto per assicurarne la longevità: dal testa o croce per la scelta di campo in un videogioco calcistico alla disposizione delle truppe in uno strategico, dalla posizione iniziale dei nemici sullo schermo alla caduta dei pezzi di Tetris. Il confine tra paidia e ludus (gioco con o senza regole) è spesso labile, o è frequentemente possibile alternare la predominanza di una modalità di gioco rispetto all’altra, così come non di rado si verificano sovrapposizioni tra le quattro tipologie, come del resto dimostrano le denominazioni proposte dalle riviste specializzate. Rimando all’interessante lavoro di Gonzalo Frasca (4) per un’ipotesi di lavoro che consente di operare una distinzione tra ludus e paidia in relazione al fatto che si ravvisi o meno uno scopo ultimo nel gioco.
Tutto ciò è dovuto alla natura sostanzialmente ibrida e concettualmente in continua evoluzione del videogame, in cui, per quanto di scarsa rilevanza, sono spesso presenti momenti di gioco mutuati da altri generi, quando addirittura non ci troviamo in presenza di un corpus complessivo composto da diversi sottogiochi.
Non sarà sfuggito, e in ogni caso tengo a sottolinearlo, l’impiego del termine “genere” in un contesto che potrebbe apparire improprio, visto che viene utilizzato in luogo di un’espressione più esatta, quale la già menzionata “modalità di gioco”, ad esempio. In teoria si dovrebbe parlare di genere riferendoci al contesto dell’ambientazione del gioco stesso, nei termini in cui esso ricorre anche nel cinema e/o in letteratura: fantasy, fantascientifico, sportivo, di arti marziali… ed è per far emergere questo apparente paradosso che è stato proposto lo schema di Caillois, più che allo scopo di dar vita ad una classificazione altrimenti di relativa utilità.

Risulta altrettanto evidente, infatti, che la modalità di gioco costituisce — con tutte le limitazioni di una tassonomia nata in modo talvolta arbitrario, sebbene difficilmente immotivato — un criterio identificativo ben più immediato e significativo, che soprattutto consente una maggior corrispondenza alla natura del mezzo.
Se i processi oggi in corso possono rendere ardua la piena condivisione dell’asserzione — sia che la consideriamo superficiale oppure estrema, provocatoria — di Gianfranco Bettetini secondo la quale la trama — e di conseguenza qualsiasi forma di narrazione — nel videogioco sia un pretesto per riproporre ciclicamente strutture di interazione sostanzialmente simili (quello che in gergo si chiama “clone”) (5), è altresì fuor di dubbio che non è la presenza di una storia la condizione necessaria al funzionamento del processo interattivo fra sistema e utente, pur risultando un corollario non certo accidentale.
Nella ricerca, quindi, dei tratti distintivi del videogame rispetto al gioco tradizionale, soffermiamoci per ora su ciò che sempre Bettetini differenzia in elementi rigidi e elementi creativi del gioco elettronico: da una parte, come ogni struttura di carattere ludico, il sistema di regole che limitano il giocatore e insieme ne consentono il coinvolgimento, dall’altra la possibilità di intervento, tipica del nostro oggetto di analisi, che richiama tutta una serie di considerazioni legate principalmente all’ambito testuale e, in un secondo momento, al rapporto che stiamo tentando di delineare con il mezzo cinematografico.
È proprio a questo livello che si consuma il rapporto tra linearità ed interazione, tra gioco e narrazione, tra autorialità e fruizione attiva. Tutti i processi di immedesimazione, e le distinzioni rispetto a tali processi nel cinema e nel videogame, passano per la dicotomia appena citata.
A parte qualsiasi discorso sulla “crisi del testo”, possiamo delineare — abbiamo parlato di condizione non necessaria sul piano strutturale, ma ciò non toglie valore alle prossime asserzioni — diverse forme secondo le quali il videogioco si configura come un testo narrativo sui generis. Pretestuosa o meno — in questo senso l’operazione del game designer è facilmente smascherabile, data la frequente ed evidente stupidità che la denota — la trama rappresenta un invito ad entrare a far parte del gioco, e a calarsi in esso al punto da credersi protagonisti non già di una competizione — nel senso più lato del termine — quanto di una storia.

Che si tratti di respingere un’invasione, di salvare una donzella in pericolo, di risolvere enigmi o di portare al successo una squadra di calcio — qui si rischia parlando di narrazione, ma sotto un certo punto di vista è ancora possibile — possiamo affermare che quando esiste uno scopo ultimo, o quando esiste la consapevolezza di due stadi distinti (quello iniziale e quello finale) entro i quali le nostre azioni si svilupperanno e troveranno la propria definizione funzionale, siamo in presenza di una rudimentale struttura narrativa che può venire arricchita a seconda della tipologia del gioco o dalla profondità del suo intreccio, ma in primo luogo dalla nostra partecipazione. Esiste, semplicemente, un testo-base, prima ancora che l’interazione abbia luogo, che getta i presupposti per quello che diverrà il testo effettivo, diverso ad ogni consumo da parte del fruitore.
Non è un caso che, ben prima dell’avvento dei filmati più spettacolari e delle scene di intermezzo, l’utente fosse introdotto alla sessione di gioco da schermate vagamente esplicative, il cui scopo era sicuramente quello di creare un’atmosfera — standard finché vogliamo, ma ad ogni modo efficace — che aggiungesse credibilità allo schema di gioco vero e proprio.
Così il livello non rappresenta più — o non solo — il grado di difficoltà crescente, quanto un diverso stadio della trama; in molti di questi casi, dobbiamo accettare il presupposto che l’interattività — non sto parlando in senso tecnico, visto che anche il minimo feedback da parte del sistema informatico denota interazione — è un concetto molto vago, e i nostri margini di intervento sono previsti senza che ci sia data possibilità di dar luogo a situazioni di gioco di una certa pregnanza, se non in punti prestabiliti. In realtà, infatti, lo svolgimento prevede l’esecuzione di azioni ben precise e lo sviluppo del processo interattivo è più lineare di quanto si creda; la differenza fondamentale rispetto al testo classico è la sorta di rapidissimo alternarsi di turni che pone l’utente e il gioco in una vorticosa serie di risposte reciproche ai rispettivi stimoli, con il sistema che, coerentemente con la modalità implementata, si limita ad attendere la decisione del fruitore o risponde comunque alla sua inazione.
Dovessimo considerare lo stesso gioco risolto da più utenti, rintracceremmo con ogni probabilità sequenze analoghe di istruzioni impartite al sistema, talvolta in ordine differente, per accorgerci di come le altre azioni svolte nel corso della sessione sono difficilmente determinanti. Certo, per “raccontare la storia” della partita dovremmo tener conto del tempo impiegato, del punteggio ottenuto, e di tutte le sfumature del caso: ma, per constatare differenze sostanziali, sarebbe più interessante riscontrare i diversi modi con cui gli utenti falliscono lo scopo del gioco, ovvero “come muoiono”.
Ad ogni modo, la presenza di una traccia narrativa ci pone curiosamente nelle condizioni di poter operare una formalizzazione di un ideale testo videoludico quasi utilizzassimo gli strumenti morfologici di proppiana/greimasiana memoria; in altri termini, una volta individuato un oggetto di valore (lo scopo del gioco, appunto), possiamo distinguere tutti i ruoli attanziali del caso e ricoprirli con le rispettive figure proposte dall’universo simulato, suddividendo il suo divenire in varie fasi di difficoltà crescente rappresentanti ognuna le prove principali da superare prima di quella finale.
Il discorso non è casuale: nell’ottica di ricerca di un regime narrativo nei videogame possiamo utilizzare questo strumento al fine di annoverare nel nostro corpus di testi, tra gli altri, tutta una generazione di prodotti su licenza cinematografica di particolare rilevanza a cavallo tra gli anni ’80 e i ’90, particolarmente quelli di casa Ocean (Predator, Robocop, Batman — The movie, Total Recall… in generale, quasi tutti i film con Arnold Schwarzenegger sono passati per i monitor dei videogiocatori (6)).

Con questa software house assistiamo all’affermazione dei cosiddetti sottogiochi, un misto di platform game, di puzzle, talvolta di gioco di corsa, di spara-e-fuggi, in un mix talvolta poco riuscito, certamente fin troppo seriale e di comodo riutilizzo, ma in più di un’occasione coerente con la struttura del film, che poteva essere talvolta ricostruita — potremmo arrischiarci a dire “formalizzata” — dalla suddivisione in diversi livelli di gioco.
Lo scopo di queste operazioni è, evidentemente, lo sfruttamento del richiamo commerciale di un titolo o di un personaggio cinematografico, che spesso si riduce alla licenza sul nome e sulla sceneggiatura del film ma non necessariamente sull’immagine (ad esempio la Ocean non poté utilizzare, pur nella riduttiva stilizzazione comportata all’epoca dalle possibilità grafiche dell’home computer, il viso di Kevin Costner per The Untouchables); per il resto, la struttura risulta simile in ogni titolo, e spesso risente del dispendio di denaro nell’acquisizione della licenza (Jurassic Park insegna) che sottrae risorse alla fase di sviluppo.
Robocop, ad esempio: arcade con elementi platform e puzzle che fa una figura migliore sul C64 che sui fratelli maggiori a 16 bit, si suddivide in diversi livelli che ripropongono la trama del film a grandi linee. Questo è un caso in cui la fedeltà non è assoluta: ad esempio, gli scontri tra il poliziotto bionico e il robot ED-209 sono piuttosto arbitrari, mentre gli spunti tratti dalla pellicola (l’identikit, l’allenamento al poligono, il salvataggio di una ragazza da un tentativo di stupro) diventano livelli bonus, il cui completamento — a parte l’uccisione del traditore interno alla OCP — non sono essenziali alla risoluzione del gioco, limitandosi a ricostruire le tracce del grande schermo, insieme ad elementi di testo scritto di carattere esplicativo. In pratica, licenza a parte, Robocop rimane un ottimo videogame, che non deve la propria struttura tanto al film di provenienza (rimane la fedeltà alla trama, ma non sono fondamentali i ricorsi ad essa), quanto alla pletora di titoli che in senso lato gli restituiscono un legame con il filone vigilantistico, ovvero il farsi giustizia da sé che pervade l’ideologia del videogame lungo tutto il corso degli anni ’80, con grossa responsabilità del cinema coevo e del decennio precedente.
Altro approccio, analogo nelle componenti di gioco ma con maggiore adesione all’omologo cinematografico è quello di Batman — The movie: in questo titolo i livelli di gioco corrispondono fedelmente allo svolgimento della narrazione, dalle industrie chimiche Axis allo scontro finale sui tetti della cattedrale di Gotham per passare attraverso la risoluzione dell’enigma dello smilex (qui una sorta di mastermind per scoprire i prodotti avvelenati dal Joker) e due veri e propri giochi di corse con la Batmobile e il Batwing; il successo riportato in ciascuna di queste fasi è essenziale al proseguimento della sfida.
Il rapporto tra cinema e videogioco si avvale spesso, come i titoli sopra menzionati possono testimoniare, di formule sostanzialmente ibride. Se mi si perdona l’excursus storico, vorrei proporre una brevissima rassegna di altre due casistiche che hanno evidenziato il legame che intercorre tra i due mezzi in modo diretto, talvolta smaccato, spesso ammiccante: gli anni della fortunatamente rediviva Cinemaware e l’ingresso di George Lucas nell’industria dei videogames, con la Lucas Film ora Lucas Arts.
 Nel primo caso si parla, in tempi che ora riconosciamo prematuri, di “film interattivo”: da Defender of the Crown a Sinbad and the Throne of the Falcon (che rifà il verso ai film con Douglas Fairbanks), da Rocket Ranger a It Came from the Desert (chiara la matrice fantascientifica degli ultimi due titoli, con più di un riferimento alla cinematografia degli anni ’50, sebbene nel primo caso l’ispirazione originaria provenga dal fumettistico The Rocketeer), la semplice struttura del gioco strategico si accompagna ad una decisa spettacolarità delle scene di intermezzo e dei sottogiochi, che calano il giocatore in un’atmosfera da grande schermo. Addirittura — assoluta autoreferenzialità su un doppio livello, cinematografico e ludico — in It Came from the Desert veniva citato Rocket Ranger nello schermo in bianco e nero del drive in dove irrompeva una formica gigante mutata dalle radiazioni emesse da un meteorite! (il riferimento a Them! è tutt’altro che casuale (7)).
Nel primo caso si parla, in tempi che ora riconosciamo prematuri, di “film interattivo”: da Defender of the Crown a Sinbad and the Throne of the Falcon (che rifà il verso ai film con Douglas Fairbanks), da Rocket Ranger a It Came from the Desert (chiara la matrice fantascientifica degli ultimi due titoli, con più di un riferimento alla cinematografia degli anni ’50, sebbene nel primo caso l’ispirazione originaria provenga dal fumettistico The Rocketeer), la semplice struttura del gioco strategico si accompagna ad una decisa spettacolarità delle scene di intermezzo e dei sottogiochi, che calano il giocatore in un’atmosfera da grande schermo. Addirittura — assoluta autoreferenzialità su un doppio livello, cinematografico e ludico — in It Came from the Desert veniva citato Rocket Ranger nello schermo in bianco e nero del drive in dove irrompeva una formica gigante mutata dalle radiazioni emesse da un meteorite! (il riferimento a Them! è tutt’altro che casuale (7)).
Nella baraonda di titoli in cui abbondano filmati di intermezzo, questi primi e limitati esperimenti (tutti i giochi in questione sono comunque oggetto di culto presso i nostalgici) gettano ulteriori basi per la definizione del concetto di interactive movie come lo intendiamo oggi; volendo di nuovo adottare un criterio di classificazione formale delle fasi di gioco, potremmo asserire che l’introduzione di scene dall’elevato grado di spettacolarità — in quel caso ancora disegnate a mano pixel per pixel — costituisce, oltre che un incentivo alla prosecuzione della partita, il vero e proprio premio al conseguimento delle prove assegnate all’utente, più ancora dell’ottenimento di elementi indispensabili al buon esito dell’esplorazione ormai dati per scontati. Per questa ragione a tali scene riconduco il concetto di “vertigine” nel riadattamento dello schema di Caillois precedentemente proposto.
Questo criterio rimarrà fondamentale per i titoli a seguire di altre software houses, sebbene un approccio analitico alla sintassi dei moderni videogames ci farà scoprire come l’utilizzo di scene di intermezzo sia molto più articolato rispetto ad una volta.

Lucas, da parte sua, ha gioco facile nel mettere al lavoro i programmatori dello Skywalker Ranch (l’infatuazione del regista per i videogiochi è cosa nota, insieme allo stretto legame che, dalla fondazione della Industrial Light and Magic in poi, lo lega alle più significative sperimentazioni con l’immagine di sintesi) alla trasposizione di titoli per le sale cinematografiche; dopo aver dato vita con Maniac Mansion (8) alla moderna interpretazione delle avventure grafiche (a loro volta eredi di quelle testuali, e degli ibridi testo-grafica proposti dalla Sierra), il genere è stato riutilizzato per la conversione di titoli come Indiana Jones and the Last Crusade, o per la produzione di nuovi giochi come Indiana Jones and the Fate of Atlantis, che per poco — ed è interessante in questo caso l’inversione di tendenza legata ad un grande nome dell’industria cinematografica — non è divenuto un film, a mia memoria per il rifiuto da parte di Harrison Ford di vestire per la quarta volta i panni del famoso archeologo.
A tal proposito, se è inutile passare in rassegna la miriade di titoli che negli ultimi quindici anni hanno avuto come fulcro la saga di Guerre Stellari, è invece curioso notare come le trasposizioni, una volta chiamate tie-in, in seguito spin-off, ovvero costole di un prodotto principale che funge da traino, costituiscano oggi una realtà sotto molti aspetti valutabile alla pari con l’omologo su pellicola, che come il cd-rom per PC o Playstation rappresenta un’emanazione di un concept principale che ha già contemplato tutte le modalità in cui il progetto prenderà forma. Chi ha ravvisato reminiscenze di Ben Hur nella gara di corse di Star Wars: Episode I, in poche parole, forse non ha mai visto Pod, per citare un titolo di successo che conta tanti predecessori quanti epigoni nel panorama dei giochi di nuova generazione: il ricorso alla computer graphics, e il cenno alla suddetta tipologia di prodotti informatici, è reso volutamente evidente per mezzo della concezione stessa dei veicoli e della conseguente, caotica frenesia, insieme ad un utilizzo della soggettiva sui cui avremo modo di ritornare (9).
A livello più superficiale, tale reciprocità è manifestata dall’utilizzo — derivato anche dall’entusiasmo generato dalla diffusione del PC come macchina da gioco e dal cd-rom come supporto di memorizzazione dei dati — di scene filmate e attori famosi nei videogame; per rimanere in tema, ci limitiamo a ricordare Mark Hamill e Malcom McDowell nella saga di Wing Commander, la risposta a Guerre Stellari da parte della Origin, e in seguito pessimo film diretto da Chris Roberts che farà compagnia ai vari Street Fighter, Mortal Kombat (serie di duelli ad eliminazione cui si è voluto forzatamente aggiungere una trama: ma, a questo punto — questione meramente analitica — non ci basta Pronti a morire di Sam Raimi, che più dei titoli citati ha saputo cogliere lo spirito del genere?), Super Mario Bros. Per ogni altra considerazione storica sull’argomento rimandiamo alle indicazioni bibliografiche.

Il videogioco, come si è avuto modo di notare in questa breve carrellata di titoli ed argomentazioni, sviluppa le sue trame e i suoi approcci alla narrazione in ambito fantascientifico, o fantastico in senso lato, mantenendoli più che mai vivi in tale direzione. Spesso, accanto alla fantascienza pura, il videogioco tende a ricostruire ambientazioni futuristiche o futuribili, e sovente con commistioni fantasy (contribuendo fra l’altro ad elevare nel lungo periodo la caratura estetica di un immaginario di non altissimo profilo, su quel labile confine che separa dal kitsch più pacchiano); quasi si ponesse un ponte verso un futuro informatizzato e di alto livello tecnologico, quasi a fornirci qualche indizio — di buono o cattivo auspicio, a seconda delle circostanze — su ciò che ci attende.
Per citare Frank Beau, “è inconcepibile dire tecnologia senza pensare: e domani, e dopo?” (10). In altri termini, difficilmente chi si ritrova a che fare con un computer si dimostra insensibile a tematiche che contestualizzano in maniera estrema e talvolta eccessiva le fantasie più ricorrenti legate alle prospettive future della tecnologia.
Notiamo ad ogni modo, per la stessa ragione sottolineata nella frase appena ripresa, che la science fiction allo stato puro non ha solamente mantenuto i legami con il genere dello spara-e-fuggi et similia: con par dignità, essa è divenuta ben presto dominio del role game, dell’RTS (lo strategico in tempo reale alla Red Alert, per intenderci), e spesso elementi futuristici hanno pervaso anche i generi più disparati, come quello sportivo ad esempio, in differenti modalità, dalla visione utopica di un mondo prossimo venturo alle premonizioni più cupe di ciò che attende l’umanità.
Sul piano sintattico il videogioco ha sviluppato le argomentazioni più valide nell’ultimo decennio; è sicuramente errato — è utile segnalarlo perché talvolta accade — associare forme sintattiche mutuate dal cinema con l’avvento della grafica tridimensionale (alla Quake, per intenderci, con calcolo della prospettiva e dei punti luce, non con i pur fondamentali predecessori che prevedevano locazioni fisse con punto di vista centrale — Dungeon Master, Eye of the Be’older, Captive…), poiché è possibile riscontrare contaminazioni o possibilità di analisi anche nei prodotti più datati, al di là dell’ovvio impulso che i processori più veloci e il relativo calcolo in breve tempo della grafica di una locazione di gioco ha conferito ai prodotti più vistosi — anche in questo senso più “cinematografici”.

L’impostazione basilare di un videogioco tradizionale in terza persona può essere essenzialmente ricondotta all’inquadratura oggettiva nel cinema, ma — e questo si rivela fondamentale nella comprensione dei criteri con cui si afferma la centralità dell’utente — il movimento di macchina è vincolato — a parte gli shoot’em-up a scorrimento costante, che però difficilmente istituiscono un legame tra il giocatore ed un personaggio dalle fattezze umane (ma che lasciano al nostro alter ego la centralità dello schermo) — allo spostamento del protagonista. Questo fa sì che, pur nella mediazione operata dal personaggio nel rapporto tra utente e contesto — ovvero la prima manifestazione di un’interfaccia mediante la metafora del corpo, oggi tanto in voga nelle più estreme sperimentazioni della rete — , si possa verificare un primo processo di identificazione, che naturalmente può aumentare con la sensazione di padronanza sull’azione, in altri termini laddove sia presente un buon feeling con il sistema di controllo del gioco (11).
Se il parallelismo tra il cinema e i classici a grafica bidimensionale dovesse apparire forzato, non dimentichiamo che già in un prodotto sicuramente atipico, ma strutturato sulle basi dell’arcade tradizionale, come Another World (e relativo seguito, Flashback), accanto al realismo dei movimenti si riscontravano scene di intermezzo animate con sguardo in macchina, campi e controcampi e raccordi di stampo cinematografico che oggi spopolano nei vari Resident Evil e Alone in The Dark, e che hanno più volte fatto capolino tra i prodotti più o meno degni di nota dell’ultimo decennio.

In questi come in altri titoli più recenti sicuramente l’analogia con il cinema è più evidente: dovendo ricreare situazioni di suspense è frequente l’utilizzo di oggettive irreali, di elementi visivi e sonori off, di repentini cambi di inquadratura che, non da ultimo, spezzano la continuità del piano-sequenza fornendo ulteriori elementi di interesse all’esperienza ludica, senza contare il fatto di poter occasionalmente vedere in faccia il personaggio comandato fino ad un istante prima, creando un deciso momento dialettico tra il fenomeno proiettivo e la presenza autoriale di un narratore.
Alcuni degli spunti più interessanti sull’argomento provengono dall’articolo su Silent Hill a cura di Andrea Salvi (12). Tra gli aspetti da sottolineare sul piano sintattico evidenziati dall’estensore del pezzo riscontriamo l’utilizzo del raccordo sul movimento: tecnicamente, la sua introduzione nel videogioco coincide con l’interruzione del nostro controllo sul personaggio per assistere ad una breve sequenza (ad esempio la raccolta di un oggetto) conseguente ad una nostra azione, che vediamo inquadrata in modo differente dal punto stesso in cui si era conclusa, il più delle volte senza ulteriori possibilità di intervento. Oppure, senza intermezzi di sorta, tale tipologia di raccordo si verifica nella transizione tra due location di gioco, caratterizzate da un diverso piazzamento della “macchina da presa virtuale” e collegate dalla ripresa (a volte apparente, ma il meccanismo illusorio funziona) del movimento del giocatore: ad esempio, una porta aperta che si chiude o la conclusione di una camminata. Se il raccordo non è preciso — e ricordiamo che esso è realmente possibile solo da quando vengono sensibilmente ridotti i tempi di caricamento tra le varie locazioni del gioco, ovvero dopo la diffusione di dischi fissi e supporti ottici — spesso interviene il sonoro a garantire la continuità. Ovviamente nulla è precluso all’uso di altre tipologie di raccordo, specie sullo sguardo.
Ma, anche nel caso di una forte presenza autoriale (oggettive irreali, sospensione dell’intervento del giocatore…) siamo davvero sicuri che il rapporto tra i due termini del processo comunicativo si riveli in modo così esplicito, così netto? Il giocatore, qualsiasi sia la forma con cui il suo sguardo sull’universo ludico si esplicita, mantiene comunque un controllo sulla situazione, e possiede uno sguardo d’insieme, un punto di vista privilegiato, che gli consente di operare in un’ottica più ampia rispetto a quella che in teoria dovrebbe possedere il suo avatar — in poche parole, spesso il giocatore scavalca lo steccato della zona di sua competenza.
Paradossalmente è a questa parziale estraneità — determinata dall’inquadratura oggettiva — e supremazia sul personaggio, abbinata al quasi totale controllo delle sue azioni, che va addebitato il processo di identificazione nel videogame, cui il privilegio del punto di vista aggiunge un elemento fondamentale, quello ha consentito il prosperare dei prodotti per home computer e console, e che ha appassionato milioni di utenti improvvisamente calatisi nei panni di eroi, sovrani, detentori del destino di un mondo intero: la sensazione di onnipotenza che prima o poi, con differenti gradualità, si è provata giocando con un computer e che ha decretato il successo di giochi come Populous e buona parte dei successivi titoli di casa Bullfrog (la dicitura god-games in questo senso è divenuta ormai uno standard; oggi il titolo di punta è Black and White), gli strategici in tempo reale, e generalmente di prodotti in cui la visione dell’intervento sul contesto assume una connotazione più ampia.

In questo senso, quale sistema simbolico (un processo logico-matematico) che genera altri processi simbolici (i procedimenti metaforici che danno luogo al contesto dell’interfaccia-utente in un’ambientazione specifica) il videogioco deve costituirsi come simulazione che non faccia necessariamente affidamento — come erroneamente si usa pensare — a criteri di realismo in senso stretto, quanto, come in ogni sistema comunicativo basato su funzionalità sue proprie, sulla coerenza del complesso di regole che lo gestiscono. È quindi utile sottolineare che il processo immersivo del giocatore può dirsi completo quando, oltre a consentire un immediato fenomeno di proiezione nel protagonista del gioco, il sistema è in grado di occultare, di dissimulare la propria gestione degli input provenienti dall’utente, il quale probabilmente dimenticherà di utilizzare un’interfaccia fisica — joystick, joypad o tastiera che sia (13). Un livello enunciativo ulteriore, infatti, è quello delle porzioni di schermo in cui il gioco si espone come tale, in pratica quella in cui siano visibili gli elementi di valutazione quali punteggi o barre di energia, quelli esplicativi come la posizione o il livello raggiunto, e così via. Il resto dello schermo deve essere percepito come un mondo facilmente controllabile, dalle regole chiare ma, soprattutto, in funzione dell’utente che, a parte casi in cui la cosa sia implicitamente condivisa, non si senta il mero meccanismo di un pur complesso e raffinato — come si usa dire — feedback loop.
Dopo questo inciso, due sono le ultime forme sintattiche che preme affrontare: la soggettiva e l’interpellazione (14).
Nel primo caso, il grande salto di qualità è avvenuto con l’avvento dei giochi in prima persona a partire da Wolfstein 3D e successori (Doom, Hexen, Quake, Unreal… l’elenco ormai è lungo), degni eredi dei già citati Dungeon Master e affini, che però proponevano visuali fisse e movimenti di novanta gradi resi esclusivamente dal cambio di uno scenario predefinito. Oggi le forme di identificazione fondate su questo principio sono talmente precise da consentire la coincidenza tra il minimo movimento del personaggio (e, soprattutto, del suo capo: alzare e abbassare lo sguardo, girare la testa in una direzione improvvisa…), addirittura nel momento della morte, in cui si ottiene una significativa corrispondenza tra la soggettiva e l’oggettiva irreale. Si tratta di soggettiva poiché continuiamo a vedere attraverso gli occhi del nostro avatar, e al tempo stesso di oggettiva irreale dal momento in cui in quel momento non dovremmo vedere nulla, e siamo evidentemente coinvolti in — o in balia di? — un processo enunciativo di indubbia forza: coinvolti nella morte in prima persona e contemporaneamente restituiti alla realtà da una presenza autoriale che ci illustra il mondo del gioco proseguire senza di noi da un punto di vista estremamente parziale (quello di un corpo riverso a terra), invogliandoci ad un progressivo distacco dall’ambiente simulato vista l’improvvisa mancanza di realismo della situazione.
Se è vero quanto testé affermato — il naturale ed assoluto coinvolgimento dettato dalla forma soggettiva — è altrettanto vero che la porzione di spazio visibile diviene in questo modo quanto mai limitata, senza consentire la visione d’insieme che prelude ad una maggiore tranquillità dell’azione, intrisa invece di suspense, di colpi di scena, di improvvisi ribaltamenti del punto di vista.
 Variante sul tema è la cosiddetta semisoggettiva dipendente, caratteristica di numerosi giochi di corse così come, ad esempio, di adventure sullo stampo di Tomb Raider: il protagonista è ripreso normalmente di spalle, con la mdp più o meno rialzata e in leggero ritardo rispetto al movimento effettuato dall’utente. Talvolta, però, si evidenzia un’inaspettata autonomia della macchina da presa, che si lancia in panoramiche, plongées e virtuosismi di varia natura che denunciano una volontà registica ben definita (certe libertà vengono prese in momenti ben precisi, o ad ogni modo prevedibili nelle modalità in cui si verificano) che talvolta rischia di far perdere alla semisoggettiva in questione il proprio statuto, se non fosse che la transizione da e verso l’oggettiva è fluida e graduale. Ma di vera e propria regia, soprattutto nelle occasioni in cui essa è gestibile dall’utente, hanno fornito forme ben più complesse le simulazioni sportive.
Variante sul tema è la cosiddetta semisoggettiva dipendente, caratteristica di numerosi giochi di corse così come, ad esempio, di adventure sullo stampo di Tomb Raider: il protagonista è ripreso normalmente di spalle, con la mdp più o meno rialzata e in leggero ritardo rispetto al movimento effettuato dall’utente. Talvolta, però, si evidenzia un’inaspettata autonomia della macchina da presa, che si lancia in panoramiche, plongées e virtuosismi di varia natura che denunciano una volontà registica ben definita (certe libertà vengono prese in momenti ben precisi, o ad ogni modo prevedibili nelle modalità in cui si verificano) che talvolta rischia di far perdere alla semisoggettiva in questione il proprio statuto, se non fosse che la transizione da e verso l’oggettiva è fluida e graduale. Ma di vera e propria regia, soprattutto nelle occasioni in cui essa è gestibile dall’utente, hanno fornito forme ben più complesse le simulazioni sportive.
Sul piano funzionale tale prassi consente di esercitare un maggior controllo — perlomeno visivo — sulla situazione rendendo il cambio del paesaggio meno straniante (prima che la mdp effettui una rotazione, ad esempio, ho modo di verificare un’ultima volta ciò che mi circonda, magari attraverso lo spazio liberato da Lara Croft che momentaneamente vedo da un’angolazione leggermente diversa), mentre sul piano discorsivo si evidenzia di volta in volta un diverso grado di partecipazione alle gesta del protagonista e di complicità con l’istanza narrante. Da un’altra prospettiva, possiamo affermare che cambia a seconda della situazione il grado di corrispondenza tra il nostro punto di vista sull’azione e la nostra partecipazione al suo controllo. Poco male: a differenza di Quake, in Tomb Raider abbiamo a che fare con un personaggio atletico, da classico platform game, e oltretutto con velleità di divismo, proponendosi quindi al nostro sguardo in diverse forme che, spettacolarità a parte, in più delle volte sono comunque funzionali alla nostra interazione con il paesaggio.
L’interpellazione è l’altra faccia della medaglia, il corrispettivo della soggettiva al forte richiamo esercitato dal testo sull’utente in merito alla sua partecipazione agli eventi. Che siano i nemici o gli interlocutori a fissarci mentre il nostro punto di vista coincide con quello del personaggio principale durante la vera e propria sessione di gioco, o che sia una sequenza di intermezzo in cui ci è offerto il coinvolgimento mediante la soggettiva, sono sempre più numerosi i casi in cui l’intervento diretto del giocatore viene richiesto. L’utilizzo disinvolto di tale forma non deve stupirci: il gioco è incentrato tanto sull’utente quanto sul suo alter ego, per cui non possono sfuggirci i motivi di richiami tanto frequenti quanto espliciti. Occasionalmente, nell’economia di un testo che rischia la ripetitività, il coinvolgimento va sollecitato e il rapporto di partecipazione ristabilito in modo che l’assuefazione non si traduca in noia e meccanicità. L’immedesimazione, e conseguentemente l’importanza conferita dall’impianto narrativo all’unicità e alla straordinarietà delle possibilità operative a noi conferite (siamo gli unici a poter salvare il mondo, ad esempio), produce un intenso lavoro preparatorio fin dalle pubblicità e dalle eventuali confezioni, se si tratta di un prodotto per l’intrattenimento casalingo. L’uso del pronome “tu” e di frasi come “sei l’eroe che…” (quasi mai “interpreti il ruolo di”, espressione più distaccata che è lecito presumere più frequente nel caso in cui il protagonista provenga dal mondo del cinema, e il cui ruolo è quindi già stato ricoperto da qualcun altro) dimostra la volontà di servirsi di un rapporto diretto che smascheri la relazione tra autore dell’opera e fruitore, per poi eventualmente ripresentarne i contenuti nell’antefatto del gioco, o mediarlo (pur conservando l’impronta di un’interazione molto diretta) attraverso figure vicarie. In forme analoghe a quelle cinematografiche (il già citato sguardo in macchina), o nelle modalità proprie dei videogiochi: con l’invito a condurre un dialogo, ad esempio, o nei momenti di pausa in cui è richiesta al giocatore una decisione importante, ovvero quando il gioco si espone al rischio di mettere parzialmente a nudo i propri meccanismi di sistema di regole, la propria rigidità.

In questo contesto, ritengo parimenti significative le occorrenze nelle quali i vari personaggi si rivolgono all’eroe anche tramite testo scritto, poiché il presupposto di un fenomeno proiettivo pur nella forma dell’inquadratura oggettiva (tipologia di rappresentazione in cui simili situazioni si riscontrano con maggior frequenza) dovrebbe portarci ad accettare come espressione dell’interpellazione anche ciò che a primo acchito appare come il coinvolgimento di una terza persona. Ma si tratta, in realtà, di una sorta di triangolazione che pone il personaggio come intermediario più che privilegiato.
Non dimentichiamo ad ogni modo un dettaglio non trascurabile: sono numerose — e ne considereremo alcune — le motivazioni ancora non illustrate in virtù delle quali le forme sintattiche riportate sono “dosate” in modalità diverse in cinema e videogioco. Per quanto riguarda l’interpellazione, un altro fattore si aggiunge a giustificarne l’impiego al di là del rapporto diretto che si instaura con il giocatore, ovvero la maggior controllabilità dei punti chiave del testo videoludico rispetto al cinema.
Il videogioco consente infatti maggiori margini di previsione circa l’attività del lettore e la sua ricezione del testo: può appunto gestire le proprie modalità di intervento e di interazione con il fruitore in maniera più decisa, proprio perché il testo si crea parallelamente alla sessione di gioco, e i momenti in cui ci si può rivolgere al protagonista sono dettati dall’attivazione di particolari meccanismi che indicano il progresso da parte del giocatore nella risoluzione delle prove proposte o il definitivo fallimento, in modo sufficientemente convenzionale e codificato da costituire la risposta ad un’aspettativa a lungo frustrata.
Pur nella complessità di un modello interattivo, infatti (dove comunque è previsto cosa il giocatore può e non può fare), ogni passo verso la meta è scandito con assoluta precisione, mentre — al di là del piacere dell’attività ludica in sé — tutto il resto può essere in ultima istanza considerato una perdita di tempo. Che tuttavia, se il prodotto è di buona fattura — ossia se l’utente non si ritiene frustrato da ciò, ma è addirittura spinto ad un’esplorazione senza meta — può a più riprese costituire il vero e proprio arricchimento del testo che verrà a prodursi, il senso stesso dell’esperienza, l’insieme di sfumature di un racconto che veramente si costruisce in compartecipazione.
Il cinema si è sicuramente appropriato di alcune modalità previste dal gioco elettronico: una dimensione sostanzialmente ludica nella filmografia contemporanea risiede sostanzialmente nella serie di ammiccamenti allo spettatore, di citazioni, di richiami che danno così vita ad un singolare dibattito al di fuori della vicenda che scorre sullo schermo. Allo stesso modo, la complessità di strutture narrative (e non parlo solo di Pulp Fiction, ma anche del videogame con tre vite a disposizione come Lola corre, o all’epoca i tre finali di Fusi di testa…) rappresenta un tentativo di superare una forma di narrazione lineare a favore di uno spettatore disorientato ma partecipe e divertito.
Le stesse forme dello sguardo — con particolare rilievo alla soggettiva — proposte da alcuni film degli anni ’90 sono espressamente — sembra eccessivo dire “dichiaratamente”, ma non si commetterebbe un grosso errore — mutuate dal videogame, o perlomeno permeate da un immaginario che conferisce allo sguardo dello spettatore una centralità assoluta, che costerà cara in termini di sovraesposizione ad un’esperienza più che mai affascinante ma vertiginosa.
Mi riferisco nello specifico a Il tagliaerbe, Johnny Mnemonic e Strange Days: non a caso tre film con la realtà virtuale come spunto primario, in un periodo in cui la simulazione con guanti ed elmetti si trovava al centro del dibattito sul futuro del videogame. L’estetica del dungeon, se così la si può chiamare, sta sicuramente alla base delle produzioni citate, per tracciare i primi e più immediati presupposti di un rapporto che oggi continua a cercare una propria configurazione tanto sul piano espressivo quanto su quello dei contenuti. E se i primi sotterranei dalla connotazione specificamente ludica sono storicamente assegnati ad un film (I predatori dell’Arca perduta), non possiamo negare che sia stato il videogioco a raccoglierne l’eredità e a produrne le più interessanti rielaborazioni (15).
Partecipazione dello spettatore, dunque: una strada sicuramente possibile nella definizione di una “estetica del videogioco” nel cinema — delimitando così anche il campo di ipotesi sull’impiego della computer graphics —, ma rimaniamo sicuramente cauti nel paventarne l’indiscriminata adozione sugli schermi del futuro. A meno di voler trasformare un film in un parco a tema di venti minuti (come lo Star Wars di Disneyworld) è lecito attendersi che l’uso massivo della soggettiva — così come di una frenesia tutta videoludica nei movimenti della macchina da presa, o di ciò che ne rimarrà nella circostanza — risulti piuttosto disorientante per uno spettatore che difficilmente sarà in grado di sostenere senza alcun disagio una duratura esposizione a eccessi grafici sbalorditivi e rapidissimi.
E se al cinema la soggettiva è una forma di coinvolgimento forte, addirittura prepotente negli esempi citati, il giocatore è necessariamente costretto a vivere in prima persona un certo tipo di esperienze (e nulla ci vieta di ipotizzare nel videogame e nel cinema prossimi venturi situazioni di uscita dalla soggettiva per “oggettivizzare” l’inquadratura, dicotomia estrema ma che verrebbe resa graduale — e per questo ancor più sconvolgente — dall’uso del piano sequenza); non tanto perché sia necessaria una pressione sul giocatore per ricreare un clima di totale adesione, quanto perché la prospettiva in prima persona diviene il fondamento stesso del gioco in questione, il quale altrimenti perderebbe qualsiasi fondamento costitutivo. Un’ovvietà, apparentemente, ma anche l’inequivocabile segnale che in questo campo cinema e fumetto soffrono di una sostanziale divergenza sul piano formale, da appianare o, perché no?, da sfruttare nelle esigenze di una sperimentazione approfondita.
In questa direzione si procede sicuramente alla ricerca di un equilibrio, a meno che il mercato non si orienti definitivamente verso un’utenza principalmente formata dagli adolescenti già alfabetizzati dai prodotti di ultima generazione e quindi più propensi ad accogliere le forme più ridondanti dell’espressione visiva.
Francesco Antinucci (16) suddivide le tipologie di videogioco in abilità e destrezza, simulazione, storie e avventure fantastiche, aderendo alla classificazione dei livelli cognitivi di Piaget (sensomotorio, rappresentativo/simbolico, operatorio); certo in questo caso si parla di videogioco in ambito educativo, ed è facile notare come la categorizzazione proceda secondo livelli di complessità crescente. È altresì vero che il grado di complessità e di articolazione nel videogioco si situa storicamente su un percorso analogo, e così il grado di interazione, di completezza di un intreccio narrativo, di consapevolezza del mezzo e delle sue potenzialità. Del resto i giocatori che sono stati bambini negli anni ’80 hanno costituito il primo pubblico di un industria in crescita e in via di definizione, ed hanno in seguito domandato prodotti in grado via via di soddisfare esigenze sempre più specifiche: in questo modo si può ora parlare di evoluzione dal videogioco come consumo al videogioco come esperienza, fino a teorizzare oggi di legami con il cinema sempre più intimi, sempre più degni di interesse.
Ovviamente le nuove generazioni hanno vissuto tale processo in maniera decisamente più rapida e consapevole, verso una direzione dalla quale dobbiamo tuttora attendere molte risposte, soprattutto in un momento in cui è decisamente difficile formulare ipotesi circa il futuro dei giochi per computer. Il mercato PC è abbastanza statico, e al momento è ancora da verificare l’impatto delle nuove console (Playstation 2 in testa) che potrebbe far ulteriormente virare il mercato verso nuove tendenze, verso nuove tipologie di fruitori.
Possiamo comunque rilevare un piccolo paradosso: a fronte di un cinema che, nonostante tutto, resta comunque narrazione con un principio ed una fine, il videogame che tenta di mutuarne la complessità si ricostruisce sulle basi di una simulazione sempre più ramificata, di approcci sempre più differenziati, di modalità distinte di risoluzione, di mondi che vivono e prosperano sotto i nostri occhi, al di là delle nostre azioni.
Siamo noi i protagonisti del film, e di conseguenza ne costruiamo la trama: potrebbe essere questa la spiegazione? Francamente ne dubito, visto che abbiamo in più occasioni rimarcato la forza dialettica della reciprocità di autore e utente del gioco.
Il problema è altrove, ovvero nella ricerca di complessità e realismo che, al di là della solidità di un impianto narrativo, nasce anche dall’esigenza del rispetto nei confronti dell’intelligenza del giocatore: dove io interpreto un personaggio, comando un esercito, sono il dio di una popolazione, non devo vedermi limitato da una struttura spartana e da personaggi in cui mi posso immedesimare solo finché non ne scopro la banalità. In questo senso, il concetto di film interattivo pertiene ancora all’ambito del videogioco, e non è il caso di eccedere con fantasie di applicabilità in tempi brevi nel contesto cinematografico.
Ma forse possiamo individuare un’altra ragione: il videogame sta acquisendo coscienza, non tanto (o non solo) si sé, quanto del fatto che il raggiungimento di certi livelli qualitativi non può concedere troppo spazio a visioni di tipo manicheo dello scopo del gioco.
Che si tratti dello sfruttamento commerciale di personaggi di un film, o che ci confrontiamo con una figura originale, una personalità di spessore, o la possibilità per il giocatore di agire secondo diversi parametri, conferisce al gioco un’inaspettata dimensione etica, in base alla quale è lecito attendersi di poter intervenire secondo numerose modalità, di poter avere ripensamenti, o di poter porre rimedio ad un errore.
È questo un traguardo da raggiungere, e che proprio in un titolo su licenza ha trovato una delle sue più significative rappresentazioni, per quanto sperimentali: parliamo di Blade Runner, capolavoro non solo tecnico che — pur senza la figura di Deckard se non in un solo punto del gioco, né la trama dell’originale — riusciva a trasmettere sul piano ideologico buona parte degli interrogativi e delle incertezze del film, ad esempio in una scena in cui era possibile decidere se uccidere o meno un replicante, e nel fatto stesso di poter contare su diversi finali.
Certo, un’interattività spinta ai massimi livelli (una maggiore casualità degli eventi, la possibilità di interagire fattivamente con il contesto del gioco pur senza perseguirne gli scopi, una decisa limitazione di punti morti e situazioni reiterate) appartiene più all’ambito del desiderio e dell’utopia più che ad una situazione effettiva o realizzabile a breve termine.

È più probabile, invece, che un sistema di gioco così ampio possa ispirare un film piuttosto che una pellicola si traduca in un gioco dal contesto così dispersivo. Oggi come oggi, il terreno comune rimane quello dell’arcade-adventure o del role-game: il cinema può mutuarne la caratterizzazione dei personaggi e del contesto d’azione, nonché la trama solitamente avvincente, mentre il videogame può con una certa semplicità tradurre in simili formule di gioco una narrazione forte ed un protagonista riconoscibile e immediatamente complice.
Già l’edutainment ha dimostrato come il videogioco possa essere veicolo di contenuti educativi, e perciò non possiamo stupirci oggi se lo scopo perseguito è quello della sfumatura ideologica, o se il concetto di ludus inizia a divenire sempre più sfumato — non solo divertimento e adrenalina allo stato puro, dunque, ma anche terreno sul quale mettere a frutto gli spunti che il cinema potrebbe offrire sul piano della credibilità.
E coscienza del videogame — parallelamente al piano narrativo, e non è detto senza mai convergere in talune occasioni — può esprimersi nell’atto di un ripensamento della natura stessa del mezzo al momento di uscire dai canoni più tradizionali. Il cinema ha già vissuto, e talvolta sofferto, simili problematicità sulla propria pelle: ovviamente ci riferiamo all’avvento del digitale, che con timore, curiosità o entusiasmo è divenuto rivoluzionario oggetto di riflessione (del resto The Abyss e Terminator 2 — due film, in ultima analisi, sull’incontrollabilità della materia digitale — rappresentavano in superficie come il problema veniva vissuto in profondità e con diverse sfumature — e del resto in T2 il monologo finale di Sarah Connor/Linda Hamilton sulle incognite del futuro lasciava intendere che la sconfitta del T1000/Robert Patrick era tutt’altro che definitiva).
Di converso, nemmeno il videogioco è stato risparmiato da una certa tipologia di problematiche, poiché la digitalizzazione ha condotto con sé il concetto di multimedialità, e con esso la sperimentazione in ambito di acquisizione di materiale filmato o fotografico su ampia scala. Certo, il dibattito, se c’è stato, è risultato meno argomentato o sofferto — non era accademico, non aveva un retroterra di esperienze teoriche alle spalle, lo stesso mezzo era troppo giovane. Diciamo piuttosto che, a posteriori, se ne potrebbe trarre qualche spunto teorico che allora era solo relativamente avvertito, inglobato com’era tra le questioni tecniche — tra le quali oggi dobbiamo scavare — degli addetti ai lavori: da una parte lo staff di produzione, dall’altra l’utenza, con la mediazione delle riviste specializzate.
Uno dei temi più sentiti era, ad ogni modo, l’opportunità di proporre scene digitalizzate all’interno di un gioco; se in generale questo genere di soluzioni è stato accolto favorevolmente sin dall’inizio, è vero che un’aura di purismo è stata mantenuta dai videogiocatori più diffidenti, un po’ per puntiglio ma soprattutto per timore di veder improvvisamente — e, soprattutto, prematuramente — snaturato il videogame dalle sue caratteristiche costitutive. E, a dire il vero, con tutte le concessioni che si possono fare ai programmatori e ai game designer a loro volta disorientati di fronte alla novità, i più scettici non avevano del tutto torto, visto che alcune delle istanze poste dal problema del rapporto immagine filmata/immagine bitmap emergono a tutt’oggi e ancora attendono risposta, come si è cercato di dimostrare con le argomentazioni finora prodotte.
Tutto sta nel capire se il rapporto in questione ha trovato un equilibrio, e se, una volta risposto affermativamente alla domanda, le convergenze si manterranno o se comunque cinema e videogioco proseguiranno non tanto su percorsi similari, quanto su ritmi che permetteranno anche in futuro uno scambio proficuo. Oggi pare di sì, e il futuro lascia intendere più di una riprova a tale asserzione; vedremo a partire da oggi — in questi mesi potremmo assistere allo spartiacque definitivo — quanti passi in avanti verranno compiuti, quali distanze saranno mantenute, in quale direzione si potrà riscontare un margine di sovrapposizione.
Il problema risiederà piuttosto nell’equilibrio, specificamente nel fattore temporale che contraddistingue il testo cinematografico e quello ludico: in un videogioco le azioni sono molto più compresse, o, per dirlo ancora con Antinucci (17), è più possibile fare molte più cose in un breve lasso di tempo. Sarà quindi il caso che il programmatore si ricordi che una sequenza filmata eccessivamente lunga diventa noiosa, o che i dialoghi non devono eccedere in verbosità; il regista, dal canto suo, rischia di trasformare i propri attori in trottole impazzite, modo poco ortodosso per dire che in una trasposizione che non voglia tradire lo spirito dell’originale il primo indice di mediocrità è la mancanza di ritmo e la scarsa adattabilità nel venire incontro al compromesso imposto da qualsiasi rapporto tra due forme espressive distinte. Nel rispetto delle rispettive formule, la questione è di vitale importanza per consentire di ottenere prodotti non eccessivamente sbilanciati da una parte o dall’altra, che rispettino la natura del mezzo di appartenenza senza allontanarsi oltremodo dall’ibrido oggi in fase definitoria.

Per questo, o siamo di fronte ad un novello Matrix, o, se lo scopo è quello di ricreare l’azione pura con relative ed improbabili evoluzioni del corpo umano, vale davvero la pena — al di là della portata epocale dell’evento — di optare per una soluzione à la Final Fantasy. Film che, trailer a parte, non ho ancora visto, poiché nel momento in cui scrivo è appena stato proiettato a Locarno; ma che, a differenza di Alberto Farassino — il quale, non senza ironia, vi ravvisa poco più che manichini digitali che recitano come attori mediocri (18)- apprezzerò sicuramente se non altro per il fatto di non aver mai visto un videogioco recitare così bene.
Sarà sempre meglio di Angelina Jolie.
Cinema e videogioco: la prospettiva di un confronto che, complici le ultime novità su grande schermo, trovano spazio sulle riviste specializzate e non solo, al punto da meritare rubriche autonome e trasversali su diverse pubblicazioni. E’ il caso di Duel, o di Alias. Ma i presupposti dell’odierno interesse partono da ben più lontano.
Questo testo proviene da Science+Fiction zerouno, catalogo del Festival Internazionale della Fantascienza 2001.




























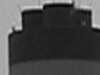










Commenti
Non ci sono ancora commenti