Christian Sinicco (CS): Fucine Mute intervista Gianluca Pulsoni, promettente critico, redattore de La Gru. Spiegaci la tua idea di tradizione nella poesia italiana… Possiamo dire alcunché sulla vastissima esperienza della nostra poesia, dalle origini ad oggi, e se sì, in quali termini?

Gianluca Pulsoni (GP): Parlare della poesia italiana, della produzione poetica in versi “italiana”, significa rimandare la questione all’origine storica dell’italiano come sistema linguistico e idioma e cercare di capire quale legame vi sia tra questa origine storica e la non sempre corrispettiva origine poetica. In genere, l’accademia e gli intellettuali anti-accademici, tra cui per “spirito” credo di annoverarmi, iniziano la disquisizione sulla nostra letteratura e poesia dalla ormai consolidata classica “divisione” e opposizione “poetica” tra Petrarca e Dante: dagli studi di Contini in poi, il primo è sinonimo di “monolinguismo” e di poesia-dettato lirico; il secondo sinonimo di “plurilinguismo” e di “poesia del dire”. Certamente è da qui che possiamo iniziare a fare i conti con il linguaggio, prendendo spunto da questa “biforcazione”della via della letteratura, che si svincola dall’anonimato dell’autore a servizio dei cicli epici per approdare ad una più serrata dialettica con il proprio mondo e le proprie comunità sociali ed esistenziali: nasce l’ “autore”come fonte del discorso, in relazione alla scrittura e alle arti, quando nasce la figura del cittadino come individuo autonomo nel politico, nell’attesa dell’umanesimo.
 Credo che per poter parlare davvero in termini precisi di Tradizione si debba poter tentare di illuminare a ritroso la storia delle lettere fino a poter “leggere” il momento in cui “nasce” l’autonomia della letteratura detta “italiana”, separandosi dalla serie degli strumenti e dall’ottica della finalità degli esercizi di potere temporali e spirituali. Questo “stacco” viene vissuto come un fatto assoluto; questa autonomia giocoforza significa privilegio e “accento” sul momento della riflessione a discapito dell’azione e del vincolo: lo si vede soprattutto nelle elaborazioni dei nostri classici poemi, formae mentis per eccellenza, in cui le personali “idee di poesia” autoriali si fanno tutt’uno col “segno” del poema come intervento nel corpo del linguaggio “vivo”, praticato dal riflesso corpo sociale: essi, i poemi, sono, usando una bella espressione di Clifford Geertz, metacommenti sociali, laddove appunto riuscissimo a leggere nel linguaggio la “geografia dei segni” in cui si muove la figura concettuale che chiamiamo “uomo”, la cui comparsa effettiva, stando agli straordinari studi di Foucault risale al periodo kantiano. E dunque, “autonomia della letteratura”… ma il paradosso più strano, per quanto riguarda il nostro Paese, è quello di avere avuto la “coscienza” dell’importanza delle lettere prima di avere avuto un vero e proprio idioma! Credo sia proprio questo il fatto letterario paradossale, e significativo: vi è stata in Italia una letteratura italiana prima di un idioma italiano! L’unificazione per idioma come immagine di una “identità italiana” è cambiata di segno in relazione ai processi storici: l’Ottocento ha fallito l’intento ponendo nelle mani di una minoranza, la borghesia, il compito ideale di questa codificazione con i risultati che tutti sappiamo; il caso specifico di una Nazione senza tradizione scritta che rese impossibile, almeno allora, un sentimento d’unione; il caso emblematico del romanzo manzoniano ne è una prova, dato che è opera di poesia, quindi opera critica, necessariamente definitoria, soggettiva e non unificante.
Credo che per poter parlare davvero in termini precisi di Tradizione si debba poter tentare di illuminare a ritroso la storia delle lettere fino a poter “leggere” il momento in cui “nasce” l’autonomia della letteratura detta “italiana”, separandosi dalla serie degli strumenti e dall’ottica della finalità degli esercizi di potere temporali e spirituali. Questo “stacco” viene vissuto come un fatto assoluto; questa autonomia giocoforza significa privilegio e “accento” sul momento della riflessione a discapito dell’azione e del vincolo: lo si vede soprattutto nelle elaborazioni dei nostri classici poemi, formae mentis per eccellenza, in cui le personali “idee di poesia” autoriali si fanno tutt’uno col “segno” del poema come intervento nel corpo del linguaggio “vivo”, praticato dal riflesso corpo sociale: essi, i poemi, sono, usando una bella espressione di Clifford Geertz, metacommenti sociali, laddove appunto riuscissimo a leggere nel linguaggio la “geografia dei segni” in cui si muove la figura concettuale che chiamiamo “uomo”, la cui comparsa effettiva, stando agli straordinari studi di Foucault risale al periodo kantiano. E dunque, “autonomia della letteratura”… ma il paradosso più strano, per quanto riguarda il nostro Paese, è quello di avere avuto la “coscienza” dell’importanza delle lettere prima di avere avuto un vero e proprio idioma! Credo sia proprio questo il fatto letterario paradossale, e significativo: vi è stata in Italia una letteratura italiana prima di un idioma italiano! L’unificazione per idioma come immagine di una “identità italiana” è cambiata di segno in relazione ai processi storici: l’Ottocento ha fallito l’intento ponendo nelle mani di una minoranza, la borghesia, il compito ideale di questa codificazione con i risultati che tutti sappiamo; il caso specifico di una Nazione senza tradizione scritta che rese impossibile, almeno allora, un sentimento d’unione; il caso emblematico del romanzo manzoniano ne è una prova, dato che è opera di poesia, quindi opera critica, necessariamente definitoria, soggettiva e non unificante.
Il Novecento post-bellico, ha realizzato tramite omologazione, commercializzazione e prostituzione dell’ “aura” l’idioma italiano come dato reale, marcandone i vuoti intellettuali e mancando tutti i presupposti culturali: il segno di quest’operazione finalmente realizzata è però mutato, e lo viviamo oggi. Le differenze — linguistiche, etiche, psicologiche, sociali — non sono praticate, ma, per così dire, “ridotte”. Misurabili e riducibili. Basta leggere Empirismo eretico di Pasolini per capire come questa unificazione dei codici sia — stata — una sconfitta, proprio per il quadro storico-politico che l’ha evidenziata: una degradazione della molteplicità delle lingue, i dialetti e le lingue deleuzianamente “minori”. Vi sono così due momenti, storicamente molto precisi, a cui allora possiamo fare riferimento per costruire una geografia spazio-temporale del divenire della nostra questione, la Tradizione: la nascita della letteratura italiana, come autonomia dell’autore dal proprio argomento, nella coscienza di poter dare giudizio di sé e del mondo — perché ciò è il riflesso della coscienza della “potenzialità” e della pratica della “possibilità” d’agire dell’uomo in quanto “cittadino” — e ciò nasce sotto il segno della poesia e della poesia di Dante; la nascita dell’idioma italiano, come momento che “segna” il passaggio della diversità linguistica dal piano dell’espressività al vincolo della “comprensibilità”, dell’informazione, del commercio, dei canoni della rappresentabilità dei codici di un idioma, di un’etica, di un sistema di valori. Di uno stato. Tutto questo si riflette in noi e si intromette nella letteratura, nel senso che per noi è questo idioma che parliamo nella realtà il passaggio di tutte le emozioni ma anche il primo paesaggio, la “scena primaria”, in cui ci muoviamo! Ma che poi noi subiamo, indiscutibilmente, nel momento in cui le modificazioni dei codici si impongono in noi a partire da processi o azioni storiche determinate sempre dall’ altro o dall’ alto.
 Questi due momenti, allora, si impongono in un segmento spazio-temporale che possiamo configurarci, come concatenati e sovrapposti assieme: una irruzione del “nuovo”, la letteratura come segno di affrancamento da una storia che si è chiusa — l’impero romano e il Medioevo — che porta una coscienza del passato riflessa nell’autonomia delle lettere e dell’autore e in una fitta dialettica di ricostruzione tra forme da alimentare con i segni della realtà e vita da formare, organizzare in giudizi e categorie assieme artistiche e inter-soggettive; una dissoluzione della diversità dei discorsi, di saperi e di pratiche — tra cui inseriamo anche la poesia — nella coercizione di un potere che mitologizza il sentimento di una “fine” della storia, amplificandone la portata, senza permettere la formazione di nuovi discorsi che sappiano davvero mostrare una via di fuga e che possano decostruire questa fine in un processo, facendo di una fine, questa, un nuovo e diverso inizio. Sovrapponendo questi due momenti abbiamo questo unicum a mo’ di modello ermeneutico astratto che è il concetto stesso di Tradizione: un’immagine la cui fonte continuamente dissolve il momento di massimo nitore e luminosità in una nuova difformità, in una nuova variazione. E allora: cos’è Tradizione? Essa è, cioè accade, ogni qualvolta un autore si colloca in una posizione di messa in crisi del proprio tempo, attraverso la propria opera che, inattuale, fa giudizio. E in cui ritorna la ripetizione dello stesso conflitto alla “fonte”, quello dei due momenti sovrapposti, che ri-accade sempre: un’originarietà “trascendente”, a contatto con la creazione per atto e l’oblio nella storia, un gesto sempre verticale che spacca la linearità cronologica e mitica del tempo presente in cui la letteratura si nutre di letteratura, come se questa irruzione modificasse la “storia della fine” in cui viviamo in una realizzata “fine della storia” e di tutte le sue bagarre. Un atto per così dire “filosofico” che “cita”, cioè “muove” un passato che “apre” una scena grandiosa sul “teatro del linguaggio”: un momento “riflessivo” di ripiegamento del linguaggio su di sé, che rivela la “poesia”, un secondo linguaggio, la compresenza dei tempi e illumina l’astrattezza del mondo nel suo limite, il noumeno.
Questi due momenti, allora, si impongono in un segmento spazio-temporale che possiamo configurarci, come concatenati e sovrapposti assieme: una irruzione del “nuovo”, la letteratura come segno di affrancamento da una storia che si è chiusa — l’impero romano e il Medioevo — che porta una coscienza del passato riflessa nell’autonomia delle lettere e dell’autore e in una fitta dialettica di ricostruzione tra forme da alimentare con i segni della realtà e vita da formare, organizzare in giudizi e categorie assieme artistiche e inter-soggettive; una dissoluzione della diversità dei discorsi, di saperi e di pratiche — tra cui inseriamo anche la poesia — nella coercizione di un potere che mitologizza il sentimento di una “fine” della storia, amplificandone la portata, senza permettere la formazione di nuovi discorsi che sappiano davvero mostrare una via di fuga e che possano decostruire questa fine in un processo, facendo di una fine, questa, un nuovo e diverso inizio. Sovrapponendo questi due momenti abbiamo questo unicum a mo’ di modello ermeneutico astratto che è il concetto stesso di Tradizione: un’immagine la cui fonte continuamente dissolve il momento di massimo nitore e luminosità in una nuova difformità, in una nuova variazione. E allora: cos’è Tradizione? Essa è, cioè accade, ogni qualvolta un autore si colloca in una posizione di messa in crisi del proprio tempo, attraverso la propria opera che, inattuale, fa giudizio. E in cui ritorna la ripetizione dello stesso conflitto alla “fonte”, quello dei due momenti sovrapposti, che ri-accade sempre: un’originarietà “trascendente”, a contatto con la creazione per atto e l’oblio nella storia, un gesto sempre verticale che spacca la linearità cronologica e mitica del tempo presente in cui la letteratura si nutre di letteratura, come se questa irruzione modificasse la “storia della fine” in cui viviamo in una realizzata “fine della storia” e di tutte le sue bagarre. Un atto per così dire “filosofico” che “cita”, cioè “muove” un passato che “apre” una scena grandiosa sul “teatro del linguaggio”: un momento “riflessivo” di ripiegamento del linguaggio su di sé, che rivela la “poesia”, un secondo linguaggio, la compresenza dei tempi e illumina l’astrattezza del mondo nel suo limite, il noumeno.

Così allora Tradizione sarebbe un concetto rinnovato, salvato dall’oblio della storia stessa perché benjaminianamente “citato” come filo rosso, come questione conosciuta e perciò “tradita”: una rammemorazione nella pratica, della storia, mutata di “segno”. Sarebbe una sorta di shifter delle lettere, come punto di vista e di fuga dal mondo: nella struttura momento d’assenza come segno di presenza di processo. Uno shifter che commuta la storia della letteratura ogni volta in letteratura — il termine “letteratura” per me ha il significato che gli dona Blanchot, come “spazio” tra i linguaggi — della storia, dove sincronia dei testi e diacronia dei processi si accordano in un unico divenire molteplice. Bisogna riappropriarsi della vita: si può fare rivivendo questa contraddizione tra l’originarietà, il nuovo strappato alla disfatta, e il “vecchio”, la contemporaneità del quotidiano e della tecnica: la loro dialettica, se infinita, mossa, porta alla fine di ogni autonomia dell’arte, alla fine dello scandalo di un arte separata dalla vita. E l’immagine di questa dialettica è ciò che si chiama “opera”.
CS: Poesia e pensiero debole: quali i riflessi dal punto di vista critico, e quali i riflessi a livello della sociologia dell’ambiente?
GP: Il pensiero debole per me è sinonimo di debolezza del pensiero. Non lo posso accettare: perché poi come concetto non è un buono strumento operativo da utilizzare ma, credo, solo un segno descrittivo che inscrive bene il passaggio di questo paesaggio storico, del “come eravamo”. Sono finite le ideologie, non il pensiero. Che l’uomo sia oggi “senza qualità ” è la letteratura a dircelo: l’inettitudine e l’inazione ci hanno aperto lo scenario del nichilismo nel teatro della storia. Che, nel momento riflessivo degli anni sessanta-settanta ci sia stato detto, da Agamben, che l’uomo sia senza contenuto è poi stata un’altra rivelazione: la rivelazione di una necessità di ripensare il pensiero al di là del “contenuto”, sia quindi come indice di argomenti sia come indice di presenza di forma: al di là dell’umano dell’uomo, ricercare l’urgenza di un pensiero che cerchi, anche, di “creare pensiero”.
 È questo che da sempre è il nodo gordiano: il tentativo e la tentazione di cercare e di creare un pensiero che sia anche il suo altro, il proprio fuori. Abbiamo bisogno di concetti forti, urgenti: abbiamo bisogno che la necessità e l’urgenza sostituiscano nella nostra forma mentis la nozione classica di contenuto. È di vitale importanza che si torni a capire la difficoltà delle cose, nel loro livello “materico”: leggere e scrivere, cosa hanno di affine? Cosa di diverso? L’arte raffinata dell’interprete è lo “specchio” dell’atto del creatore: il giudizio è sempre creazione e ripiegamento, invenzione di una originareità, permanenza di energia. Siccome credo che la poesia come esercizio sia una pratica che sospende il giudizio — non kantiano, ma quello “soggettivo” — perché ingloba in se l’idea di giudizio come “creazione” e indice di interpretazione, riservo in essa la massima importanza: essa è la “messa in crisi” della cultura, il suo continuo superamento e rinnovamento, vista esteriormente.
È questo che da sempre è il nodo gordiano: il tentativo e la tentazione di cercare e di creare un pensiero che sia anche il suo altro, il proprio fuori. Abbiamo bisogno di concetti forti, urgenti: abbiamo bisogno che la necessità e l’urgenza sostituiscano nella nostra forma mentis la nozione classica di contenuto. È di vitale importanza che si torni a capire la difficoltà delle cose, nel loro livello “materico”: leggere e scrivere, cosa hanno di affine? Cosa di diverso? L’arte raffinata dell’interprete è lo “specchio” dell’atto del creatore: il giudizio è sempre creazione e ripiegamento, invenzione di una originareità, permanenza di energia. Siccome credo che la poesia come esercizio sia una pratica che sospende il giudizio — non kantiano, ma quello “soggettivo” — perché ingloba in se l’idea di giudizio come “creazione” e indice di interpretazione, riservo in essa la massima importanza: essa è la “messa in crisi” della cultura, il suo continuo superamento e rinnovamento, vista esteriormente.
Letta interiormente, o almeno provando a farlo, possiamo soltanto abbozzare delle tracce che portino a formare quella che un giorno potrà, spero, essere una vera e propria critica del linguaggio: e con critica non intendo certo il senso che questa parola assume nel gergo giornalistico. Penso da un po’ che la poesia debba essere annoverata come esercizio extra-culturale perché extra-linguistico: al limite della follia, o della “patologia”, la poesia come momento di creazione è indissolubile dal suo momento di riflessione, implicato nell’atto. “Fare poesia” vuol dire “non parlar la parola, ma la cosa”, e pure tutti i rovesci di questa formula, imprigionati ai dettati non-detti di questo doppio legame. Se si tratta di un ripiegamento del linguaggio, ciò fa si che il linguaggio si ponga come locus in cui i vettori lirici passano: quindi c’è da considerare il linguaggio come rappresentazione. Non in senso mistico o di rifiuto a-prioristico, ma in senso materialista.
Che sia necessario un rifiuto di una ipertrofia del linguaggio che parli se stesso, questo deve essere chiaro. Esprimere non è mai facile e non deve esserlo. C’è quindi bisogno di vettori e di contro-vettori poetici, cioè di “nodi” o “resistenze” per creare. Attraversare in questo caso il linguaggio è compiere il primo passo necessario per superarlo: l’atto di creazione è un ripiegamento dello stesso linguaggio su di sé, un momento di riflessione in cui il linguaggio si stratifica e vede la propria essenza, in cui si vede; un processo che disarticola tutte le associazioni concettuali e squalifica tutti gli attributi in causa: l’essenza metaforica del linguaggio, il circolo vizioso della comunicazione, l’implicazione e la persuasione ecc. Che il linguaggio sia il lignaggio dell’essere e l’immagine del desiderio differito è appurato: noi, difatti, siamo un divenire e non un essere.
 Le tesi di Heidegger sul linguaggio sono sacrosante: ma noi, appunto, cerchiamo altrove con lo sguardo e la mano. Inoltre, nello stesso tempo in cui c’è da considerare questo ripiegamento, c’è da riflettere e riflettersi molto sulla questione della “cosa”: che vuol dire nella sua assolutezza? In accordo proprio alla peculiarità della poesia, come esercizio e non come genere, la “cosa stessa” di cui si parla non può non essere che il fallimento del senso e del linguaggio stesso, inscritti già nel senso che nel linguaggio stessi, e non letti come simboli del negativo filosofico. Ogni cosa è molteplicità di interpretazioni: un oggetto in sé non esiste; persiste e insiste nelle infinite sue possibilità cognitive, potenziali e intersoggettive. Vale per un oggetto materico, figuriamoci per un oggetto linguistico! Se quindi le interpretazioni sostituiscono i fatti e le cose, esse però si pongono come creazioni immediate allo stesso tempo: anche il senso logico in un contesto antropologico e pragmatico, o magari sensista, potrebbe essere visto — perché no — come il vero sesto senso umano, rovesciando completamente il suo ruolo e il suo funzionamento. Come dire: tutto è creazione! E questo è un fatto, cioè un’interpretazione…
Le tesi di Heidegger sul linguaggio sono sacrosante: ma noi, appunto, cerchiamo altrove con lo sguardo e la mano. Inoltre, nello stesso tempo in cui c’è da considerare questo ripiegamento, c’è da riflettere e riflettersi molto sulla questione della “cosa”: che vuol dire nella sua assolutezza? In accordo proprio alla peculiarità della poesia, come esercizio e non come genere, la “cosa stessa” di cui si parla non può non essere che il fallimento del senso e del linguaggio stesso, inscritti già nel senso che nel linguaggio stessi, e non letti come simboli del negativo filosofico. Ogni cosa è molteplicità di interpretazioni: un oggetto in sé non esiste; persiste e insiste nelle infinite sue possibilità cognitive, potenziali e intersoggettive. Vale per un oggetto materico, figuriamoci per un oggetto linguistico! Se quindi le interpretazioni sostituiscono i fatti e le cose, esse però si pongono come creazioni immediate allo stesso tempo: anche il senso logico in un contesto antropologico e pragmatico, o magari sensista, potrebbe essere visto — perché no — come il vero sesto senso umano, rovesciando completamente il suo ruolo e il suo funzionamento. Come dire: tutto è creazione! E questo è un fatto, cioè un’interpretazione…
In questo caso, l’unico luogo del linguaggio, l’unico caso in cui il giudizio come interpretazione si illumina nella sua formazione di atto di creazione è quello dell’esercizio poetico, dello spazio lirico: mutato di segno, il giudizio è creazione e la creazione è critica, poiché è l’esercizio poetico che giocoforza rompendo gli a-priori del linguaggio, le connessioni logiche che sono a suo fondamento, rompe infinitamente tutte le relazioni interne ed esterne tra utenti e linguaggio stesso, ripensandole e costringendolo a fare in una nuova prospettiva. Di qui, tutti i problemi che sono chiamate recensioni e il non-senso, in poesia, dell’ “informazione”. La cosa stessa è il ripiegamento del linguaggio, perché le cose non sono: la presenza di un’interpretazione fonda un circolo vizioso dove l’interpretazione può proliferare all’infinito. Come rompere il circolo? Modificando il sistema di valori, il campo di creazione: la co-esistenza nell’atto di creazione di valori critici e di momenti creatori sottrae alla permeabilità del giudizio dell’altro. È il linguaggio stesso a non dover funzionare, per liberare l’indicibile sempre detto in sé, cioè per tentare di mostrarlo. Come fa a non funzionare? Bisogna attaccare ciò che è a monte: come detto, tutti i suoi fondamenti. Quindi, sia diffida e diffidenza del linguaggio e del “tecnicismo”, sia diffidenza nel misticismo dell’intuizione e della “purezza” decantata come facilità e felicità dei poeti. L’emozione passa e trapassa: ma si confronta con la parola, la ingloba e la supera!
Quando dico che la lingua è creazione, la lingua di un poeta, vorrei intendere che lo statuto di creazione nasce laddove finisce l’autonomia del linguaggio, in cui il linguaggio smette di funzionare e affonda nei suoi balbettamenti, nelle sue variazioni, nella fisiologia, facendo si che lo stile, cioè una nozione critica, venga letto e sentito come movimento, cioè come un’azione artistica, “emica”. L’eteronomia del linguaggio è un dato imprescindibile. Raggiungere questa condizione significa aprirsi in uno spazio letterario in cui i modelli di interpretazione ai soggetti parlanti e muti possono essere applicati senza la mediazione del commercio letterario e del linguaggio stesso. Cosa in sé e ripiegamento del linguaggio sono due fattori dello stesso fenomeno, una è una nozione e l’altra una azione: che tutto sia detto nel foglio-mondo del linguaggio, che la parola sia “cosmesi”del mondo poiché noi parliamo il linguaggio, le parole, è chiaro, poiché il linguaggio è cultura ed è il luogo dell’incontro per eccellenza. Che non esistano le cose, ma solo le interpretazioni è ormai una acquisizione epistemologica. Ma che appunto esista la possibilità di tramutare il potere di un discorso, anche alto e filosofico, in potenza pratica è comprovato da tutte le possibilità offerteci. Non esiste altrove fuori dal linguaggio, ma un’ altrove, per così dire, “dentro” il linguaggio che porta la creazione a formare del linguaggio il proprio “fuori”, le “opere”. La dimensione dell’immaginario del linguaggio si appiattisce ai significanti lirici: la narrazione si fa fatto nel verso, l’autobiografia del poeta è trasfigurata e “griffata” dall’auto-bio-grafia dello scrittore.
 La cosa stessa va cercata quindi nella rottura della macchina mitica del linguaggio che produce discorso, cioè potere, tramite “la parola”, il vincolo per eccellenza. Il ripiegamento del linguaggio, la sua “crisi”, è la cosa stessa: da produrre ora sarebbe la “critica” di questa crisi, la sua analisi. La “cosalità” della cosa, il suo attributo principale, sta nella piega, o nelle pieghe, del linguaggio ogni volta che dismette la propria auto-referenzialità. È dunque impossibile dire “il dire”, dire il linguaggio con il linguaggio: caduti i principi fondanti il linguaggio come “macchina”, principi che sono dentro la rete stessa dei significati della macchina linguistica e mitica, è solo possibile “abdicare” ai vincoli di ogni forma di discorso, qualora non si mostri mai come affermazione o gioco o invenzione e qualora si mostri sempre come discorso di potere. È dunque chiaro che uno scrittore che abbia l’intenzione di dire il linguaggio con il linguaggio mente in maniera palese, “a fin di male”: se si “mette in crisi” il linguaggio come fa l’esercizio poetico, non si può poi avere la pretesa di “mettere in scena” il linguaggio stesso, mantenendo principi fondanti dell’esistenza del linguaggio come “la comunicazione” quando essi in realtà si dissolvono già nella “messa in crisi” della funzionalità del linguaggio. È il cane che si morde la coda, o la malafede dei letterati. Sono solo le pieghe e i ripiegamenti, le riflessioni nel linguaggio a liberare dai vincoli tutta la macchina linguistica e a permettere l’espressione di formule operative come “parlare la cosa”. È impossibile intendere la cosa stessa se non tramite il linguaggio. Ma il linguaggio non conosce le cose perché le nomina. La nominazione è nell’ordine del significato e non dell’evento. La parola è soglia della materialità muta del mondo.
La cosa stessa va cercata quindi nella rottura della macchina mitica del linguaggio che produce discorso, cioè potere, tramite “la parola”, il vincolo per eccellenza. Il ripiegamento del linguaggio, la sua “crisi”, è la cosa stessa: da produrre ora sarebbe la “critica” di questa crisi, la sua analisi. La “cosalità” della cosa, il suo attributo principale, sta nella piega, o nelle pieghe, del linguaggio ogni volta che dismette la propria auto-referenzialità. È dunque impossibile dire “il dire”, dire il linguaggio con il linguaggio: caduti i principi fondanti il linguaggio come “macchina”, principi che sono dentro la rete stessa dei significati della macchina linguistica e mitica, è solo possibile “abdicare” ai vincoli di ogni forma di discorso, qualora non si mostri mai come affermazione o gioco o invenzione e qualora si mostri sempre come discorso di potere. È dunque chiaro che uno scrittore che abbia l’intenzione di dire il linguaggio con il linguaggio mente in maniera palese, “a fin di male”: se si “mette in crisi” il linguaggio come fa l’esercizio poetico, non si può poi avere la pretesa di “mettere in scena” il linguaggio stesso, mantenendo principi fondanti dell’esistenza del linguaggio come “la comunicazione” quando essi in realtà si dissolvono già nella “messa in crisi” della funzionalità del linguaggio. È il cane che si morde la coda, o la malafede dei letterati. Sono solo le pieghe e i ripiegamenti, le riflessioni nel linguaggio a liberare dai vincoli tutta la macchina linguistica e a permettere l’espressione di formule operative come “parlare la cosa”. È impossibile intendere la cosa stessa se non tramite il linguaggio. Ma il linguaggio non conosce le cose perché le nomina. La nominazione è nell’ordine del significato e non dell’evento. La parola è soglia della materialità muta del mondo.
È però la parola anche evento in sé: inalienabile dall’esercizio umano, essa si ingloba alla sua soglia muta: del parlare, dell’intendere le cose. La parola nell’esercizio poetico si riflette e ripiega in sé: non dice le cose, o almeno non solo ma si ripega in sé mostrandosi come “evento”, ponte tra immaginario e immediato. L’intervento sulla parola reiterato nell’esercizio poetico “fonda” il doppio movimento del dettato lirico: l’atto retorico del parlare e narrare un storia, in cui i modi “creano”continuamente il fatto e l’atto scrittorio dell’inscrivere nel flusso orale il “verso”. Come dire: l’orecchio del canto e dell’incanto indefinito del mondo e l’accecamento del verso, “la luce”. Questo ipotetico diagramma di funzionamento si dispiega ogni qual volta si fa riferimento alla “scrittura”, di cui abbiamo bisogno di una nozione allargata il più possibile. Il parlare sarebbe quindi interno già alla pratica poetica della parola, nozione “osmotica” e contigua alla parola poetica stessa. Ma nello stesso tempo, io credo, la scrittura è interna al “parlare”, poiché ogni volta ne è sia l’archeologia che la naturale genealogia significativa. Si parla quindi ciò che inscritto da sempre nel linguaggio, ciò che il linguaggio non dice da sempre, ma mostra: ciò di cui si parla non ha parola, cioè non può ammettere giudizi a margine, ma è parola, o meglio sempre la tentazione, per così dire, a “la parola”. E si scrive invece, si può scrivere l’orale del linguaggio laddove esso si “sospendi” nelle sue funzioni e si “esponga” alla possibilità e impossibilità dell’atto: laddove si mostri nella sua insufficienza. O meglio, nella sua non autonomia.
CS: Quale aspetto della comunicazione, tradizionale e multimediale, può rivitalizzare, a livello della promozione degli autori e della selezione delle opere, il tessuto connettivo dell’ambiente letterario e in special modo dell’area della poesia?
GP: Il tessuto connettivo dell’ambiente letterario? Non so, ti direi ciò che per me è la verità, per quel poco che sento e provo a immaginarmi che, in realtà, questo famigerato ambiente non lo conosco… C’è molta meschinità, arroganza e c’è un invadente presenza di circoli viziosi in cui ci si omaggia, come dei vassalli, a vicenda: io faccio questa bella recensione a te, tu mi fai inserire nell’ambito universitario. Io parlo bene, tu fai per me qualcosa. Senza necessità, senza progetto, senza una idea di, un pensiero “forte”: tutti a dire io io, a causa del nostro povero individualismo. Come gli asini, i-o i-o i-o… Insomma: la letteratura come commercio e ricettazione, e non come pedagogia. Questo mi pare l’ambiente.
Ma se poi vuoi sapere quali aspetti di questa sorta di “comunicazione” a banda larga possano, per me, essere rivitalizzanti o scossi… ebbene, io ti dico che dipende tutto dalla serietà e dall’integrità dei progetti dei vari operatori culturali in campo. Non si deve lasciar perdere le riviste e né il foglio per così dire “militante”, assolutamente: si deve lottare per una diversa strategia di distribuzione d’idee e nello stesso tempo per una de-monetizzazione dello spazio culturale e informativo, ma va bene il contatto con la carta, con la parola scritta, con l’idea di redazione e di comunità: va bene il filo rosso da mantenere con ciò che eravamo e saremo, con l’idea di Tradizione. E riviste in questo senso che si propongono come “mostra” in itinere di novità profonde, radicate nel passato e proiettate nel futuro, nello stesso tempo, ce ne sono e ce ne sono state.

Oggi, credo, sia una grande cosa l’idea di rivista-libro che è In forma di parole di Scalia, non a caso un reduce di quel volutamente dimenticato progetto estetico e etico che fu Officina. Per non parlare poi di uno dei significativi progetti che la cultura italiana abbia mai avuto, nel senso proprio da dare alla parola cultura: cioè il Politecnico, squisitamente italiano per indole e indolenza e assolutamente “straniero” e “anacronistico” rispetto al provincialismo del pensiero e della poesia che abbiamo oggi — e io credo che, benché non la risonanza, ma per la sua forma e il suo taglio non abbia nulla di che invidiare alle riviste epocali che sono successe dopo, come per esempio Tel Quel. Altri esempi di grandi “invenzioni” che furono e che oggi non sono più? Lengua di D’Elia, che non sta a me elogiare in questa sede ma basta, visto il suo contesto storico, a essere annoverata come una rivista di “propulsione”, di lavoro specifico e mirato — non a caso non prende nome da metafore extra-linguistiche ma sta tutta nella sua peculiarità e nel suo intento. E l’elenco potrebbe anche continuare, aggiungendo se vogliamo molte pagine di Comunità, meritorie per aver offerto scritti di geni assoluti quali per esempio Furio Jesi.
C’è quindi molto da lavorare, in relazione a quanto si vuole cercare e trovare: ci si può inventare una distribuzione pauperistica, per veicolare proprie idee “politiche” con un taglio il più possibile preciso e conciso e con l’idea di una redazione “aperta”, come è il caso della collana di Questipiccoli di filosofia politica ideata e diretta da Clio Pizzingrilli. Oppure, ancora, si può tentare una strada più personale ed “eccentrica”, quella della pubblicazione di una rivista “ibrida”, irregolare. L’esempio che conosco più icastico e fulgido mi appare con l’Acamasce: né rivista, ne libro ma, sotto la forma del libro d’arte, esempio di “segno” e di presenza assoluta di un’esigenza di poesia guidata dall’idea di “incontro”, di riscontro personale sugli “altri” secondo il suo ideatore, Domenico Brancale. Sono tutti progetti forti, poco pubblicizzati e sono progetti che conosco bene e che amo molto. E che mi stanno insegnando molto! Specie a costruire prima una idea forte vincolata dalla necessità, e poi al lavoro assiduo e totalizzante: dal formato, all’idea di promulgazione e diffusione — che preferisco all’ideologia dell’immagine e della comunicazione -, al ripensamento di una idea di “pubblicità”, al valore e non-valore dell’informazione, alla necessità del riscontro. Alla gratuità della pubblicazione non definitiva. E, come detto già prima, vanno bene le riviste: ma occorre un ripensamento dell’idea di “comunicazione”, di informazione mediata, di “filtrazione”. E, di conseguenza, occorre una nuova educazione alla ricezione, alla lettura, all’attenzione del linguaggio che è nella realtà e che è la realtà stessa, nei suoi a-priori.
De-monetizzare lo “spazio letterario” e una azione politica che si muova su due direzioni: un rifiuto della proliferazione delle figure critiche e accademiche e una ri-distribuzione del piccolo capitale nel reinvestimento sull’educazione “culturale” che continui “fuori” dalla scuola e dai luoghi canonici ormai non più preposti. Qui, in Italia, ho la netta sensazione che la domanda di letteratura sia minore dell’offerta che si da, a svantaggio di una distribuzione selvaggia di cariche e di denaro e di uno svilimento dell’organismo vivente della società, cioè la cultura, che non è solo sensibilizzazione alle belle arti e allo sfascio di questo paese ma è anche sensibilizzazione alle idee, al patrimonio di una “Tradizione” che non è mai rivisitata, ma solo museificata. Non si sa più leggere né ammirare e, ci tengo a dirlo, che dicendo cultura non ho detto “umanesimo”, che è qualcosa che mi da molto fastidio — come credo lo desse a Blok — e dicendo Tradizione non voglio intendere, assolutamente, l’autonomismo identitario di certe culture locali, sotto l’egida di movimenti pseudo-politici di massa. La volgarità del politico è la volgarità della nostra cultura: potere non è sapere.
 In quanto alla multimedialità… non conosco affatto il panorama “multimediale” in relazione alla poesia, ma lo conosco un po’ in relazione quanto basta alle arti. So che è sinonimo di “democrazia”, di possibilità d’espressione “libera”, ma io credo che nello stesso tempo sia espressione di “nullità” d’espressione. Cioè, senza ricorrere a voli pindarici, io penso che la multi-medialità in sé non sia garante di necessità d’espressione e di rigore d’applicazione: può non conservare l’arte, non né è necessariamente il logico presupposto. E nello stesso tempo la sua valenza di “molteplicità” è una somma che non somma nulla, che non è sinonimo o “specchio” della realtà: uno più uno più uno, all’infinito, fa ancora “uno”. Questo lo dico perché si applicano mezzi che spesso non si sanno applicare, in virtù di una piccola idea, quando va bene, che si vuole tentare di “comunicare”.
In quanto alla multimedialità… non conosco affatto il panorama “multimediale” in relazione alla poesia, ma lo conosco un po’ in relazione quanto basta alle arti. So che è sinonimo di “democrazia”, di possibilità d’espressione “libera”, ma io credo che nello stesso tempo sia espressione di “nullità” d’espressione. Cioè, senza ricorrere a voli pindarici, io penso che la multi-medialità in sé non sia garante di necessità d’espressione e di rigore d’applicazione: può non conservare l’arte, non né è necessariamente il logico presupposto. E nello stesso tempo la sua valenza di “molteplicità” è una somma che non somma nulla, che non è sinonimo o “specchio” della realtà: uno più uno più uno, all’infinito, fa ancora “uno”. Questo lo dico perché si applicano mezzi che spesso non si sanno applicare, in virtù di una piccola idea, quando va bene, che si vuole tentare di “comunicare”.
In questo senso, questa intenzione artistica è profondamente in malafede: sia nei confronti di se stessi, per quanto riguarda i sé-dicenti “artisti”, sia per quanto riguarda gli “spettatori” e gli “ascoltatori” e sia per quanto concerne la stessa “arte”. Che poi, invece, ci sia un uso e anche un “abuso” con coscienza e lucidità di “tecnologia” informatica e performativa: ebbene, questo mi sembra molto, ma molto più interessante. Cito solo due esempi di artefici epocali che hanno rinnovato il linguaggio trasformando la loro “scrittura”, sempre trascorsiva e oppositiva al linguaggio, in “tecnologia”: Glenn Gould e Carmelo Bene. Quale fu la loro presa di posizione nei confronti del mezzo? Assolutamente radicale: tutti e due, con le loro idee di organizzazione concettuale e musicale, riuscirono a mettere nel centro del loro lavoro i mezzi tecnologici come “motori” propulsivi del loro esercizio: comporre per la registrazione comporta tecniche e “posture” totalmente differenti e altre dalla prestazione dal vivo; leggere in scena tramite la tecno-logia comporta una vera e propria immediatezza che dissolve ogni punto di vista in punto di fuga, marcando la a- logia, ponendo lo spirito della musica al di là della musica e il linguaggio come ritmo e immagine di un tempo cancellato. Così allora anche per le letture pubbliche: la tecnologia vincolata e veicolata all’idea, come risorsa inumana dell’umano. Serve questo.
CS: Le tue analisi su letteratura e sistema sono puntuali. Quali secondo te i vizi e le virtù della rivista su cui scrivi? Per quanto riguarda i vizi, penso alla sterile polemica sulla comunicazione, o alcune battaglie ideologiche sulla società di massa.
GP: La Gru, è un progetto a cui mi sono aggregato dopo, spinto da alcune esigenze condivise e deciso a partecipare per via della bellezza dell’azzardo e soprattutto di ciò che sta a monte del progetto stesso. L’idea di dare all’utenza che poi noi, di volta in volta ci stiamo formando, un foglio di spunti, di idee “forti” su cui ragionare, evitando quindi i rischi di impostazione didattica e critica, vuoi anche per la necessità di “dire” senza ermetismi in uno spazio “leggibile” e plasmato dalla forma giornalistica, mi è subito piaciuto. Dei quattro redattori e dei più stretti collaboratori, i nostri amici pesaresi Stefano Sanchini e Loris Ferri, ti dico subito che sono insieme a Riccardo Fabiani la persona più distante dalla bagarre dei giovani poeti: per la ragione appunto che non scrivo, come Riccardo, liriche. E nello stesso tempo ci tengo che mi si consideri non un critico, ma per ora uno studioso e operatore culturale. E basta.
Il progetto de La Gru mi attraversa e mi interessa notevolmente per le implicazioni antropologiche tra poesia e cultura, e per l’editoria — con tutti i problemi davvero molto interessanti con l’informazione e le strategie di diffusione e ricezione testuali. Fin dove ci sarà la mia necessità di interrogarmi su questa connessione, fin dove La Gru avrà la possibilità di continuare, si continuerà a lavorare sotto questa scia: pubblicazioni di giovani inediti e editi che offrano un panorama non “omologato” ma spesso tendente al variegato: ci sono voci che non sono piaciute a tutti, ma è il rischio che si corre partendo da zero come abbiamo fatto. I numeri non tutti saranno buoni magari: ma sono buoni già in sé poiché sono stati fatti, qualcosa c’è. E nel panorama delle idee di poesia e di prosa, manca il cimento e il pathos che si sente ne La Gru nell’affrontare in maniera culturale e non formalista i problemi tra poesia, linguaggio e realtà.
 In quanto alla sterile polemica sulla comunicazione… forse è vero che le battaglie ideologiche sulla società di massa, oggi che viviamo la “fine della storia” e forse “la fine della politica” possono sembrare sterili, desuete, ma è essenziale che si ricordi questo fatto: non si può prescindere nell’analisi culturale dall’analisi del linguaggio: per negarlo, superarlo o magari omaggiarlo oppure bestemmiarlo. Questo la filosofia più straordinaria — penso qui in Italia a Carlo Sini e Giorgio Agamben e in Francia al compianto Jacques Derrida — ce l’ha insegnato: non alcuni artisti e né alcuni movimenti poetici e poeti, che perseverano a fare cattiva filosofia con le loro arti concettuali ed a non essere ne artisti e ne poeti. E quindi vale anche il contrario: si passa dal linguaggio per approdare alla realtà, alla cosa: se il linguaggio oggi in Italia, e la poesia è la sua espressione limite, o la sua non-espressione prima, è tarato, omologato, censurato nelle sue tentazioni impoetiche consce, bisogna dirlo.
In quanto alla sterile polemica sulla comunicazione… forse è vero che le battaglie ideologiche sulla società di massa, oggi che viviamo la “fine della storia” e forse “la fine della politica” possono sembrare sterili, desuete, ma è essenziale che si ricordi questo fatto: non si può prescindere nell’analisi culturale dall’analisi del linguaggio: per negarlo, superarlo o magari omaggiarlo oppure bestemmiarlo. Questo la filosofia più straordinaria — penso qui in Italia a Carlo Sini e Giorgio Agamben e in Francia al compianto Jacques Derrida — ce l’ha insegnato: non alcuni artisti e né alcuni movimenti poetici e poeti, che perseverano a fare cattiva filosofia con le loro arti concettuali ed a non essere ne artisti e ne poeti. E quindi vale anche il contrario: si passa dal linguaggio per approdare alla realtà, alla cosa: se il linguaggio oggi in Italia, e la poesia è la sua espressione limite, o la sua non-espressione prima, è tarato, omologato, censurato nelle sue tentazioni impoetiche consce, bisogna dirlo.
Bisogna denunciare il fatto come assurdità e vizio. E se questo appiattimento “orizzontale” del linguaggio si riflette nella neutralità dell’idioma, bisogna che tutti capiscano che un rischio di omologazione dei comportamenti c’è. Se si dice che è preferibile un rovesciamento estremo e una contaminazione estrema a posto di questo minimalismo come maschera di qualsivoglia qualunquismo, di destra e di sinistra, bisogna mostrare che questo modo riflette un cambiamento del linguaggio. Il tutto non è un sistema di valori: semmai, è un sistema di variazioni. Come chiosa tutta la lezione debordiana sulla società: l’immagine è divenuta spettacolo, lo spettacolo società, cioè miseria. La spettacolarizzazione dell’immagine è divenuta realtà che non riusciamo a vedere perché siamo: estremo chiasmo, estrema deriva, estremo detour. Che fare? Ecco allora, noi ci proponiamo questo, anzitutto anche e solo questo: bisogna che allo stesso tempo si denuncino i fatti e che questi fatti possano essere riconducibili, nella lettura critica ed esegetica, a un nodo concettuale illuminato, affrontato volta per volta, la realtà o la comunicazione come estetica e ideologia. Oppure l’idea di eresia, cioè l’approccio etico e anti-psicologico.
Ora tu mi dici della sterile polemica sulla comunicazione… premesso quanto ti ho detto, cioè della nostra necessità ed onestà intellettuale a dover collegare società di massa a ideologia della comunicazione perché giocoforza è una acquisizione culturale che l’Italia e l’Occidente ha integrato nel rispettivo dna sociale, può essere che l’argomentazione, il montaggio dei testi o il taglio degli articoli possa essere sembrato “sterile”, cioè non produttivo, con nessun concetto operativo che saltasse fuori. Ciò va bene: va bene che ci sia confronto e discussione su un problema, che quindi il problema si renda per quello che è, cioè un complesso di significati e interpretazioni. Ciò però, come detto, non toglie nulla alla validità dell’organismo complessivo: si propone un discorso che si mostra nelle sue varianti. V’è la necessità di ripartire da certi nuclei cruciali, nostro calvario o — se vuoi — croce-via.
Il numero scorso, quello sulla comunicazione, è quello di impostazione più ideologica e vincolante: il testo-pretesto di Mario Perniola, interrogato per l’occasione dal sottoscritto e molto felice del progetto, è uno stimolo per mostrare apertamente come l’autonomia del linguaggio porti all’immagine della comunicazione, cioè a coniugare estetica della comunicazione con funzionalità della macchina mitica e linguistica. E questa unione cosa produce? Produce una ipertrofia della fruizione, una facilità d’accesso all’informazione, una cultura ready-made senza distacco dal linguaggio, senza ironia e umorismo che per me sono anche sinonimi di oralità. I segni del linguaggio si sdoppiano: appare la loro presenza e scompare la loro utenza. Simulacri di realtà e realtà stessa. Tutto, oggi, funziona anche troppo bene. E se oggi la comunicazione può essere vista come mitologia della realtà, i rapporti si invertono indefinitamente: non si crea più realtà, ma comunicazione all’infinito. Comunicatività. E che cos’è oggi la realtà? È l’estetica della comunicazione. Un chiasmo inquietante..

CS: Poesia/Scrittura/Opera/Esecuzione. Viviamo un’epoca di importanti modificazioni a livello dei prodotti letterari e sulla fruizione. Quali le risposte della critica? Quali nozioni estetiche da introdurre?
GP: La critica non risponde: tace e acconsente allo scempio della cultura. Una vitale kulturkritik, come agognava Nietzsche, qui ed ora, è un sogno. Ti posso dire che io, personalmente, ho dei modelli di lavoro e di interpretazione, dei testi e del linguaggio, e quindi della realtà, che trovo in filosofi e studiosi seri, che in Italia abbiamo avuto e abbiamo ma che, come sempre, non valorizziamo. Non è che siamo fermi a Croce e Gentile, che peraltro sono spesso mal spiegati e mal capiti. Per quanto riguarda la poesia, i grandi tentativi di interpretazione socio-linguistica e filosofica di Ferruccio Masini, specie su Benn, sono straordinari. E vanno a completare un lavoro che inizia dal “quadro” del tempo storico, alle motivazioni estetiche, fino alla traduzione come pratica di interpretazione: questo è rinnovamento!
 Questa è critica, nel puro spirito kantiano e tedesco della parola. Oppure — che so — Cristina Campo, con Gli imperdonabili: analisi obliqua di alcuni autori, visti come portatori di discorso, soggetti parlanti e muti. E letti come “mondo” a sé. Un altro esempio? Tutto il lavoro sulla letteratura italiana di Giorgio Agamben: dalle chiose misconosciute e geniali su Delfini e Caproni, a Idee della prosa; al suo studio su San Juan de la Cruz che manca del momento inventivo e creativo della traduzione, non geniale, per definirsi come “straordinario”. Oppure, per citare sempre di Agamben, il lavoro sull’operatività del linguaggio e la letteratura, con digressioni sui provenzali, ne Il linguaggio e la morte.
Questa è critica, nel puro spirito kantiano e tedesco della parola. Oppure — che so — Cristina Campo, con Gli imperdonabili: analisi obliqua di alcuni autori, visti come portatori di discorso, soggetti parlanti e muti. E letti come “mondo” a sé. Un altro esempio? Tutto il lavoro sulla letteratura italiana di Giorgio Agamben: dalle chiose misconosciute e geniali su Delfini e Caproni, a Idee della prosa; al suo studio su San Juan de la Cruz che manca del momento inventivo e creativo della traduzione, non geniale, per definirsi come “straordinario”. Oppure, per citare sempre di Agamben, il lavoro sull’operatività del linguaggio e la letteratura, con digressioni sui provenzali, ne Il linguaggio e la morte.
La critica non deve essere mai formalista, ma sempre culturale, “aperta”: analitica e inventiva assieme. E se c’è analisi e invenzione nell’interpretazione, l’atto diviene critico, finalmente felice e proficuo: l’altrove del critico, noi ormai dissolti critici e già spettatori estetici, confluisce nell’altrove dell’artista e dell’arte. Si interpreta rilanciando la sfida della creatività: creando a nostra volta la realtà dalla realtà di quel linguaggio, di quell’ opera. E quindi si ha bisogno di concetti che esplichino formule, operazioni, invenzioni. E l’occupazione e la formazione del concetto è un lavoro al limite del mutismo e dell’anonimato: è creazione e riflessione assieme, sospensione del linguaggio e messa in atto della crisi del tempo, del problema del tempo.
Poesia / Scrittura / Opera / Esecuzione sono momenti del lavoro del linguaggio contro il linguaggio: non v’è la voce come elemento pre-linguistico, poiché come detto il lavoro artistico è critico allo stesso tempo, e quindi passa per degli stadi di mutismo incondizionato dentro i propri atti. Subentra la voce come visibile solo quando si sia dissestato il proprio campo linguistico preso come geografia dei propri atti, delle proprie invenzioni poetiche. La voce è “creazione” e concetto limite e base della scrittura: dove v’è scrittura, lavoro sul linguaggio contro il linguaggio non v’è voce; dove v’è voce, cioè dove non v’è direzione e quindi circolo comunicativo poiché il contenuto ingloba in sé come creazione tutti i possibili giudizi, non v’è scrittura. Una variante per me significativa della nozione di scrittura, per tentare di allargare la sua portata e mutarla di segno, mi sembra il concetto esplicato da quello straordinario studioso di arti e spettacolo che fu Maurizio Grande, a proposito di Carmelo Bene.

Grande, rifacendosi a Margini di Derrida, e quindi all’idea di una nozione allargata di testo, parla, a proposito di Bene, di “smarginatura”. Considerando lo statuto “anarchico” dell’arte come l’unico modo pensabile dell’arte stessa, dire smarginatura vuole intendere un’operazione che cerchi in eguale misura di problematizzare le nozioni di orale e di scritto in relazione al senso. Un azione il cui atto di fondamento è “filosofico” e “teatrale” assieme, filosofico nel senso di sapiente e teatrale nel senso in cui il teatro è una metafora, magari barocca ma pur sempre metafora, del pensiero-in-voce. Quest’azione apre ad un principio la cui determinazione è la “disarticolazione” del discorso, che apre a sua volta alla messa in atto della crisi del senso. Che cosa vuol dire disarticolare? Certamente non si tratta di articolare in maniera diversa, ma nemmeno poi di non articolare. Se consideriamo l’idea di frammento e la sua necessità, l’abuso incondizionato filtrato dall’ideologia del pensiero debole non ha giovato alla sua proficuità.
E inoltre, occorrerebbe ben distinguere da certe tipologie di espressioni per frammenti: l’incapacità di dire di molta poesia novecentesca, avallata appunto dalla fine del sistema che segna l’epoca post Nietzsche, che fa il palio con molto quietismo intellettuale. Uno può continuare a frammentare, frammentare ma ciò non vuol dire che possa mettere in crisi il senso, quindi nulla. Non dice! Non è che il frammentismo dica il non-detto: diverso invece è il discorso su Nietzsche perché il suo esercizio lirico è la prassi dell’aforisma, forma aperta e problematica per eccellenza. Che poi oggi il mondo sia frammentario e “favola” è vero; ma una cosa è addossarsi come capro espiatorio di tutto la volgarità delle espressioni facendo si che la propria opera, la propria “vita” si faccia frammentaria, anche a rischio di mutismo e un’altra cosa è invece rappresentare, cioè illustrare frammenti. Si deve essere travolti dalla dimensione extra-culturale della vita, dove spazio e tempo sono una unicità. Se si rimane nel frammento, invece… Cioè è importante capire come si può frammentare una idea, una storia, senza aver mai attentato al senso, cioè senza aver mai rinnovato e creato e prodotto pensieri e problemi.
L’esercizio della smarginatura invece propone un’ appiattimento dei mezzi con i fini che cerca di liberare l’immanenza, o meglio la potenza dal linguaggio. Che non deve essere confusa con l’evidenza del linguaggio stesso, poiché è impossibile dire “il dire”. E inoltre, liberando l’immanenza, si arriva in una situazione relazionale, tra interprete e creazione, in cui a trasmettersi è la pulsione a-segnica degli atti che intervengo sulla lingua, sul testo, sui suoni, sul senso e per metonimia, sul mondo e sul cosmo. Non è più questione di dire, ma di “far dire” alle parole l’indicibile, far sentire l’inaudito, far capire l’incomprensibile del linguaggio, il suo “fuori”, la sua soglia di gioco in cui la materia linguistica diviene “organica”. Sono le parole a sanguinare, che non parlano ma fanno parlare e si parlano l’un l’altre, ripiegandosi nel proprio vuoto. Scrivere e parlare sono due momenti dello stesso fenomeno, la cui continuità è il linguaggio stesso, in cui l’indicibile, muto perché irripetibile, cioè non commercializzabile, è pura discontinuità, puro “spazio”: è la cosa stessa.
CS: Violare le forme delle opere precedentemente compiute non è forse il tema dell’eresia, tuttavia pare essere la via percorribile per un “fare” che non si vuole accontentare di ciò che già conosce. Quale la tua idea in proposito?
 GP: Come già detto prima, “parlare la cosa, e non la parola”, come Pasolini in Bestia da stile. A noi rimane solo il parlare, che non possiede mai l’oggetto del proprio discorso ma che è, che si fa, oggetto di se stesso: come detto, la cosa in sé è il ripiegamento del linguaggio stesso, dove esso si fa disfunzionale e il potere del discorso, di ogni discorso, si fa incolore, non pervasivo, senza voce. E a noi rimane solo lo scrivere, che è degradazione dell’orale e sua profondità, suo nascondimento: dove l’orale si può liberare dalle connessioni logico-discorsive dei principi della comunicazione e farsi potenza ingiudicabile. E quindi l’atto orale pervade sia la scrittura che l’eloquio, ambo i poli di un ipotetico diagramma. E questo movimento che dovrebbe interessare a formare una analisi non estetica, ma pragmatica delle opere letterarie, lette in uno spazio tra linguaggio e interprete, dove nella realtà tutto è ridotto in linguaggio e nel foglio bianco tutto il linguaggio è tradotto in “mondo”.
GP: Come già detto prima, “parlare la cosa, e non la parola”, come Pasolini in Bestia da stile. A noi rimane solo il parlare, che non possiede mai l’oggetto del proprio discorso ma che è, che si fa, oggetto di se stesso: come detto, la cosa in sé è il ripiegamento del linguaggio stesso, dove esso si fa disfunzionale e il potere del discorso, di ogni discorso, si fa incolore, non pervasivo, senza voce. E a noi rimane solo lo scrivere, che è degradazione dell’orale e sua profondità, suo nascondimento: dove l’orale si può liberare dalle connessioni logico-discorsive dei principi della comunicazione e farsi potenza ingiudicabile. E quindi l’atto orale pervade sia la scrittura che l’eloquio, ambo i poli di un ipotetico diagramma. E questo movimento che dovrebbe interessare a formare una analisi non estetica, ma pragmatica delle opere letterarie, lette in uno spazio tra linguaggio e interprete, dove nella realtà tutto è ridotto in linguaggio e nel foglio bianco tutto il linguaggio è tradotto in “mondo”.
L’eresia, o quello che ho chiamato “tema dell’eresia”, grazie anche ad alcune suggestioni datemi da Gianni D’Elia, si instaura in questa visione anti-formalistica dell’opera d’arte. Ed essenzialmente “etica”. Io credo fortemente che il segreto di una buona analisi, oltre che il dover-essere inventiva, è quello di dover cercare di “profanare” l’aura di un’opera in relazione al pensiero attorno all’opera stessa, cioè quelle che possono venire chiamate anche “forme di discorsività”. “Mostrare” e non dire, questo sarebbe un dettato interessante. “Inventare” e tra -dire, questo è il momento importante nell’arte. Ed è appunto il “tradimento”, come prassi della traduzione della relazione interprete-mondo, creatore-Tradizione, ad aprire alla formazione “etica” di un autore “eretico”, cioè un autore che conosce alla perfezione il proprio agire e il proprio campo e mezzo che può permettersi soltanto il lusso di sperimentare. Tu dici Violare le forme delle opere precedentemente compiute… Il contenuto di un’opera è la sua urgenza di “dire”, non la sua forma o le sue forme, né i significanti — che rimandano sempre ad altri significanti — né tanto meno i significati — che rimandano sempre ad altri significati. Ed è allora l’atto stesso del “violare” a comprimere il senso di un opera staccata dal proprio autore col paradosso della stessa opera “causa” e “casa” dello stesso autore. Questa violazione indebita riflette sempre la dimensione critica dell’arte e dell’artista: dimensione critica contigua sempre al dato fattuale e al fare artigiano. Ed è tale questa dimensione critica poiché necessita una immersione nel passato della Tradizione, da proiettare, reinventato, nel proprio presente, anche esso reinventato.
 Di qui l’assurda pretesa di alcuni poeti e artisti che vogliono essere per forza contemporanei: l’inattualità invece, è l’unico modo per essere contemporanei e oppositivi al tempo e alla storia. Perché poi parlare di arte, come già detto, significa parlare giocoforza di linguaggio: ma parlare di linguaggio vuol dire soprattutto parlare di storia e di tempo, reale e metafisico assieme. L’eresia in questo senso significa comprensione e critica assieme, capacità di ammirare e di stroncare: esercizio di ammirazione e privilegio dell’odio. Riguarda principalmente una diversa lettura dell’opera d’arte: non in rapporto con l’opera senza autore, ne in rapporto con l’autore senza opera, ma in relazione con la già relazione autore-linguaggio. Quindi il dato principale è che la sua qualifica è essenzialmente “etica”, ma necessita di un’immersione quasi “emica” nell’orizzonte della Tradizione per imparare ad interpretare. L’eresia è, se vogliamo, una delle poche “forme etiche” che producono pensiero e problemi oggi: è una lotta contro le evidenze che cerca di criticare creativamente la contemporaneità, passando per una sua reinvenzione. Il presente è quanto più ci inquieta e quanto più agognamo. Ed è quanto più di inconoscibile noi affrontiamo, nel senso in cui tutto il problema dell’azione nel linguaggio produce, se messa in un certo rapporto di tradimento e di resistenza con nodi e vincoli della Tradizione, è uno specchio che riflette il problema del tempo e della temporalità del linguaggio, cioè la sua dimensione dinamica e storica. Se l’arte deve produrre “realia”, essa deve produrre ciò che dei realia stessi è l’attributo più qualificante, “la presenza”.
Di qui l’assurda pretesa di alcuni poeti e artisti che vogliono essere per forza contemporanei: l’inattualità invece, è l’unico modo per essere contemporanei e oppositivi al tempo e alla storia. Perché poi parlare di arte, come già detto, significa parlare giocoforza di linguaggio: ma parlare di linguaggio vuol dire soprattutto parlare di storia e di tempo, reale e metafisico assieme. L’eresia in questo senso significa comprensione e critica assieme, capacità di ammirare e di stroncare: esercizio di ammirazione e privilegio dell’odio. Riguarda principalmente una diversa lettura dell’opera d’arte: non in rapporto con l’opera senza autore, ne in rapporto con l’autore senza opera, ma in relazione con la già relazione autore-linguaggio. Quindi il dato principale è che la sua qualifica è essenzialmente “etica”, ma necessita di un’immersione quasi “emica” nell’orizzonte della Tradizione per imparare ad interpretare. L’eresia è, se vogliamo, una delle poche “forme etiche” che producono pensiero e problemi oggi: è una lotta contro le evidenze che cerca di criticare creativamente la contemporaneità, passando per una sua reinvenzione. Il presente è quanto più ci inquieta e quanto più agognamo. Ed è quanto più di inconoscibile noi affrontiamo, nel senso in cui tutto il problema dell’azione nel linguaggio produce, se messa in un certo rapporto di tradimento e di resistenza con nodi e vincoli della Tradizione, è uno specchio che riflette il problema del tempo e della temporalità del linguaggio, cioè la sua dimensione dinamica e storica. Se l’arte deve produrre “realia”, essa deve produrre ciò che dei realia stessi è l’attributo più qualificante, “la presenza”.
E, per contiguità, una dimensione di presenza assoluta, extra-oggettuale. E, di conseguenza, affrontando il linguaggio, si affronta una nuova distribuzione dei valori del tempo: l’atto, creativo e critico, destituisce il presente contemporaneo come aggregato di informazione e comunicazione invasiva, sistema di segni. E istituisce una ripartizione anticronologica del tempo: il futuro è quanto non è stato attuato e il non ancora possibile che si confondono; il passato è la dimensione e la profondità della potenza non in atto. E il presente si fa il “momento” di intuizione del vuoto assoluto che pervade la contemporaneità. E il “momento” di creazione di effetti di realtà, problemi come creazioni, creazioni come problemi. E messa in crisi della realtà stessa, fin dalle sue fondamenta, cioè il linguaggio stesso. E quindi, la nozione “stessa” di senso. Per almeno un’onestà intellettuale: far capire come “la conoscenza” sia un’impraticabile oggetto eterogeneo culturale. Non c’è conoscenza se non conoscenza formale. E, nello stesso tempo, non c’è conoscenza che non esiga l’azione fattuale a monte e che non auspichi per la propria realizzazione, come momento culmine, il proprio fondamento di oblio. La conoscenza per realizzarsi non deve essere assoluta, ma sempre transitoria: è l’irruzione del passato nel presente, in cui la conoscenza si adegua alla forma di archivio e museo, a volere ciò.

La conoscenza è incomunicabile: esiste, al di qua e al di là del linguaggio, ma è invisibile. Quindi non si tratta di andare al di là di ciò che già si conosce, cioè accelerare i tempi e sperimentare al sicuro: si tratta di farsi saltare la terra sotto i piedi! Si tratta di mettere in crisi la nozione stessa di “conoscenza”: l’arte è anarchia — quel poco che nel mondo è rimasto — ; è crisi, è empasse. È e deve essere intollerabile e crudele come sensazione. Fa parte del linguaggio del corpo, che per me equivale al ripetuto e reiterato silenzio dell’ Essere. “Si può solo dire nulla”, come scrive a proposito del linguaggio e della scrittura Carlo Sini; poiché è possibile solo creare il vuoto, come dimensione autentica e non alienabile dell’organismo. Al di qua di niente, al di là di tutto, come dice un verso di Domenico Brancale: la poesia pretende e tace. Ci manca “la parola” perché noi la siamo.







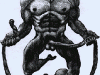





























Commenti
Non ci sono ancora commenti