 Molto si è detto e scritto su Ingmar Bergman. Diversi critici e saggisti di ogni paese e nazionalità hanno esplorato nel corso degli anni la carriera del grande maestro di cinema, scomparso il 30 luglio 2007 all’età di ottantanove anni. Un flusso diluviale di recensioni, articoli e monografie che hanno tracciato il ritratto di un artista la cui personalità resta tuttora inscindibile dall’opera.
Molto si è detto e scritto su Ingmar Bergman. Diversi critici e saggisti di ogni paese e nazionalità hanno esplorato nel corso degli anni la carriera del grande maestro di cinema, scomparso il 30 luglio 2007 all’età di ottantanove anni. Un flusso diluviale di recensioni, articoli e monografie che hanno tracciato il ritratto di un artista la cui personalità resta tuttora inscindibile dall’opera.
All’inizio degli anni Sessanta è stata la critica italiana a fornire il contributo più prezioso, individuando nella trilogia del silenzio di Dio il culmine di una ricerca, una lunga domanda continuamente riproposta in termini diversi, segno di una profonda trasformazione in senso anche stilistico[1].
Lo stesso regista ebbe occasione di affermare a proposito del film Come in uno specchio (1961) che inaugura la trilogia: «Avevo deciso di operare una riduzione. Questo risulta evidente fin dalla prima immagine: quattro persone provenienti non si sa da dove spuntano dal mare»[2].
La comparsa di immagini mitiche coincide con il progressivo affermarsi della figura femminile: agli eroi solitari e meditabondi de Il posto delle fragole e de Il settimo sigillo (1957) subentrano sempre più volti di donna che invadono lo schermo rubando la scena ai personaggi maschili.
Il risultato è una rappresentazione della donna, in uno solo o più personaggi, che sfugge ad una definizione netta e assume i caratteri della contraddizione provocatoria, della virtualità, della sfumatura.
In coincidenza di questo passaggio si sviluppa un altro ambito di ricerca, questa volta di matrice prevalentemente anglosassone, caratterizzato da un approccio interdisciplinare nei confronti del film. In questo modo l’inquadratura, la sequenza, si inscrivono all’interno di un discorso più vasto che comprende lo scenario esterno e politico contemporaneo, i grandi cambiamenti in corso in quegli anni. All’inizio del discutissimo Persona una delle due protagoniste, Elisabeth, viene colta in un attimo di terrore e di smarrimento mentre sullo schermo televisivo che ha di fronte scorrono le immagini violente della guerra in Vietnam. Con un gesto istintivo, Elisabeth alza le braccia a scudo per ripararsi dalla violenza della realtà.
A proposito di questa scena, Paisley Livingstone nel suo libro Ingmar Bergman and the rituals of art parla di violenza, quella ben visibile trasmessa dalla tivù e quella, molto più sottile, che pervade la complessa relazione tra le due protagoniste[3].
Una, Elisabeth, è la malata, l’altra, Alma, la normale; una è la paziente, l’altra l’infermiera; poi, gradualmente, i due caratteri si compenetrano a vicenda e diventa sempre più difficile per lo spettatore stabilire con certezza un margine di differenza per ambedue i casi.
Il progressivo staccarsi da questi due ruoli fissati in partenza crea uno spazio di vuoto, di sospensione, e il film prende forma. Non a caso la sequenza iniziale è caratterizzata dall’immagine di un pezzo di pellicola fotografica che si rompe, si frammenta[4].
 La follia in Persona non si misura dall’analisi psicologico-introspettiva dei personaggi, ma diventa un problema di linguaggio, di come e se sia possibile esprimere attraverso la macchina da presa ciò che non ha una forma certa, immediatamente visibile.
La follia in Persona non si misura dall’analisi psicologico-introspettiva dei personaggi, ma diventa un problema di linguaggio, di come e se sia possibile esprimere attraverso la macchina da presa ciò che non ha una forma certa, immediatamente visibile.
E in questo punto preciso che subentra l’importanza del corpo dell’attore — in questo caso è più esatto dire dell’attrice — come metafora, come tramite atto ad esprimere l’ambiguità, lo scollamento da un unico ruolo. Il volto e il corpo dell’attrice riempiono quella frattura che si è venuta a creare tra l’evento appartenente alla realtà dei fatti, al politico, al sociale, e l’ambiguo personaggio bergmaniano.
Nel volume Ingmar Bergman: tutto il teatro, gli studiosi inglesi Frederick e Lise Lone Marker mettono in luce l’importanza dell’attore come elemento centrale. Il compito del regista è quello di parlare, discorrere con gli attori, disporli sul palcoscenico secondo un metodo coreografico per metterli meglio in relazione tra loro e con il pubblico, in modo che si sentano in grado di recitare con la massima efficacia, sicuri che il loro carisma funzionerà. A proposito di una messinscena dell’Anitra selvatica di Ibsen, un critico svedese scrisse sul giornale: «Senza arredi scenici e con il solo aiuto dell’illuminazione e dell’arte degli attori Bergman crea sotto gli occhi del pubblico quel mondo di fantasia che i protagonisti hanno costruito intorno a sé. Solo le espressioni del viso degli attori e i raggi di luce che dal tetto si proiettavano sul palco e sullo sfondo nero sopra di loro indicavano dove si trovavano e ciò che vedevano in quel regno dell’immaginazione»[5].
La capacità di creare e infondere suggestione è quindi una prerogativa del regista che accomuna il suo lavoro sia sul palcoscenico che sul set.
«In Persona – spiega Bergman nell’autobiografia “Immagini”- c’è una piccola scena in cui l’infermiera racconta ad Elisabeth un’esperienza sessuale insieme ai due ragazzi. Mentre ne descrive i particolari l’unica cosa che vediamo per tutto il tempo è il volto di Elisabeth (Liv Ullmann) che divora la scena. Divora con le labbra ciò che le viene raccontato ed è una scena molto erotica. Se si fosse cercato di ricostruirla con i due ragazzi e le due ragazze il risultato sarebbe stato solo squallido»[6].

Il desiderio e l’avidità che il volto di Elisabeth dimostra mentre ascolta il racconto dell’infermiera — e che diventano tanto più evidenti quanto più li si confronta con la sua assenza di parole — si riflettono sul volto di Alma, che spinta dalla volontà di penetrare oltre questo silenzio, finisce con l’impazzire a sua volta.
Esistono diversi punti di contatto tra il linguaggio del corpo, in special modo del corpo dell’attore, del mimo — di chi insomma si esibisce agli occhi degli altri — e il corpo del folle. Numerosi studiosi, storici ma anche psicanalisti, ne mettono in luce le somiglianze, soffermandosi in particolar modo sul corpo della donna isterica.
A metà Ottocento, la nascita della psichiatria moderna segnala l’importanza del corpo, del sintomo, di tutto ciò che si manifesta allo sguardo indagatore del medico. Il primo luogo che salda l’interesse scientifico — o presunto tale — a quello dello spettatore curioso è, guarda caso, un mondo molto caro a Bergman: ovvero quello dell’artista ambulante, del baraccone, della fiera delle vanità.
Qui vengono allestiti dei veri e propri musei anatomici dove il corpo femminile viene esposto — le cosiddette Veneri di cera — per essere poi studiato e commentato nei minimi particolari. L’elemento drammatico e quello scientifico si riversano cosi inizialmente su di un semplice manichino destinato ad evolversi verso forme animate. Nel grande asilo della Salpetriére, quella che fu la più importante istituzione manicomiale parigina, (…) corpi di alienate si dibattono in preda a furori senza oggetto, derive di una emotività che ha perduto aggancio con le tradizionali forme di autorappresentazione e di comunicazione.
Eppure ancora rimane, nel loro disordinato gesticolare in mezzo a ruvide lenzuola timbrate, un’ombra di grandezza. Sono gesti antichi che rinviano alle posizioni delle statue, classiche per certi versi, barocche per altri; sono spezzoni di iconografia religiosa, brandelli di repertorio teatrale[7].
La donna malata diventa l’oggetto privilegiato di questo sguardo, perché il suo corpo appare misterioso, si presta ad essere esplorato ma allo stesso tempo temuto.
La contrapposizione tra il dramma e la verità scientifica era già al centro delle tematiche di Bergman dai tempi de Il volto (1958). La storia di un mago, di un ipnotizzatore che, ossessionato dal segreto della sua arte, costruisce sul vuoto e viene continuamente messo in discussione e continuamente chiamato a rendere conto alla ragione e all’analisi incarnata dal materialismo del medico Vergerus. Due uomini, due antagonisti si misurano quindi in un conflitto profondo che non trova via d’uscita, ambedue incastrati nella rigidità del ruolo[8].
A partire dalla trilogia, l’enfatizzazione posta sui primi piani di volti e mani femminili riunisce, invece, due aspetti apparentemente inconciliabili: la gestualità fisica, “calda” ed appassionata, prerogativa dell’elemento drammatico e l’atteggiamento “freddo” e distaccato di chi scruta attraverso la macchina da presa. Il corpo dell’attrice ha quindi il potere di comunicare attraverso un semplice gesto e funziona da superficie riflettente, ricreando i conflitti del reale nell’ambito della relazione umana; tanto più se si pensa che proprio a partire dalla trilogia, i richiami alla realtà esterna diventano sempre più artificiosi, di maniera. Al contrario, i corpi delle attrici, svelandosi in tutta la loro complessità, ricercano l’affetto reciproco, lo scambio di effusioni attraverso il contatto di baci, carezze ed abbracci per poi respingersi con la crudezza delle parole, del dialogo. Ancora Livingstone sottolinea la componente di violenza inespressa che trova il suo corrispondente visivo in inquadrature dove l’attrice passa da uno stato catatonico ad improvvisi e incontrollati scatti di nervi[9].
L’esser folle nei film di Bergman non è quindi scindibile dall’essere attrice, dalla sua capacità di contenere attraverso il linguaggio del corpo le mutevoli contraddizioni dell’animo umano, né tanto meno dalla capacità di sognare ad occhi aperti.

I suoi strani racconti e le sue visioni danno vita a una lacerazione interiore che perdura da secoli e che ha trovato nel Novecento alcune delle sue più importanti raffigurazioni artistiche: non ultima quella di un singolare regista che nell’immaginario, dal freddo della sua isola in mezzo al Baltico, continuerà ad affascinare.
Nella soffitta abbandonata
Nel primo film di Ingmar Bergman, Prigione (Fängelse) del 1949, la protagonista Birgitta nel suo sogno sente il pianto del bambino che le è stato portato via appena nato. Il tema della ragazza madre bella e sfortunata che non può tenere il suo bambino era già da tempo presente nel lavoro di Bergman.
In Crisi (1945) uno dei personaggi racconta di aver ucciso la sua ragazza e il bambino di lei soffocandoli con il gas; in Piove sul nostro amore (1946) la fidanzata del protagonista non riesce a portare a termine la sua gravidanza, nonostante venga ricoverata in una clinica.
E infine, in Città di porto (1948) la protagonista finisce nei guai quando confessa di aver aiutato un’amica ad abortire[10].
Sembrano tante varianti di un’unica storia destinate a rimanere incastrate senza riuscire a venire completamente allo scoperto perché altri argomenti avevano la precedenza. Finalmente arriva per Bergman l’occasione di poter proporre un soggetto originale[11], un complicato intreccio di storie parallele tra un regista che cerca una buona storia per il suo film, uno sceneggiatore in crisi coniugale e, per l’appunto, una sfortunata giovane madre.
 Seguire passo passo l’inizio del film, cui le prime scene danno la forma quasi di un labirinto, ci può chiarire le idee. Si inizia teatralmente con un gong, cui segue l’immagine di uno sconosciuto che, con le spalle rivolte alla macchina da presa, ci conduce in un edificio simile ad una fabbrica, che si rivela poi uno studio cinematografico. Bergman lascia che la figura varchi la soglia di una porta, che appartiene in realtà ad un fondale, che viene subito dopo rimosso da un paio di operai. Un primo segnale di demarcazione dunque. Una volta all’interno, assistiamo insieme al nostro accompagnatore ai preparativi per una ripresa: viene provata una carrellata e un campanello nello studio richiama perentoriamente al silenzio. è in questo preciso istante che Bergman fa muovere la macchina da presa e va ad inquadrare Hasse Ekman (nella parte del regista). Come se l’inizio delle riprese, appena annunciato, coincidesse con l’inizio del film, di cui siamo spettatori[12].
Seguire passo passo l’inizio del film, cui le prime scene danno la forma quasi di un labirinto, ci può chiarire le idee. Si inizia teatralmente con un gong, cui segue l’immagine di uno sconosciuto che, con le spalle rivolte alla macchina da presa, ci conduce in un edificio simile ad una fabbrica, che si rivela poi uno studio cinematografico. Bergman lascia che la figura varchi la soglia di una porta, che appartiene in realtà ad un fondale, che viene subito dopo rimosso da un paio di operai. Un primo segnale di demarcazione dunque. Una volta all’interno, assistiamo insieme al nostro accompagnatore ai preparativi per una ripresa: viene provata una carrellata e un campanello nello studio richiama perentoriamente al silenzio. è in questo preciso istante che Bergman fa muovere la macchina da presa e va ad inquadrare Hasse Ekman (nella parte del regista). Come se l’inizio delle riprese, appena annunciato, coincidesse con l’inizio del film, di cui siamo spettatori[12].
Da queste prime battute, sappiamo che i protagonisti sono il regista, lo sceneggiatore Thomas e in generale l’ambiente caotico del set cinematografico, secondo l’esempio. Ma il soggetto che Thomas (Birger Malmstem) propone all’amico regista, la storia di una prostituta che sta in un racconto seppellito tra le cianfrusaglie dell’artista nel suo appartamento, esce dalle pagine e si trasforma in immagine. Un narratore fuoricampo guida lo spettatore attraverso i vicoli del vecchio centro di Stoccolma sulle tracce di qualcosa o di qualcuno, finché la macchina da presa si ferma su una ragazza che si trascina dentro una casa vecchia e trascurata, camminando faticosamente sale le scale e suona il campanello. Questo espediente letterario che guida lo spettatore in una direzione precisa[13] e lo costringe a seguire le vicende della ragazza fa a pugni con la struttura a scatole cinesi usata nelle scene d’apertura.
È come se il film sentisse la spinta insopprimibile di prendere una strada e di seguire solo quella, cancellando con un colpo di spugna la struttura ad incastro, frammentata, eccezionalmente postmoderna per una pellicola datata 1949.
Prigione trova il suo asse dopo i primi venti minuti, è un film ad altissimo tasso di sperimentazione e il rischio di apparire nonsense è forte durante tutto l’inizio. Ma dal momento in cui il narratore fuoricampo introduce le immagini di Birgitta il film si orienta inequivocabilmente, trova il suo centro e non lo abbandona più. Prigione rivela cosi l’assenza di una struttura premeditata, costruita, studiata a tavolino, come spiega il regista:
«Ho scritto il soggetto in due, tre giorni. La preparazione della sceneggiatura ha richiesto un po’ più di tempo, e il film è stato girato in sedici o diciassette giorni. Non ho avuto il tempo di approfondirne la forma estetica, di metamorfizzare per così dire la sceneggiatura, come ho fatto in seguito quando ho compreso meglio i temi e i motivi che sono presentati qui in maniera molto cruda»[14].
Nella scena del sogno e nelle brevi inquadrature che la preparano, la sperimentazione sale alle stelle: rispetto alla visione nella stanza del pittore viene mantenuta la stessa atmosfera perturbante ma la modalità di rappresentazione è totalmente diversa.
In questo film il passaggio dalla realtà al sogno è molto complesso, il sogno emerge gradualmente dalle immagini, lo si avverte “nell’aria” ma chi guarda non riesce subito ad afferrarlo: insomma, si fa desiderare attraverso una serie di piccoli aiuti.
Il primo di questi è il racconto di Birgitta (Doris Svedlund), la prima chiave che ci permette di penetrare nel sogno che verrà e nella sua atmosfera perché lo abbozza tramite una descrizione, lo evoca e lo chiama. È interessante come il fatto che si tratti di un sogno passato, in altre parole dì un ricordo, scivoli in secondo piano rispetto all’economia delle immagini.
In questo modo il racconto prima e le immagini che seguono si rendono garanti del doppio status di Birgitta, contribuiscono a rendere la sua figura ancora più misteriosa situandola in un altrove che ancora non si mostra. Birgitta con le parole e con la testa è ancora lì, nel sogno che l’abbiamo appena sentita raccontare.

Quando Birgitta inizia il suo racconto un meccanismo ad ingranaggio è pronto a scattare. La macchina da presa si avvicina gradualmente al suo volto, il carillon inizia a suonare e la luce che le illumina il volto si fa più vivida e intensa. Tre elementi diversi coordinati da istanze diverse entrano in gioco contemporaneamente col tempismo d’un attacco d’orchestra, in cui tutti i componenti sono perfettamente autonomi l’uno dall’altro ma obbediscono ad un unico ritmo. Proprio la precisione e l’accuratezza con cui viene eseguita l’operazione mettono in risalto come tutti questi elementi si trovino in complementarità l’uno rispetto all’altro. Il racconto di Birgitta è perfettamente funzionale al movimento di macchina e anche viceversa, e lo stesso vale per la luce e la musica.
A proposito del carillon — leitmotiv doppio, sia visivo che sonoro presente anche in altri film di Bergman — Koskinen vede a ben ragione uno dei “segnali che demarcano la finzione, un’acuta coscienza della presenza dall’altra parte del pubblico[15]”. Sempre secondo Koskinen questi segnali sottolineano la cura e “l’attenzione di Bergman ad apostrofare il pubblico per guidarlo oltre la magica soglia, e poi tornare a ricordargliene l’esistenza una volta che la finzione è ben impiantata”[16].
In Prigione il carillon svolge esattamente questa funzione di guida che ha il compito di ricordare ancora una volta a chi guarda che siamo in un sogno.
Ancora una volta nessuno stacco si rende necessario por inquadrare il volto ma è l’obiettivo che si avvicina gradualmente ad esso e il suo movimento lento, il suo lungo attardarvisi durante tutto il tempo del racconto rivelano il piacere dell’inquadrare. Così anche da come ruota sempre molto lentamente e ci gira intorno (sembra che lo stia corteggiando) per osservarlo da prospettive diverse in tutta la sua bellezza. Il volto si offre nuovamente, e le parole di Birgitta incominciano e finiscono esattamente là dove incomincia e termina l’offerta, scandiscono il tempo dei corteggiamento.
Quest’atmosfera di calore e armonia evapora misteriosamente nelle immagini successive lasciando dietro di sé un’ombra, una scia di irrisolto rappresentata dai due profili indistinti nell’oscurità che vengono illuminati solo a tratti dal fuoco del caminetto.
Il fuoco è l’unico elemento che si collega alla scena precedente (cfr. il bagliore delle fiamme sul viso di Birgitta mentre racconta) e che può suggerire che i due profili che lo spettatore fa fatica ad identificare siano quelli di Birgitta e di Thomas. La serie di immagini che si susseguono appaiono e scompaiono per dissolvenza nello stesso tono misterioso e sottraggono alla vista dello spettatore quello che fino a pochi secondi prima avevano mostrato.
Salvo poi rilanciarlo, molto eroticamente, alla fine di tutte le dissolvenze quando sullo schermo ritornato luminoso e perfettamente distinguibile il volto riappare, prima quello di Thomas seguito da quello di Birgitta. Il volto viene dunque prima mostrato, poi misteriosamente celato, poi fatto sparire, poi rimostrato secondo una meccanica del desiderio che trova il suo apice in quest’ultima fase[17]. Questo atteso ritorno esaudisce la tacita richiesta dello spettatore così da creare una notevole sovrapposizione tra la soddisfazione di chi guarda e quella di chi è guardato (cfr. il sorriso dì visibile appagamento sui volti dei protagonisti). Qui le immagini occultano e per tutto il tempo lasciano sottinteso quello che è successo nel frattempo tra i due in una maniera molto sottile e velata, ed allo stesso tempo danno vita ad un erotismo sofisticato che una messa in scena diretta non avrebbe permesso.

Questo bel ritorno all’atmosfera iniziale è però destinato a durare così poco che subito la macchina da presa incomincia il suo movimento verso il basso, una specie di discesa agli inferi. Dopo aver attraversato una zona d’ombra (cfr. lo schermo nero) si ferma sul pupazzetto del carillon, quello che Birgitta stringeva tra le mani al momento del racconto.
Dal sogno ad occhi aperti…
Dare un luogo, un posto alla follia, a tutto ciò che non è possibile toccare con mano ha rappresentato un proposito che si presenta in maniera ricorrente, quasi ossessiva nella cinematografia di Bergman.
Attraverso i racconti dei personaggi, giunge notizia di strane e misteriose figure serrate dietro una parete; poiché il regista dapprincipio si rifiuta di filmarle, di dare loro fattezze umane e riconoscibili, allo spettatore viene istintivo di chiedersi che cosa stiano a rappresentare queste figure che Bergman descrive nella versione originaria della sceneggiatura del film Prigione (1949) di seguito riportata.
«Il salone della signora Bohlin era una stanza con mobilio fuori moda. Vi erano spessi tappeti sul pavimento, molti quadri con motivi italiani alle pareti, statuette, un’alta stufa di maiolica che se ne stava a dormire in un angolo, enormi sofà e poltrone, un lampadario al soffitto e tre finestre, munite di pesanti tendine drappeggiate che davano su una strada con piante di tiglio. A una parete era appeso un nero orologio che ticchettava maestosamente, su un panciuto comò c’era una piccola pendola che pulsava con veloci tintinnii e sulla cornice della stufa di maiolica stavano alcune preziose conchiglie e fotografie di parenti della signora Bohlin, di cent’anni fa.
“Tra poco il sole si alzerà e allora ti farò vedere qualcosa di molto singolare” -disse serio Andreas- “Qualcosa che non cessa mai di stupirmi e di riempirmi di venerazione mista a terrore per questa vecchia stanza e per tutte le altre vecchie stanze in cui delle persone hanno vissuto a lungo insieme. Ma aspetta. Proprio ora il sole si alza in fondo a questa strada e s’infiltra qui. Guarda, guarda. Vedi?” -indicò con fervore dietro alla parete-. “Non vedi lì, sulla parete? Là! E là! E là!”.
“No” -disse Birgitta Carolina- “non vedo niente”. Allora lui la condusse più vicino alla parete dove brillava un raggio di sole. “Vedi adesso?” -disse, e la sua voce tremava un poco- “guarda qui, e là, e là!”.
Lei prima aveva già notato che la tappezzeria aveva un disegno insolito, ma ora all’improvviso scopriva che esso cangiava non appena un raggio lo illuminava e che una quantità di volti apparivano in quella tremante striscia di luce. “Vedo!” -mormorò Birgitta Carolina.
“Sì, è una cosa straordinaria” -disse Andreas. Poi lui non disse più nulla per non turbare questo meraviglioso spettacolo. Dopo qualche minuto, infatti quei volti non solo si trovavano nella striscia di sole, ma tutta la parete ne era piena, erano parecchie centinaia forse migliaia.
E, nel silenzio, Birgitta Carolina sentì un coro di voci che sussurravano.
Erano deboli e distanti ma lei poteva distinguerle molto chiaramente. Parlavano tutte insieme, alcune ridevano altre piangevano, alcune sembravano gentili, altre dure e indifferenti.
C’erano voci vecchie, voci di bambini, voci di giovani donne e voci soprane di vecchi che piagnucolavano, si sentivano i bassi di direttori che brontolavano e gioviali nitriti maschili. Era come una musica di toni irreali, che saliva e scendeva come la risacca di un mare infinito.
“È come se questa parete fosse una lastra fotografica” — disse Andreas- “e questa stanza una magica macchina fotografica. Ogni essere umano che è stato dentro questa stanza è stato ritratto. Qui, devi vedere” -disse trascinandola con sé e indicandole un volto sbarrato, semigirato che era il suo, quello di lui. All’improvviso tutti gli orologi suonarono le cinque e mezzo e un grande carro della spazzatura passò cigolando sulla strada, la luce del sole si spense, i volti sparirono, le voci morirono e la stanza riprese il suo aspetto di salone borghese di un tempo irrimediabilmente trascorso»[18].

Primo film scritto e diretto da Bergman, Prigione è anche il suo primo, esplicito tentativo per conferire una dimensione simbolica a oggetti come specchi, fotografie e bambole, per esprimere stati d’animo, emozioni e idee.
In particolare, questa misteriosa visione sulla parete costituisce una sorta di vero e proprio filo conduttore che il regista svilupperà anche nei successivi film Come in uno specchio, L’immagine allo specchio e anche in Fanny e Alexander. Nel suo giocare con la fantasia allucinatoria, senza più ritorno al reale, consiste il ‘rischio’ dell’artista Bergman ed al contempo il suo fascino.
In corrispondenza delle numerose modifiche che la versione originaria della sequenza, così come Bergman riporta dettagliatamente nell’autobiografia Immagini, subisce nel tempo, cambiano anche le caratteristiche della protagonista, che dalla ragazza sognatrice e ingenua si trasforma in una donna malata, ritenuta pericolosa e incontrollabile dalla società.
In Prigione la presenza di strane figure che si agitano sulla parete e che solo i due protagonisti riescono a vedere viene immediatamente percepita dallo spettatore sotto forma di suono, di un sommesso brusio che sta ad indicare che dietro alla parete qualcosa c’è ma ancora non si decide a manifestarsi.
Aggiunge Bergman a mo’ di corollario della scena:
«Se penso che la frattura tra diverse realtà ha rappresentato la mia vita dall’inizio fino ad oggi, trovo che i risultati della mia raffigurazione di essa siano stati relativamente magri. Soltanto poche volte sono riuscito a forzarne i mutevoli confini. In Prigione non ci riuscii affatto. Le visioni della tappezzeria furono cestinate»[19].
Nel film la figura della sognatrice Birgitta nasce dalle pagine di un racconto: appartiene quindi per definizione all’universo dei fittizio e la sua provenienza le impedisce di integrarsi agli altri personaggi, relegandola in uno stato di sospensione tra realtà e immaginazione come di chi cammina sospeso a mezz’aria.
Questo sguardo lunare caratterizza molti dei protagonisti dei primi film del regista: ad esempio, in Crisi (1946) uno dei personaggi è anch’egli un artista, un attore un po’ pazzo che racconta episodi di vita passata alla ragazza di cui è innamorato che assomigliano più a delle favole che a fatti realmente accaduti. Narrare una storia, in questo caso, corrisponde ad aprire un mondo per chi ascolta: ed in entrambi i film è una figura creativa — un attore in Crisi, un pittore in Prigione — ad aprire questo mondo ad una ragazza che resta incantata ad ascoltarlo.
Sola nella stanza con il pittore, buffa, piccola e sperduta, Birgitta incomincia a intravedere le creature misteriose che si agitano sulla parete: i loro volti appaiono e scompaiono, avanzano e indietreggiano, i contorni si fanno via via più chiari o più incerti, più vicini o più lontani.
In un’ipotetica galleria di ritratti femminili bergmaniani, appare il volto di Birgitta, spettatrice che assiste a questo misterioso spettacolo, mentre guarda a questo mondo di pura immaginazione con un misto di paura e di curiosità: i suoi occhi perennemente spalancati e l’espressione di stupore infantile rimandano ai tratti della bambina delle fiabe, di colei che come in un sogno, intraprende un lungo viaggio inoltrandosi in territori sconosciuti, dove l’orrido convive accanto al meraviglioso.
Lo sguardo stralunato e malinconico getta il seme della follia, l’impossibilità di delineare un confine preciso tra ciò che si vede e ciò che esiste: pur ammantata da quella che viene comunemente definita come fantasia o creatività, la sognatrice, la bambina ingenua che ascolta a bocca aperta tutto quello che le viene raccontato è una figura destinata a scomparire, almeno per un po’ di tempo.
In un altro film celebre per le sequenze oniriche, Il posto delle fragole (1957) il sogno acquista un sapore già molto diverso, più amaro, legato com’è alla nostalgia, alla sensazione di irrecuperabilità dei tempo perduto.
La parte fantastica, inspiegabile ed irrazionale si annacqua, giustificata dal rimpianto di un evento irrimediabilmente trascorso ma inscritto nella biografia dei protagonista, un anziano docente universitario[20]: in poche parole, un ricordo.
Poiché chiunque può far emergere un avvenimento, una frase, un’immagine dal proprio passato, ridar loro una vita che fisicamente non possono più avere, è interessante notare come la visione fantastica in Prigione si caratterizzi rispetto al flashback proprio per la sua provenienza ignota, per la sua apparente incongruenza.
…al delirio schizofrenico
Quando dunque dieci anni più tardi Bergman riprende l’idea della parete animata nel film Come in uno specchio (1960), questa da superficie nella quale inscrivere un’immagine nonsense diventa un vero e proprio specchio — da cui il titolo — che tende a riflettere le angosce profonde della protagonista.
Il passaggio dall’immaginazione alla malattia avviene in maniera sottile, quasi occulta: l’idea di un universo immaginario vivo e mobile, in perenne movimento diventa l’ombra spaventosa di un dio che sceglie di manifestarsi alla protagonista con l’aspetto di un ragno.

«Sentivo che dovevo fare un film su qualcuno che fluttuava attraverso la carta da parati — afferma il regista — e pensai che la Andersson (l’attrice Harriet Andersson che nel film interpreta il personaggio della visionaria Karin, nda) fosse la persona indicata. Vedevo una piccola porta nel muro. Attraverso questa porta lei entrava in un altro mondo e da lì anche usciva. Viveva serenamente in entrambi i mondi ma gradualmente quello reale, il mondo degli oggetti quotidiani che ci circondano, le diventa sempre più estraneo finché quello delle sue fantasie prende completamente il sopravvento»[21].
L’immagine di Harriet Andersson che, appoggiata alla parete, cerca di carpire i suoni e le voci del mondo misterioso situato al di là del muro è nota: siamo nel 1960 e il film da La tappezzeria è diventato Come in uno specchio.
Qui l’onirismo barocco si raggela in un’osservazione impassibile degli stati d’animo, e la macchina da presa resta ferma sul suo volto contorto in una smorfia di terrore mentre la donna urla e si contorce come un animale in trappola, il corpo percorso da un singulto che non trova alcuno sfogo esterno.
Nel suo personaggio sono già evidenti quella centralità che il corpo, i gesti e l’espressione della folle assumono nella filmografia di Bergman. La figura apparentemente irreprensibile e normale di una qualsiasi signora borghese si trasforma e rinvia ad una natura segreta, da ‘rinchiudere’.
“Voglio essere mandata in un ospedale” — afferma categorica Karin alla fine del film — “ma non m’importa di essere curata”.
Attraverso le parole della donna sembra quasi di scorgere l’ombra inquietante dell’edificio profilarsi all’orizzonte, un luogo dove attraverso i corridoi lunghi e deserti si aggirano medici che hanno tutti lo sguardo freddo e inespressivo del marito di Karin, anch’egli medico.
Malgrado in Come in uno specchio non venga mostrato direttamente, è rilevante notare come in altri film del regista l’ospedale non è mai il luogo affollato che si è abituati a vedere nella realtà quotidiana, ma sembra più una clinica privata: un luogo di ritiro solitario e al contempo di riposo, in grado di garantire controllo e protezione a chi vi cerca ricovero, ma per questo motivo inquietantemente simile alla casa, allo spazio domestico.
Poiché nel mondo borghese messo in scena da Bergman predominano l’intimità, la riservatezza e il decoro, che trovano la loro incarnazione nelle figure speculari della moglie e della madre, l’indifferenziazione dell’ambiente casa — ospedale, interno — esterno trova un ulteriore punto in comune nella figura della donna malata, che si pone rigorosamente al di fuori di questi due modelli ‘classici’. In essa confluiscono tutti quegli elementi destabilizzanti quali la malattia, il lutto, la morte che la rende oggetto di ripugnanza e insieme di ammirazione, di rifiuto e di amore da parte di chi le circonda.
Uno dopo l’altro sfilano i corpi di Marta (Luci d’inverno, 1963), affetta da un eczema che le ricopre le mani e si estende al volto procurando ribrezzo nel suo compagno.
Ester (Il silenzio, 1963), immortalata negli ultimi giorni della sua malattia è un corpo agonizzante che a fatica si trascina dal letto alla poltrona, e di cui il film attende la morte come l’evento risolutorio.
Elisabeth (Persona, 1968) ai fiumi di parole del dramma da camera contrappone un mutismo che ha la forza, la trasparenza della parola vera.
Tutte queste figure, compresa la protagonista di Come in uno specchio, sono accomunate da una condizione anomala che le riveste di una visibilità eccezionale.
L’obiettivo porta fuori lentamente la malattia, la scruta nel suo manifestarsi; produce inquadrature piene di una fisicità ossessiva, fatta di volti contratti, occhi sbarrati, corpi schiaffati — non senza un certo compiacimento — in faccia a chi guarda col favore del primo piano e dell’elaborazione di una nuova tecnica.
«Pensai che avrei potuto piazzare la macchina da presa in un punto della stanza e che essa dovesse fare soltanto un passo avanti o uno indietro. I personaggi avrebbero dovuto muoversi in rapporto all’obiettivo. La macchina da presa avrebbe dovuto soltanto registrare, senza mai eccitarsi o partecipare. Dietro tutto questo c’era un’acquisita convinzione che quanto più violenta è l’azione, tanto meno la macchina da presa deve partecipare. Essa deve mantenersi obiettiva, anche quando l’azione raggiunge culmini emozionali»[22].

La macchina da presa registra con l’impassibilità dello scienziato, come lo sguardo del medico rappresentava una delle componenti fondamentali dentro il manicomio nascente, lo sguardo proiettato sul mondo, interiore del folle che parla, del folle che dà voce alla sua sofferenza, del folle che la rappresenta muto attraverso il teatro del suo corpo: del folle insomma che riesce ad esibire il contenuto storico, sociale, politico, religioso e personale del suo delirio[23].
In questo contesto, la donna che si sottrae ad un’immagine eticamente corretta e soprattutto socialmente utile, la cui natura disordinata e pericolosa non può essere tenuta a freno viene rinchiusa, studiata e alla peggio volgarmente esibita.
Le cartelle cliniche e l’archivio fotografico — le cosiddette planches esquiroliane — conservano la memoria del corpo femminile che illustra i sintomi classici, e che conduce ad una sistematizzazione del sapere sul corpo, sulle sue pulsioni segrete che vengono per l’appunto definite sotto l’etichetta di malattia.
La studiosa femminista Joan Mellen asserisce che “in Bergman manca totalmente l’idea che le donne possano trascendere ed abbiano di fatto superato le norme dell’ascetico ed inflessibile pensiero filosofico ottocentesco nel quale egli è totalmente sommerso […]. Le loro vite mancano di significato perché troppo stretto è il vincolo con la loro biologia e con l’incapacità di darsi un significato esistenziale che trascenda il loro ruolo sessuale. In questo senso si può dire che Bergman è molto più duro, e dei tutto arbitrariamente, con le sue donne che con i suoi uomini. Esse vengono descritte come parte di un livello inferiore dello sviluppo umano. Anche se la ricerca filosofica del significato esistenziale non dovrebbe essere influenzata dagli ormoni, Bergman insiste nel sostenere che, proprio a causa della loro fisiologia, le donne sono intrappolate in esistenze vuote e desolate in cui sfioriscono al primo apparire delle rughe sul volto”[24].
È ben noto che il tardo Ottocento si servì delle scoperte scientifiche per trasformare i conflitti sessuali in una denuncia scientificamente fondata della sessualità femminile quale fonte di smembramento e degenerazione sociale[25].
Ma se il pensiero filosofico etichetta, definisce e secondo un filo logico discorsivo produce un’immagine femminile di cui si propone la piena e completa padronanza, dinanzi allo sguardo del regista il corpo femminile rappresenta proprio tutto ciò che al pensiero classificatorio continua a sfuggire: la sensualità dei volti, degli occhi, delle mani, il mistero del corpo nella forma della sofferenza e dell’insofferenza. La malattia diventa un fatto estetico, nel momento in cui l’obiettivo anziché impietosirsi dinanzi alla malattia ne è morbosamente attirato, tende a metterne in risalto l’aspetto combattivo, il corpo che lotta contro la morte e la malattia: lungi dal suscitare compassione o tristezza, le malate appaiono mostruose in quanto meno tempo resta loro da vivere, più scaturisce l’istinto di aggrapparsi agli ultimi istanti di vita con le unghie e con i denti.
Le coppie e le famiglie che vivono intorno alla donna malata vivono questo peso con tutti i problemi che ne derivano, in bilico tra l’ansia di liberarsene e il senso di colpa per desiderarlo.
Funzionano quindi come delle microsocietà, da cui la definizione che ne dà Bergman di gruppo umano[26], la cui dinamica è particolarmente evidente ad esempio in Sussurri e grida: le sorelle e la balia vanno e vengono intorno al letto su cui giace la malata Agnes, seguendo un ritmo coreografico a mo’ di danza funebre. Dopo la morte, la resurrezione: di questa danza il corpo della moribonda è il controcanto, spunta e rispunta nel corso del film come una nenia ossessiva che simboleggia gli intrighi tra sorelle, i loro difetti e debolezze, le profonde meschinità.
Anche in Come in uno specchio la malattia è una sorta di leit-motiv che percorre il film in maniera sottile, inizia appena appena a trapelare discorsi dei familiari della protagonista, creando un’evidente disparità con le prime inquadrature che mostrano una Karin allegra, scherzosa, quasi in apparenza niente possa turbarla. A produrre la malattia della donna è lo scarto che si crea tra le parole e le immagini, tra ciò che viene inquadrato, il volto, un corpo, quanto di più concreto e tangibile esista sulla faccia della terra, e ciò che invece non viene rappresentato direttamente ma “sta” lì, come sospeso nel vuoto, o nascosto tra le pieghe del suo pensiero, precluso allo spettatore.
Per poter esprimere la sostanziale continuità che secondo Bergman intercorre tra fantasia e realtà, il regista crea il personaggio di un dio misterioso che, nascosto dietro alla carta da parati, minaccia con la sua presenza la protagonista:
«Un dio scende in una persona e prende dimora in essa. Prima appare soltanto come una voce, un grave sapere o un ordine. Minaccioso o supplichevole, ributtante ma anche sollecitante. Così la sua presenza s’impone sempre di più, e l’uomo può sperimentare la forza del dio, imparare ad amarlo, sacrificarsi per lui, fino all’estremo attaccamento e al vuoto completo. Quando questo vuoto viene raggiunto, il dio prende l’uomo in suo possesso e compie le proprie azioni attraverso le mani di questi. Ma una volta che l’uomo è vuoto, bruciato e senza più alcuna possibilità dì vivere nel mondo, allora lo abbandona. là questo che succede con Karin. E la linea di confine che lei deve varcare è il singolare disegno della tappezzeria»[27].

Karin è insomma in preda ad un terrore folle — Bergman parla come di un caso di schizofrenia religiosa — e la paura che la attanaglia è dentro, non fuori. È la paura di un desiderio, forse anche sessuale, che la attraversa senza che lei possa opporvi freno; il suo corpo appare contratto, come se facesse resistenza ad una forza ostile, ma si tratta di una resistenza impossibile perché l’altro è temuto e atteso al tempo stesso.
«È un dio che le parla. Lei è umile e sottomessa di fronte al dio che adora. Dio è sia scuro che chiaro. Talvolta le dà degli ordini incomprensibili, di bere acqua salata, di uccidere animali e così via. Ma talvolta è pieno d’amore e le dà forti emozioni, anche sessuali. Scende giù e si traveste da Minus, suo fratello più giovane. Nello stesso tempo il dio la costringe a rinnegare il suo matrimonio. Lei è la sposa che attende il suo sposo, e non può insudiciarsi. Lei trascina Minus nel suo mondo. Lui la segue volentieri e con ardore, poiché si trova al limite della pubertà. Il dio crea sospetti e invia falsi segnali a Martin e a David (il padre e il fratello) perché stiano in guardia da lei. Invece fornisce Minus di doti straordinarie»[28].
Rispetto al desiderio dirompente di Karin è come se una presenza invisibile spingesse continuamente in senso contrario, ansiosa di placare il delirio della donna per riportarla all’ordine.
“Come ci si avvicina al corpo altrui, all’intimità del suo dolore o del suo piacere?” sembra chiedersi Bergman. La risposta è tramite lo sguardo, e poiché vi è una connivenza sottile tra il desiderio di osservare e mostrare, si può dire che il corpo della malata contenga in sé una forte dose di erotismo. Si tratta però di un eros sotto vetro, di un corpo immobilizzato nell’inquadratura che rifugge dal controllo, inventa stranezze, si inarca, e lotta continuamente con il bisogno, ancora una volta, di raccontare quello che si è visto.
La follia si trova a venir compressa in quell’angusto spazio che è il vecchio solaio dove avvengono gli incontri tra la donna e il dio; una volta lì può uscirne soltanto sotto forma di racconto, attraverso lo sfogo di Karin al fratello per ciò che ha visto ma non riesce ad afferrare razionalmente.
Raccontare la follia
Tuttavia l’atto di narrare, anziché procurar sollievo nella protagonista, la conduce sull’orlo di una contraddittorietà esasperata: come ogni isterica, Karin è attraversata da impulsi contrastanti che il resoconto di quello che lei solamente vede si rivela totalmente incapace di contenere.
Il rapporto tormentato che Karin vive con il bisogno di narrare ciò che ha visto, di ritrovare insomma un interlocutore disponibile all’ascolto riporta al problema di come — e se — sia possibile recepire la follia.
D’altra parte tutto il film, primo di una serie di Kammerspiele o drammi da camera[29] si misura su di un evidente conflitto: da una parte la scelta del regista di non dare un’immagine visibile al dio, dall’altra la necessità di affidare alle parole della donna il racconto di quello che accade oltre la parete.
Per chi la ascolta, in questo caso il fratello Minus, non è possibile più di tanto penetrare nel pensiero della folle. Figura dei disordine, del caos, ella mette a disagio chi la ascolta: so il suo sfogo verbale può rappresentare un punto di ancoraggio e di decifrazione della visione, la confusione delle sue idee, la frequente incomprensibilità dei suoi discorsi e delle sue frasi producono un misto fra paura ed attrazione.
Malgrado ciò, la folle parla, parla e ancora parla: solitamente parla a ruota libera e si caratterizza proprio per come espone direttamente e con dovizia di particolari la sua esperienza. Nei suoi racconti emerge il ricordo dell’incontro con il dio in tutta la sua vivezza, insieme alla consapevole lucidità che quello che viene raccontato è qualcosa che appartiene ormai ad un tempo passato.

Nel caso del dramma bergmaniano, l’immagine che continua ad agitarsi “lì dentro” resta inaccessibile, chiusa, murata dietro a quella parete — questa volta in senso metaforico — che è il pensiero della folle.
Se in Come in uno specchio la narrazione si misura con il tentativo di gettare un ponte tra l’irrazionalità della donna e l’intoccabile normalità dei suoi familiari, il padre, il marito, il fratello, mano a mano che si avanza nei film successivi questo gesto di fiducia viene sempre più a mancare: a distanza di due anni, ne Il silenzio i personaggi comunicano tra di loro come i sordomuti, tramite una sequela di gesti, timidi cenni del capo oppure smorfie di dolore.
La parola perde il suo valore comunicativo, specchio di una profonda solitudine che porta i personaggi ad imboccare il sentiero di quella che il regista ha spesso definito come «l’analfabetismo dell’animo»[30].
In Persona la scelta di porre al centro del film una figura di donna afasica segnala un’ancora più accentuata perdita di fiducia nei confronti dell’espressione verbale. La scienza psichiatrica colloca l’afasia ai margini estremi della nosologia, in un paesaggio desolato, povero se non vuoto di parole, popolato da gesti, da grugniti, da fonemi senza senso[31].
Al contrario, nel film la parola introiettata, trattenuta si rivela per assurdo in grado di disegnare sul volto dell’afasica Elisabeth (Liv Ullmann) un’ombra di dolce consolazione che, più che alla pazzia, sembra alludere ad un silenzio di sapore diverso, arcaico: delle profetesse del teatro antico che tramite la parola guidavano i personaggi attraverso la propria sorte, Elisabeth è l’immagine rovesciata. La macchina da presa la coglie nel bel mezzo di una rappresentazione dell’Elettra sofoclea (è un’attrice teatrale, nda) mentre si guarda intorno con lo sguardo smarrito, la voce che non riesce più ad emettere alcun suono, completamente sola sotto i fari del palcoscenico. Le figure mitiche, sembra suggerire Bergman con quest’inquadratura, sono soltanto un apparato di trucco e abiti da scena, che una volta smessi lasciano trapelare l’incertezza di una donna alla ricerca di una propria identità.
D’altronde «Come in uno specchio, Luci d’inverno, Il silenzio e Persona sono Kammerspiele (drammi da camera). Sono musica da camera. Ossia il puro atto di coltivare un certo numero di temi per un ristrettissimo numero di voci e figure. I fondali sono astratti, velati da una specie di foschia. Si opera una distillazione»[32].
Quella foschia che permane contribuisce a rendere l’atmosfera di questi film perennemente ambigua, come se, accantonata l’idea della parete, il regista sentisse ancora urgentemente l’idea di allestire uno spazio dove realtà e fantasia siano libere di confondersi.
Forse è dovuta proprio a questa volontà inesaudita quella sensazione di oppressione che continua a gravare sui Kammerspiele, quel continuo dibattersi dei personaggi in un mondo-prigione da cui riesce difficile evadere.
La creatura nascosta dietro la parete
Ma in Fanny e Alexander (qui il protagonista è un vero e proprio bambino), anch’egli perso nella grande casa dei nonni, la stanza magica è destinata a trovare la sua compiuta realizzazione: non più un semplice luogo di ricovero com’era la stanza della malata, ma uno spazio di totale e libera fantasia.
Al suo interno, si nasconde la creatura bisessuale: «Ismael, l’idiota dal volto angelico, dall’incerta figura sottile e dagli occhi senza colore che vedono tutto. Egli può compiere azioni maligne, è una membrana per i desideri. Esperienze dell’occulto di Alexander: la conversazione con il padre morto. Dio gli si mostra. Incontro con il pericoloso Ismaele, che manda la donna in fiamme ad annientare il vescovo»[33].
In questa casa, il bambino vede mostri a volontà ma ne sembra, più che spaventato, misteriosamente attirato. Non corre pericolo, e anche l’immagine femminile ha cessato di incutere turbamento, prontamente ricondotta all’irreprensibilità della figura materna, borghese delle varie mamme, nonne e zie di Alexander.
Prodotto dello sguardo di un bambino anziché di quello di un adulto la visione perde il suo aspetto distruttivo, malato, e assume le caratteristiche di una creatura “buona”, o quantomeno comprensibile: «Ismael è un groppo di timori, né maschio né femmina, è l’incertezza stessa di fronte alla sessualità, alle sue scelte e ai turbamenti affettivi che accompagnano l’adolescenza. Ismael è il testimone di sentimenti profondi non mai scioglibili, ambiguità e ambivalenze custodite nel punto più interno e protetto. Anche se con la dovuta prudenza a Ismael si deve dare ascolto, bisogna imparare a parlare con lui senza eccessiva paura, bisogna imparare a vivere con lui; egli deve essere nutrito e accettato, basta sapere quando tenerlo rinchiuso»[34].
La mostruosa visione trova finalmente uno spazio apposito dove stare senza che sul film gravi quell’atmosfera di soffocamento presente nei Kammerspiele. Al contrario, in questo romanzo visionario, la follia diventa una magia inarrestabile, che trova nella stanza magica il suo luogo idoneo, al riparo dal conflitto mentale che ossessionava le donne malate.
È in questi ultimi due film che Bergman riesce a raccontare con naturalezza quello che in precedenza aveva richiesto uno sforzo necessario. Aprire le porte del pensiero altrui è praticamente impossibile e il sottinteso disprezzo nei confronti dell’ottimismo scientifico, di un sapere di tipo positivista che aleggia nella cinematografia del regista ne è un’ulteriore prova.
Medici e scienziati vengono messi alla berlina come figure molto spesso esagerate, caricaturali che tentano di arrivare alla verità in maniera artificiosa; a questi si oppone il medico “stregone”, il dottore dal sorriso beffardo di Sussurri e grida (1973) che spia attraverso i lineamenti i segni e le rughe del volto i segreti dell’altro. Ma, sembrano dirci questi ultimi due film, L’immagine allo specchio e Fanny e Alexander, attraverso la narrazione di ciò che si è visto e vissuto privilegiando ora le parole ora le immagini è possibile dare vita ad un nuovo disegno.

Questa volta non più un ammasso di voci e di volti che si agitano alla rinfusa sulle pareti ma è il volto di una strana creatura che, messa a confronto con il pensiero di un bambino, non suscita più timore. Un nuovo disegno dove la follia intreccia lo stesso sentiero della fantasia e della fiaba, come se la mano del regista andasse a tirare fuori quelli che erano i pensieri rinchiusi nella mente dei personaggi e ne ritagliasse tante, diverse magiche figurine.
Note
[1] Si veda a questo proposito il volumetto di Massimo Maisetti La crisi spirituale dell’uomo moderno nei film dì Ingmar Bergman, edito a cura del Cineclub Bustese, Varese, 1964, in particolare l’introduzione e le pagg. 48-55.
[2] Cfr. Ingmar Bergman, Immagini, op. cit., p. 209.
[3] Qui l’approccio intrapreso è di rigore antropologico, con complessi riferimenti alle teorie girardiane sul legame tra la violenza e l’antico sacrificio. Cfr. Paisley Livingstone, Ingmar Bergman and the rituals of art, Cornell University Press, Ithaca and London, 1992, pp. 208-209.
[4] Ibidem.
[5] Cfr. Frederick e Lise Lone Marker, op. cit., in particolare le pagine 171-223 dedicate alle messinscene da Ibsen.
[6] Ibidem.
[7] Cito dall’articolo di Silvia Vegetti Finzi “Il travaglio delle passioni:dal teatro psichiatrico al laboratorio psicoanalitico”, cfr. Anna Panepucci (a cura di), Psicoanalisi e identità di genere. Laterza, Bari, 1995, pp. 13-38.
[8] Cfr. Olivier Assayas, Stig Björkman, Conversazione con Ingmar Bergman, Lindau, Torino, 1994, pp. 78-79.
[9] Cfr. P. Livingstone, op. cit., p. 209.
[10] Sugli esordi di Bergman nel mondo del cinema si veda Francesco Bono (a cura di), Il giovane Bergman. 1944-1951, Officina Edizioni, Roma, 1992, contenente numerosi saggi, recensioni e documenti fotografici sui primi film del regista.
[11] Sulla fase di realizzazione e produzione del film, cfr. Ingmar Bergman, Immagini, Garzanti, Milano, 1992, pp. 123-131.
[12] Sulle aperture avvolte tra doppie e triple demarcazioni dei primi film si veda Maaret Koskinen, Al di là della finzione. Alle origini dell’ estetica di Bergman, cfr. Francesco Bono (a cura di), op. cit., pp. 21-26.
[13] Secondo Koskinen la voce off conduce per mano lo spettatore dentro la finzione filmica attraverso un percorso obbligato, casella dopo casella, come succede anche nei noir francesi e americani negli anni Quaranta.Cfr. Koskinen, op. cit., p. 25.
[14] Si veda l’intervista dei critici Stig Björkman, Torsten Manns, Jonas Sima, Una conversazione con Ingmar Bergman, cfr. Francesco Bono (a cura di), op. cit., p.7.
[15] Maaret Koskinen, op. cit., p.25.
[16] Ibidem.
[17] Questo procedimento per dissolvenze ricorda le “inquadrature vaganti (vaganti come lo sguardo, come le carezze) che trova la maniera di scoprire lo spazio [e che] ha qualcosa a che vedere come con un continuo spogliarsi, uno striptease generalizzato, meno diretto ma più perfezionato”. Christian Metz, Cinema e psicanalisi, Marsilio, Venezia, 1980, p. 80.
[18] Cfr. Ingmar Bergman, Immagini, op. cit., pp. 125-129.
[19] Ibidem, p.129.
[20] Sulle affinità tra le atmosfere del flashback in Bergman e la scrittura proustiana, tutta volta a ripercorrere la fragilità del passato, cfr. Jean-Luc Godard, Bergmanorama, Cahiers du Cinéma, 85, luglio 1958.
[21] Cfr. Stig Björkman, Torsten Manns, Jonas Sima, Bergman om Bergman. Interviews with Ingmar Bergman, Da Capo Press, New York, p.163.
[22] Cfr. Ingmar Bergman, Immagini, op. cit., p.72.
[23] Sulla relazione tra lo sguardo scientifico e l’osservazione del corpo del folle come chiave per accedere ad una più approfondita conoscenza della follia cfr. Mario Galzigna, La malattia morale: alle origini della psichiatria moderna, Marsilio, Venezia, 1988, pp.121-126.
[24] Cfr. Joan Mellen, Donne e sessualità nel cinema d’oggi, La Salamandra, Milano, 1978, pp. 104-124.
[25] Sulla natura tentatrice e immanente del corpo femminile contrapposto al desiderio di evanescenza di quello maschile, simboleggiato sul finire dell’Ottocento dalla figura del dandy, cfr. il capitolo “Corpi desiderabili e corpi umiliati”, in Jean Starobinski, Ritratto dell’artista da saltimbanco, Bollati Boringhieri, Torino, 1984, pp. 81-101.
[26] Cfr. Björkman, Manns, Sima, Bergman on …. op. cit., p. 162.
[27] Cfr.Ingmar Bergman, Immagini, op.cit., p.215.
[28] Ibidem, p. 214.
[29] Il termine viene preso in prestito dal teatro di August Strindberg, ed in particolare da una serie di opere scritte nel 1907 per l’Intima Teater di Stoccolma: Temporale, Casa bruciata, Sonata di fantasmi, Il pellicano. Sul rapporto tra il regista e il drmmaturgo cfr. Frederick e Lise Lone Marker, Ingmar Bergman: tutto il teatro, Ubulibri Milano, 1996, pp. 60-133.
[30] Cfr. Ingmar Bergman, Scene di vita coniugale- Dialoghi di “Scene da un matrimonio”, Einaudi, Torino, 1974.
[31] Cfr. Mario Galzigna, op. cit., p. 92.
[32] Cfr. Frederick e Lise Lone Marker, op.cit, p.73.
[33] Cfr. Ingmar Bergman, Immagini, op.cit., p. 231.
[34] Cfr. Luisa Accati, “Quell’uomo che ha sposato mia madre: Ingmar Bergman e l’identificazione dell’artista”, in Paola Redaelli (a cura di), Lapis: incubi di pace, Manifesto Libri, Roma, 2000, pp. 75-87 e in particolare p. 84.
Filmografia
La terra del desiderio (Skepp Till Indialand) t.l.: Battello per l’India, 1947
Musica nel buio (Musik I Morker) t.l.: Musica nelle tenebre,
Città di porto (Hamnstad), 1948
Prigione (Fängelse), 1949 ; ;
Sete (Törst), 1949
Verso la gioia (Till gladje), 1950
Sant hander inte har – t.l.: Questo non accade qui, 1950
Un’estate d’amore (Sommarlek) t.l: Gioco d’estate, 1950
Donne in attesa (Kvinnors väntan), 1952
Una lezione d’amore (En lektion i kärlek), 1953
Monica e il desiderio (Sommaren med Monika) t.l.: L’estate con Monica, 1953
Una vampata d’amore (Gycklarnas afton) t.l.: La serata dei buffoni, 1953
Sogni di donna (Kvinnodröm), 1955
Sorrisi di una notte d’estate (Sommarnattens leende), 1955 ;
Il settimo sigillo (Det sjunde inseglet), 1957
Il posto delle fragole (Smult ronstället), 1957
Alle soglie della vita (Nära livet) t.l.: Vicino alla vita, 1958
Il volto (Ansiktet), 1958
L’occhio del diavolo (Djävulens öga), 1960
La fontana della vergine (Jungfrukällan), 1960
Come in uno specchio (Säsom i en spegel), 1961
Luci d’inverno (Nattvardsgästerna) t.l.: I comunicandi, 1963
Il silenzio (Tystnaden), 1963 ;
A proposito di tutte queste signore (För att inte tala om alla dessa kvinnor), 1964
Persona, 1966
Daniel (episodio del film collettivo STIMULANTIA), 1967
L’ora del lupo (Vargtimmen), 1968
La vergogna (Skammen), 1968
Passione (En passion), 1969
Il Rito (Riten), 1969
Fårodokument – t.l.: Documentario su Faro, 1971
L’adultera (Beronginen/The Touch), 1971
Scene da un matrimonio (Scene ur ett äktenskap), 1973
Sussurri e grida (Viskiningar och rop), 1973
Il flauto magico (Troll flöjten), 1975
L’immagine allo specchio (Ansikte mot ansikte) t.l.: Faccia a faccia, 1976
L’uovo del serpente (Das Schlangenei/The Serpent’s Egg/ Ormens ågg), 1977
Sinfonia d’autunno (Herbstsonate/Höstsonaten), 1978
Fårodokument 1979 – t.l.: Documentario su Fåro 1979, 1979
Un mondo di marionette (Aus der Leben der Marionetten/Ur Marionetternas Liv) t.l.: Dalla vita delle marionette, 1980
Fanny e Alexander (Fanny och Alexander), 1982
Hustruskolan – t.l.: La scuola delle mogli, 1983
Dopo la prova (Efter repetitionen), 1984
Documentario su Fanny e Alexander (Dokument Fanny och Alexander), 1986
Il volto di Karin (Karins Ansikte), 1986
Il segno (De två saliga) t.l.: I due beati, 1986
Marchese de Sade (Markisinnan De Sade), 1992
Le Baccanti (Backanterna), 1993
L’ultimo grido (Sista Skriket), 1995
Harald & harald, 1995
Vanità e affanni (Larmar och gör sig till), 1997
Bildmakarna – t.l.: I creatori di immagini, 2000
Sarabanda (Saraband), 2004












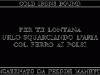
























Commenti
Non ci sono ancora commenti