 La poesia in dialetto triestino, che trova la sua massima espressione in Virgilio Giotti, ha conosciuto negli anni Sessanta, Settanta e Ottanta del Novecento un boom. Tuttavia negli ultimi quindici anni questa tendenza quantitativamente importante pare essersi arrestata. Perché? Le ragioni di questo crollo potrebbero essere ricercate nella matrice stessa della poesia triestina: autobiografica, memorialistica, poco aperta alle sperimentazioni e alle trasformazioni dell’immaginario contemporaneo. Topoi del genere, trattati con originalità e stili peculiari dagli autori più solidi della tradizione giuliana in dialetto (Giotti, Pittoni, Sambo, Malabotta, Cergoly, Fölkel, Carpinteri & Faraguna, Pierri, Doplicher, Grisancich e altri), non hanno attecchito nelle generazioni di poeti più giovani (nati negli anni Sessanta e Settanta), più interessati a confrontarsi con esperienze nazionali e straniere, anche per timore di scivolare nella retorica del campanilismo o della difesa ad oltranza di un’identità troppo poco granitica per essere difesa.
La poesia in dialetto triestino, che trova la sua massima espressione in Virgilio Giotti, ha conosciuto negli anni Sessanta, Settanta e Ottanta del Novecento un boom. Tuttavia negli ultimi quindici anni questa tendenza quantitativamente importante pare essersi arrestata. Perché? Le ragioni di questo crollo potrebbero essere ricercate nella matrice stessa della poesia triestina: autobiografica, memorialistica, poco aperta alle sperimentazioni e alle trasformazioni dell’immaginario contemporaneo. Topoi del genere, trattati con originalità e stili peculiari dagli autori più solidi della tradizione giuliana in dialetto (Giotti, Pittoni, Sambo, Malabotta, Cergoly, Fölkel, Carpinteri & Faraguna, Pierri, Doplicher, Grisancich e altri), non hanno attecchito nelle generazioni di poeti più giovani (nati negli anni Sessanta e Settanta), più interessati a confrontarsi con esperienze nazionali e straniere, anche per timore di scivolare nella retorica del campanilismo o della difesa ad oltranza di un’identità troppo poco granitica per essere difesa.
Vorrei ripartire dalla considerazioni che chiudono l’introduzione di Roberto Damiani e Claudio Grisancich all’ultimo volume (dotato di ampio apparato antologico) dedicato alla poesia triestina in dialetto: «Dal 1976 a oggi [1989] per la poesia triestina è stata una stagione d’oro. I libri editi sono saliti al numero di 56, con la media stupefacente di 4 titoli all’anno e con ben 24 esordienti su 32 operatori attivi (1.7 esordienti per anno, con una punta di 6 esordienti nel 1980) […] Dal 1965 al 1989 non è trascorso un solo anno senza che venisse edito almeno un libro di poesia vernacola […]. Osimo ha avuto la sua parte, in questa impennata: che il quadriennio 1977/1980 sia nel novero delle sei annate più generose di pubblicazioni è eloquente circa il rapporto tra le fortune della poesia vernacola e la mobilitazione cittadina contro la minacciata industrializzazione del Carso e per l’autonomia di Trieste. […] È forse casuale che al declino della protesta abbia corrisposto il ridimensionamento del boom?»[1].
Col senno di poi dovremmo modificare i termini della questione: non si tratta di “ridimensionamento” bensì di un arretramento talmente consistente da mettere in serio dubbio la persistenza della musa vernacola e di quella in dialetto. Come emerso in Trieste allo specchio [2], sia nell’appendice bibliografica (più di 350 poeti triestini, in lingua e/o dialetto, dal 1950 al 2002) che nella disamina critica, le ultime generazioni di poeti locali prediligono l’italiano e i riferimenti culturali d’Oltralpe o d’Oltreoceano a scapito di quelli mitteleuropei. Anche ad un rapido scandaglio, ci si accorgerebbe che, negli autori nati a partire dagli anni Sessanta, nessuno ha coltivato la scrittura in dialetto. Ecco l’elenco dei “giovani” triestini (per nascita) editi in ordine alfabetico: Velvet Afri, Michele Alessio, Giuliano Antonione, Manuel Fanni Canelles, Paolo Carboni, Mauro Caselli, Paola Colle, Matteo Danieli, Lisa Deiuri, Luciano Dobrilovic, Gianfranco Franchi, Igor Gherdol, Gaetano Longo, Cristiano Mautarelli, Fabrizio Maurel, Luigi Nacci, Massimo Palme, Deni Pasini, Christian Sinicco, Davide Vetta (dei 21 citati, 9 hanno fatte parte del gruppo “Gli Ammutinati”: Afri, Alessio, Antonione, Canelles, Danieli, Dobrilovic, Nacci, Palme, Sinicco)[3].
 Questo desolante scenario coinvolge non solo le ultime generazioni[4], come emerge dall’analisi dei dati fuoriusciti dal questionario di Trieste allo specchio [5]: alla domanda “in quale lingua predilige scrivere (italiano, dialetto triestino, altra lingua o dialetto) e perché? Solitamente, nella conversazione quotidiana, utilizza la lingua o il dialetto?” L’italiano raccoglie il 60% dei consensi nello scritto e il 40% nella conversazione quotidiana, mentre il dialetto si attesta al 22% nello scritto e il 27% nel contesto orale, stessa percentuale della categoria d’uso lingua-dialetto.
Questo desolante scenario coinvolge non solo le ultime generazioni[4], come emerge dall’analisi dei dati fuoriusciti dal questionario di Trieste allo specchio [5]: alla domanda “in quale lingua predilige scrivere (italiano, dialetto triestino, altra lingua o dialetto) e perché? Solitamente, nella conversazione quotidiana, utilizza la lingua o il dialetto?” L’italiano raccoglie il 60% dei consensi nello scritto e il 40% nella conversazione quotidiana, mentre il dialetto si attesta al 22% nello scritto e il 27% nel contesto orale, stessa percentuale della categoria d’uso lingua-dialetto.
Pur asserendo, insieme a Maria Corti, che il poeta crea un dialetto il quale non ha niente a che fare con quello effettivamente parlato[6], ciò nonostante bisogna fare i conti con l’amara realtà: l’italiano domina, e Trieste non sembra più essere «la città italiana dove l’uso del dialetto quale strumento di comunicazione quotidiana è rimasto più radicato»[7].
Quali sono, poeti giuliani, le motivazioni che conducono alla scelta del mezzo espressivo? Per quanto riguarda la decisione di scrivere in dialetto le motivazioni addotte nel questionario si contano sulle dita delle mani, come se rappresentasse un ostacolo scavare dentro di sé per scoprire le proprie ragioni: c’è chi lo fa perché ha acquisito un bagaglio di conoscenze tecniche e le vuole praticare, pur non essendo nativo di queste parti (Roverelli Cargnelli: in italiano i racconti, le poesie anche in dialetto triestino che ho studiato e approfondito col prof. Mario Doria. In casa parlo in lingua perché sono nata a Firenze); chi per la densità del suo lessico (Pirona: scrivo in dialetto triestino per la particolare pregnanza del suo vocabolario); chi tira in ballo l’ispirazione (Bortolotti: scrivo in entrambe, dipende dall’ispirazione; è come se fossero due lingue diverse, due modi di pensare); chi passa per inseguire “la verità che giace al fondo” (Buttiro Bison: in dialetto sono più sincera), chi, infine, lo sente come indispensabile ai fini della propria poetica (Caselli: è la mia lingua materna e il bisogno di aderenza al reale esige un’espressione poetica con questa lingua. Scrivo però anche in lingua).
La scelta dell’italiano come lingua dei versi è spesso legata all’adesione alla tradizione letteraria nazionale (Apih: è lingua della mia cultura; Brusadelli: per l’influenza della letteratura studiata; Zovatto: perché dalle elementari al liceo ho mandato a memoria i migliori “sonetti” della nostra tradizione letteraria, a cominciare da interi capitoli della Divina Commedia; Danieli: in italiano, per abitudine al confronto con la letteratura italiana; Bolaffio: perché ho fatto studi classici); o come unica possibilità, visto il disamore per il dialetto (R. L. Cargnelli: mi adatto agli altri, per cui anche in dialetto, ma non amo i dialetti; Pierri: non amo il dialetto, anche se a volte lo uso per scrivere e per parlare; Cechet: scrivo e parlo in italiano. Non mi piacciono i dialetti; soprattutto non mi piace il dialetto a Trieste, perché qui sembra che nessuno sappia parlare altro. Mi piace, invece, il dialetto in Goldoni, perché è parte del contenuto); o per non escludere alcuna fetta di pubblico (Claut: per non precludermi lettori); o per ragioni intime, esistenziali (Torossi Tevini: scrivo, penso, sogno in italiano; Vitello Damato: ci trovo l’essenza del mio essere).

Un ulteriore elemento di valutazione proviene dalla divisione per genere: il dialetto viene praticato in poesia più dal campione maschile che da quello femminile. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Pizzi, ovvero che le poetesse triestine hanno preferito il dialetto all’italiano[8], le 44 poetesse da noi intervistate hanno dimostrato una più marcata propensione per la lingua: sul totale delle risposte l’italiano supera il 66%, il dialetto triestino il 20% (alternandolo all’italiano, mentre solo Borghi Mestroni ha dichiarato di usare unicamente il dialetto per la poesia), altre lingue e/o dialetti un risicato 14%. Dunque, la maggioranza delle nostre poetesse sembra voler affrontare “di petto” la tradizione maggiore, senza farsi relegare, né autorelegarsi in una condizione di marginalità.
Nessuno dei nostri pare avere la lucida consapevolezza di uno Scataglini, laddove, rispondendo nel 1988 ad un questionario di “Diverse Lingue”, confessava che, al di là di ragioni di carattere musicale e letterario, l’assunzione del dialetto era connessa all’identificazione della sua «vicenda di intellettuale solitario ed isolato con quella degli uomini che vengono posti al margine della storia: gli esclusi, quelli che sono deprivati degli strumenti in cui il potere si manifesta: la lingua (incommensurabile per chi la guarda dal suo povero idioma di subalterno) e la cogenza dell’uso della forza quando viene irreparabilmente patita. La lingua dei servi, dunque: lingua dell’affettività domestica e del rassegnato abbandono al corso delle cose. Oppure lingua dell’oscenità e della bestemmia quando la rabbia può sollevare solo un empio brandello di bandiera contro la soggezione sociale diventata destino»[9].
Il fatto che non vi siano, da parte di chi sceglie di scrivere in dialetto, rivendicazioni di carattere politico o ideologico, non deve stupire se, sempre dallo stesso questionario, è emersa l’immagine del poeta triestino rinchiuso in una «bolla di vetro»: alle domande “c’è un particolare evento della storia cittadina degli ultimi cinquant’anni che l’ha colpita talmente al punto da dare una svolta alla sua poetica? E parimenti un fatto storico non triestino?” e “l’ideologia ha pesato, o ancora pesa, sulla sua produzione poetica?”, circa il 70% ha dichiarato di non esser stato influenzato o colpito da nessun evento storico né dall’ideologia. E in effetti, stringendo l’inquadratura alla produzione in dialetto (ma le tesi si potrebbero estendere anche alla produzione in lingua)[10], in linea con quanto sostenuto da Brevini, e cioè che nel ’900 la poesia in dialetto «passa dal piano della realtà a quello dell’io e, prevalentemente, della memoria» e che successivamente, con l’irrompere sulle scena dell’esperienza neodialettale, «il quadro retorico resta sostanzialmente quello lirico-soggettivistico»[11], la poesia triestina in dialetto è, nelle sue prove più solide, poesia autobiografica e memorialistica, molto lontana dall’afflato “rivoluzionario” di Scataglini o dalle acrobazie plurilinguistiche del Calzavara di e [12].
 Sto pensando agli autori più maturi del Novecento triestino (senza arrischiarmi in classifiche impossibili, do l’elenco in ordine di nascita): Virgilio Giotti (1885-1957), Anita Pittoni (1901-1982), Guido Sambo (1905-1968), Manlio Malabotta (1907-1975), Carolus Cergoly (1908-1987), Ferruccio Fölkel (1921-2002), Lino Carpinteri (1924) & Mariano Faraguna (1924-2001), Ugo Pierri (1937), Fabio Doplicher (1938-2003), Claudio Grisancich (1939)[13].
Sto pensando agli autori più maturi del Novecento triestino (senza arrischiarmi in classifiche impossibili, do l’elenco in ordine di nascita): Virgilio Giotti (1885-1957), Anita Pittoni (1901-1982), Guido Sambo (1905-1968), Manlio Malabotta (1907-1975), Carolus Cergoly (1908-1987), Ferruccio Fölkel (1921-2002), Lino Carpinteri (1924) & Mariano Faraguna (1924-2001), Ugo Pierri (1937), Fabio Doplicher (1938-2003), Claudio Grisancich (1939)[13].
In tutti loro — tranne che in Pierri, e spiegherò il perché — la celebrazione/solennizzazione del proprio universo passato ha sormontato sia un’ipotesi di rinnovamento civile (Porta), sia un sentimento di solidarietà con il popolo emarginato (Belli); il grande assente cioè della poesia in dialetto triestino è il presente. Se poi mi venisse rimproverata la mancanza di autori come Giglio Padovan e Giulio Piazza, sgombrerei il campo da dubbi e titubanze appoggiandomi a Pasolini: «Dallo Steinbach, al Venezian, al Torrespini, e ai meno peggio Piazza e Padovan, le letteratura vernacola triestina non solo non offre nulla di notevole, ma non si è neanche organizzata in una sia pur fioca tradizione. Comincia, insomma, tout court, con Giotti»[14].
Giotti, per essere definito da Contini come «forse il primo dialettale in cui il dialetto non abbia nulla di veramente vernacolo»[15], deve operare una cesura netta con la città e la sua (controversa, difficile) storia: il suo anti-dialetto (Pasolini) e la suo aristocratico stare in disparte (Quarantotti Gambini diceva che fosse «intrattabile» nei salotti)[16], vanno naturalmente nella direzione di un mondo rarefatto. Tuttavia egli non punta alla fuga dal quotidiano, bensì ad una sua “assolutizzazione”, mediante una depurazione (di mondo creato per sottrazione parla Damiani)[17] da una parte di qualsivoglia topologia di riferimento, dall’altra — per dirla con Mario Doria — di qualsivoglia eccesso, al fine di originare un dialetto «stringato, essenziale e coerente con se stesso […]; popolareggiante, in cui si rileva certamente qualche volgarismo (drento, sintir, povaro), ma anche cert’aria di pulizia, di ordine»[18] (Magris parla proprio di potenziamento dei significanti del dialetto a fini lirici contro il linguaggio quotidiano[19]).
I personaggi e le cose della sua poesia — come ha ben colto Mauro Caselli in un acuto e per certi versi illuminante saggio — «si intrattengono allora in quel “non-luogo” eletto che è la “erta” di casa, in riti di accoglienza, di saluto, che la sottolineatura dell’incorniciamento rende solenni […]. Giotti constata che ogni attraversamento è impossibile; si è sempre soggetto, si è sempre soli e il distacco, il non essere pienamente addentro all’io, al mondo, che inizialmente segnalava una zona franca, elettiva ed auspicabile, si fa posizione obbligata»[20]. Ovvio quindi che, istituendo la “distanza” dalle cose come misura principe dello scrivere, l’autore non possa essere invischiato nelle maglie strette del contingente: come ha spiegato in uno dei suoi Appunti inutili (6 agosto 1947), osservando da uno spiraglio delle fronde, non gli interessa sapere il loro nome, così come nelle guerre, le distruzioni, i soprusi dell’uomo non vede che monotonia.
La prima della schiera dei post-Giotti è anagraficamente Anita Pittoni. A parte l’esigua quantità con cui confrontarsi (Fèrmite con mi [21] e, al limite, la prosa lirica El passèto [22]), basterebbero le parole di Damiani&Grisancich per inquadrarla: «un es compiaciuto di una femminilità fragile, pronto a commuoversi intensamente e a vivere la vita con morbido fatalismo, amante dei chiaroscuri e della penombra, delle parole sussurrate e dei sentimenti inespressi, nostalgico dell’infanzia e gentilmente egocentrico»[23].. D’altronde è la stessa Pittoni a raccontare che la trentina di liriche di Fèrmite con mi sono state pubblicate «come terapia voluta dai medici»[24] per risollevarsi dalla depressione che la attanagliava da diverso tempo; volontà confermata anche dal titolo delle sezioni che compongono il volumetto: “Mi e i mii”, “Le amorose”, “Noi de Trieste de tuto el mondo”, nonché la celebre poesia finale, El strighez, in cui si canta l’impossibilità di tagliare il cordone ombelicale che lega a Trieste.
La scrittura in dialetto di Guido Sambo è avvinta alla sua condizione bohemien -post-crepuscolare, al suo andar ostariando — come recita il titolo della poesia che chiude Òmini e contrade [25] — nella zona del Borgo Teresiano accanto alla Stazione che ha preso il nome, in virtù delle sue quotidiane frequentazioni in compagnia dell’amico Dino Dardi, di “Samberia”. Nonostante l’affetto dovuto al personaggio, a risentire oggi la lapidaria consacrazione datata 1961 per penna di Fabio Todeschini («dei poeti che ancora oggi scrivono “in triestino” noi non sapremmo indicare altri oltre a Sambo»)[26] si rimarrebbe probabilmente perplessi; c’è però da aggiungere che in quell’anno, in quegli anni, ancora non si erano rivelati i versi triestini di Claudio Grisancich, che avrebbe esordito giovanissimo cinque anni più tardi; né di Cergoly, che sarebbe tornato in auge appena negli anni Settanta; né di Malabotta, che aveva sì già stampato un libricino[27], ma avrebbe raggiunto una certa visibilità solamente nel 1968 grazie alla pubblicazione scheiwilleriana[28]; né di Carpinteri&Faraguna, i quali avevano stampato nel 1954 L’opera omnia di Druse Mirko [29], ma ben dieci anni mancavano all’uscita della loro prova più importante in versi, Serbidiòla [30], anch’essa edita da Scheiwiller con in esergo una poesia inedita di Eugenio Montale; alla luce di ciò, di questo “vuoto”, Todeschini in quell’introduzione del 1961 fa, come unica eccezione degna di nota dopo Sambo, il nome di Anita Pittoni, in attesa di far uscire quel Fèrmite con mi che Todeschini aveva evidentemente avuto modo di leggere in anteprima.
Più originale, sebbene anch’esso personalissimo a in definitiva autobiografico, il percorso di Malabotta, che è visibile nella sua completezza nel volume uscito postumo per Scheiwiller con la prefazione di Vittorio Sereni[31]. Il tratto più rilevante del suo scrivere è l’icasticità e il guizzo aforistico che sfociano nell’epigramma, i temi ricorrenti «il gioco, la giovinezza appena passata, la nostalgia delle donne amate, ritrovate in un lampo della memoria». Una poesia «specchio di un’intima fedeltà ai più brevi incontri, alle passioni appena sfiorate»[32], intrisa, come quelle dei suoi colleghi giuliani, da una certa “aria di famiglia”: «Ieri / ghe ga tocado / a Paolo. / E ‘desso? / A mi? / A Livio? / A Stelio? A Vani? A Emilio? A ti? »[33].
 Ancora più isolata della precedente la poesia di Carolus L. Cergoly, un poeta — nella definizione che ne diede Pasolini — «tremendamente aristocratico: appartato, geloso della propria solitudine, bizzarro, praticamente teso solo a sfuggire a qualsiasi definizione. Il centro del mondo è lui. E il suo mondo non è Trieste»[34]. A mettere sui due piatti della bilancia le valutazioni di Giudici e di Damiani, la sfida si risolverebbe di certo a favore del secondo, il quale sottolinea come Cergoly si sia costretto ad amare il mito di Trieste, un mito « privato, tutto suo, libresco inaudito e inaudibile da chi vive nella storia»[35], mentre dall’altra parte Giudici scrive che «i “grandi temi” dell’amore, della società e della storia, trovano in Cergoly […] un riscontro niente affatto generico o retorico, ma tutto concretezza, tutto nomi e cognomi»[36]. La sua poesia celebra come in una scoppiettante festa, la fastosità, la tragicomicità e la decadenza di un mondo che non esiste, fantomatico e fantasmagorico, parto di una fervida e fantasiosa immaginazione, e se non si può parlare, come dice Brevini, di fuga in «mondo minore, chiuso, come di solito nei dialettali» ma in un «prestigioso e snobistico universo internazionale»[37], alla fine comunque di fuga si tratta, di ripiegamento nostalgico screziato di venature malinconiche.
Ancora più isolata della precedente la poesia di Carolus L. Cergoly, un poeta — nella definizione che ne diede Pasolini — «tremendamente aristocratico: appartato, geloso della propria solitudine, bizzarro, praticamente teso solo a sfuggire a qualsiasi definizione. Il centro del mondo è lui. E il suo mondo non è Trieste»[34]. A mettere sui due piatti della bilancia le valutazioni di Giudici e di Damiani, la sfida si risolverebbe di certo a favore del secondo, il quale sottolinea come Cergoly si sia costretto ad amare il mito di Trieste, un mito « privato, tutto suo, libresco inaudito e inaudibile da chi vive nella storia»[35], mentre dall’altra parte Giudici scrive che «i “grandi temi” dell’amore, della società e della storia, trovano in Cergoly […] un riscontro niente affatto generico o retorico, ma tutto concretezza, tutto nomi e cognomi»[36]. La sua poesia celebra come in una scoppiettante festa, la fastosità, la tragicomicità e la decadenza di un mondo che non esiste, fantomatico e fantasmagorico, parto di una fervida e fantasiosa immaginazione, e se non si può parlare, come dice Brevini, di fuga in «mondo minore, chiuso, come di solito nei dialettali» ma in un «prestigioso e snobistico universo internazionale»[37], alla fine comunque di fuga si tratta, di ripiegamento nostalgico screziato di venature malinconiche.
Nostalgico al quadrato è Ferruccio Fölkel, che ha esordito molto tardi, a 57 anni, con un volumetto di versi, Monàde. 33 poesie del Giudeo, edito da Guanda e ristampato 24 anni dopo, nel 2002, dal Ramo d’Oro. A palesare questo incedere “da gambero” è fin dall’inizio il nome usato per firmarsi, Fery, che gli consente di tornare con la memoria agli anni dell’infanzia, quando una bambina ungherese di nome Olga lo chiamava “Ferykám”, ovvero “mio caro Fery”; oppure l’incipit della silloge: «una chiave di lettura di questa raccolta è una foto di famiglia con dedica autografata scritta in gotico tedesco da mio bisnonno paterno Samuel Funkelstein»[38]. Come in Cergoly il pastiche è personalissimo: ma se nel primo ci si trova d’innanzi ad un “lessico mitteleuropeo” asservito all’impalcatura che deve sostenere un universo costruito a tavolino, in Fölkel l’alternanza dei tasselli che formano il mosaico finale della sua lingua (italiano, triestino, ebraico, inglese e tedesco) è regolata dai suoi umori intrecciati al ritmo scostante del rimembrare. Inversamente a Cergoly, che traduce l’intimità delle proprie fantasie e dei propri ricordi in mito pubblico e magnificente della Mitteleuropa, per Fölkel, come ha rilevato Dedenaro, «la Mitteleuropa esce così dal mito e diventa un percorso familiare, una storia di affetti e radici»[39] in cui si erge imponente la figura del padre, senza però che vi sia rimpianto acritico per un tempo oramai andato.

Lino Carpinteri e Mariano Faraguna si sono segnalati giovanissimi alla città redigendo “La Cittadella”, il supplemento del lunedì al quotidiano “Il Piccolo”. La premiata ditta di giornalisti-scrittori-drammaturghi confeziona in versi due “saghe”: la prima è quella di Mirko Drek, poi autocensurato in Druse Mirko (la cui nascita è rivendicata da sette borghi del Carso così come quella di Omero lo era da sette città della Grecia) , riconducibile al filone della “satira del villano” e in seguito sconfessata dalla coppia, perché frutto di una visione di ideologie contrapposte oramai sorpassata; la seconda “saga” invece è quella del Noneto, un «folletto aristocratico, deliziosamente svanito, che narra storie di passati remoti, seduto ogni volta su tombe diverse»[40], che intona sempre il canto a partire da un verso divenuto a Trieste popolarissimo: co’ ierimo putei. Il volume esce con il titolo di Serbidiòla, che rimanda, in una comica storpiatura antiasburgica, a “Serbi Dio l’Austriaco Regno”, primo verso della canzone che gli studenti delle scuole italiane dell’Impero Austro-Ungarico dovevano mandare giù a memoria. Anche qui, dunque, la disposizione è tutta all’indietro, ad una rievocazione che — accadrà anche, forse di più, nella loro fase successiva in prosa, quella delle Maldobrie — mescola dati reali ad un numero sempre maggiore di suggestioni favolose, fiabesche, mitiche, al punto da far dire (azzardando) a Stelio Crise che «Carpinteri e Faraguna, totalmente calati in quel mondo, non lo rappresentano né vecchio, né nostalgico, né querulo, ma come un aspetto, forse non solo triestino, dell’aggrovigliata inconsapevolezza del primitivo»[41].
 Come ho già avuto modo di dire[42], sarebbe a mio modesto modo di vedere errato concentrare troppe attenzioni sulla svolta in dialetto di Fabio Doplicher. Egli stesso evidenzia che per lui il dialetto è «lingua della memoria» praticata per molti anni in segreto, il triestino «stretto» della sua vecchia nonna che negli anni Quaranta lo «coccolava da bambino»[43]. L’interazione — nella sua produzione in lingua — «tra ricordi privati (e per questo stralunati nel procedimento associativo-onirico) e ricordi collettivi (le frequenti rivisitazioni della guerra e del paesaggio carsico, talora anch’esso ancipite nelle sue fioriture stagionali e nel suo essere serbatoio di reperti storici»[44] si trasforma, con lo scivolamento nel dialetto, in monologo in cui centrale si fa la vicenda personale, a scapito del suo metamorfico attraversamento della storia. Già ne Il girochiuso [45], il suo esordio in versi, la “schizofrenia”, con la prima parte dominata dalla poematicità (racconti in versi e poemetti che, come auto-commenta Doplicher, «spaziavano su un mondo urbano che con i suoi ritmi di lavoro e con i rapporti umani che instaurava aveva messo in crisi modi di vivere e abitudini»[46]) a cui fa seguito una seconda parte lirica, proprio perché il locus non è più l’ambiente industriale del Nord o Roma, ma Trieste e il Carso: è Doplicher a dire che per lui Trieste è mare/Carso/acqua salata/vento dei pini[47] – e difatti l’incipit del primo testo, intitolato Un ricordo, è La bora alla Pescheria risucchia sul molo.
Come ho già avuto modo di dire[42], sarebbe a mio modesto modo di vedere errato concentrare troppe attenzioni sulla svolta in dialetto di Fabio Doplicher. Egli stesso evidenzia che per lui il dialetto è «lingua della memoria» praticata per molti anni in segreto, il triestino «stretto» della sua vecchia nonna che negli anni Quaranta lo «coccolava da bambino»[43]. L’interazione — nella sua produzione in lingua — «tra ricordi privati (e per questo stralunati nel procedimento associativo-onirico) e ricordi collettivi (le frequenti rivisitazioni della guerra e del paesaggio carsico, talora anch’esso ancipite nelle sue fioriture stagionali e nel suo essere serbatoio di reperti storici»[44] si trasforma, con lo scivolamento nel dialetto, in monologo in cui centrale si fa la vicenda personale, a scapito del suo metamorfico attraversamento della storia. Già ne Il girochiuso [45], il suo esordio in versi, la “schizofrenia”, con la prima parte dominata dalla poematicità (racconti in versi e poemetti che, come auto-commenta Doplicher, «spaziavano su un mondo urbano che con i suoi ritmi di lavoro e con i rapporti umani che instaurava aveva messo in crisi modi di vivere e abitudini»[46]) a cui fa seguito una seconda parte lirica, proprio perché il locus non è più l’ambiente industriale del Nord o Roma, ma Trieste e il Carso: è Doplicher a dire che per lui Trieste è mare/Carso/acqua salata/vento dei pini[47] – e difatti l’incipit del primo testo, intitolato Un ricordo, è La bora alla Pescheria risucchia sul molo.
È una distinzione netta, tra due mondi — messo in luce anche Caproni[48]: a ciascuno di questi due mondi corrisponde un mezzo linguistico. Quello che però mi preme sottolineare qui è che anche un autore importante, sia quantitativamente che qualitativamente (credo l’autore più complesso e completo nel panorama della letteratura triestina del secondo Novecento) come Doplicher, così straordinariamente immerso nel suo tempo e capace di analizzare l’ambiente della poesia («la metamorfosi dei tempi richiede una poesia della metamorfosi», recita un suo slogan)[49] e allo stesso tempo di premonire molti aspetti dello scenario globale che si sarebbero mostrati solo anni dopo, abbia invece in dialetto optato per un ripiegamento nella memoria, mentre avrebbe potuto, chissà con quali esiti, provare a gettare Trieste e il suo dialetto nella centrifuga della contemporaneità.
Colui che ha con più consapevolezza — consapevolezza, dice Brevini, conquistata pienamente solo negli anni Ottanta[50] — forgiato un proprio dialetto e lo ha fatto con più costanza, seppur non accompagnato da prolificità, è Claudio Grisancich. Dopo essere stato accolto giovanissimo (a 14 anni) nel salotto di Anita Pittoni, e sotto la “protezione” sua e di Giani Stuparich, esordisce nel 1966 con Noi vegnaremo [51], volume che riunisce 98 poesie scritte tra gli 11 e i 25 anni ordinate e introdotte dalla stessa Pittoni. Un poeta precoce, dunque, che dopo la sua seconda prova, Dona de pugnai [52], in piena fioritura della stagione neo-dialettale (il 1972 è l’anno in cui escono I canti clandestini di Cergoly, I bu di Guerra, Cronache e paràbbule di De Donno, La piccola valle di Alì di Battaglia, La notti longa di Calì, La plòe ta pinède di De Gironcoli; sono gli anni degli esordi di Loi, Giacomini, Baldini, Scataglini), ha subito un arresto, quasi un’interruzione definitiva: 17 anni di silenzio (rifiuto del dialetto testimoniato anche dalla scelta temporanea dell’italiano sia per la poesia che per i racconti) dovranno difatti passare prima che la crisi sfoci in una nuova fase, quella delle crature.
A differenza di Giotti, della sua ricerca di assolutezza lirica, Grisancich muove in direzione di un «vivace diarismo, che impone l’autenticità di ambientazioni e dati quasi con il vincolo di un “patto autobiografico”»[53], ed è esattamente il piano autobiografico ad essere intaccato dall’esperienza coeva dei suoi colleghi, dalla problematicità sollevata da autori come Noventa, Scataglini, Calzavara, Zanzotto (dialettale), solo per fare alcuni esempi. La strada imboccata dal 1989 ad oggi continua quel processo di radicalizzazione dell’interiorizzazione di cui parlava Damiani[54] — nell’ultima raccolta, che sempre per restare nella dimensione della biografia di sé, si intitola Inventario (2004) vi è un approfondimento del lavoro sulla forma, più tesa, contratta, indurita[55], con cesure forti che spezzano il ritmo, come se il suo dialetto fosse lì e lì per divenire balbuzie.
 Diversa dalle strade appena illustrate è quella di Ugo Pierri, che ha esordito tardissimo, nel 1996, all’età di 59 anni, proprio con un libro in dialetto intitolato Aiku lokali, a cui sono seguite altre prove in lingua prima di cimentarsi nuovamente in triestino nel volume scritto a quattro mani con Paolo Speri (entrambi sotto psuedonimo: Pierri/Van Poppel e Speri/Taf), triestino “esule” a Milano da molti anni. In Doplicher a ciascun mezzo linguistico è assegnato un immaginario, in Pierri no: in lingua o in dialetto il suo campo da gioco resta quello della satira.È appunto il rifarsi al filone “portiano” (appesantito dal piglio intransigente di un Persio o di un Giovenale) della poesia in dialetto che lo differenzia dai suoi colleghi: fustiga vizi, costumi, miti e maschere della Trieste novecentesca, città non idealizzata bensì «necropolis», cità de jazo», «covo de ladri», didi «mercanti e putane», «veci biliosi», «liberi kofe» (matti), «borgo de merda», «osmiza felix», «cità malada / de melonite acuta / e peste nera» (il Melone è stato il simbolo della Lista per Trieste, movimento per l’autonomia locale), «cità de merda / omini incartozzai / veci ranzidi», «’na tana de faine / rubagaline»[56].
Diversa dalle strade appena illustrate è quella di Ugo Pierri, che ha esordito tardissimo, nel 1996, all’età di 59 anni, proprio con un libro in dialetto intitolato Aiku lokali, a cui sono seguite altre prove in lingua prima di cimentarsi nuovamente in triestino nel volume scritto a quattro mani con Paolo Speri (entrambi sotto psuedonimo: Pierri/Van Poppel e Speri/Taf), triestino “esule” a Milano da molti anni. In Doplicher a ciascun mezzo linguistico è assegnato un immaginario, in Pierri no: in lingua o in dialetto il suo campo da gioco resta quello della satira.È appunto il rifarsi al filone “portiano” (appesantito dal piglio intransigente di un Persio o di un Giovenale) della poesia in dialetto che lo differenzia dai suoi colleghi: fustiga vizi, costumi, miti e maschere della Trieste novecentesca, città non idealizzata bensì «necropolis», cità de jazo», «covo de ladri», didi «mercanti e putane», «veci biliosi», «liberi kofe» (matti), «borgo de merda», «osmiza felix», «cità malada / de melonite acuta / e peste nera» (il Melone è stato il simbolo della Lista per Trieste, movimento per l’autonomia locale), «cità de merda / omini incartozzai / veci ranzidi», «’na tana de faine / rubagaline»[56].
Come si evince dalle manciate di versi riportati, ci si imbatte in una varietà dialettale molto aspra, gravida di volgarismi, che, seguendo lo schema proposto da Doria[57], potrebbe avvicinarsi alle tinte forti — perlomeno relativamente alle formule lessicali[58] — del “negron”, una versione triviale del dialetto triestino, diffusasi originariamente nella zona periferica del quartiere di S. Giacomo (la “Galauca”), che ha il suo primo antenato scritto nel Veglione Ultra Popolare [59] (1891) di Giulio Piazza e si propaga poi attraverso la rubrica “Gigi Lipizzer” (scaricatore portuale) sul periodico umoristico “Marameo” e le maciete di Angelo Cecchelin. Il negron, in tutte le sue possibili varianti e i suoi aggiornamenti, non ha però trovato nei poeti suoi degni difensori (a parte Pierri, emerge sporadicamente solo in Grisancich e Malabotta e, nei nostri giorni, Targestopoli, raccolta inedita del poeta triestino-magiaro Lajos Undor, costituita da una cinquantina di testi apparsi disordinatamente sul foglio satirico “Ossezia” dal 2002 al 2005)[60], e ciò non stupisce, dal momento che la poesia in dialetto triestino, come affiorato da questa rapida carrellata, è tendenzialmente lirica, auto-biografica, “passatista”, quasi per niente incline alle sperimentazioni della stagione neo-dialettale.
Sempre più simile ad un naufrago abbarbicato ad un iceberg che si assottiglia al punto di diventare un cubetto di ghiaccio (per citare l’immagine coniata da Villalta)[61], il poeta dialettale si interroga sul senso della propria battaglia. Le strade che si prospettano — come scrive Vincenzo Bagnoli — sono tre: «da un lato sta il vitalismo “magmatico” della lingua pre-logica; da un altro il ridursi a esercizio puramente antiquario dal sapore consolatorio; in ultimo la possibilità di ricollocarsi all’interno di un discorso pubblico, ossia aperto»[62].
A differenza del vicino Friuli, che ha inaugurato negli ultimi anni una politica protezionistica poderosa a tutti i livelli, dalla scuola ai mezzi di comunicazione, al teatro e alla musica, Trieste — fermo restando la non comparabilità di friulano e triestino — non ha fatto e non sta facendo altrettanto: in città e provincia quasi solo le compagnie teatrali amatoriali in dialetto triestino, tra cui spicca l’associazione “L’Armonia”, perseverano nell’opera di salvaguardia (un triestino però “annacquato”, in linea con i tempi), mentre nella narrativa e in poesia il paesaggio è desolante. Eppure a non molti chilometri dei giovani che coltivino i propri dialetti ci sono: Ivan Crico, Pierluigi Cappello, Flavio Santi, i componenti del “collettivo” poetico “Trastolons” (nato nel 1996 e composto da Maurizio Mattiuzza, Raffaele B. B. Lazzara, Guido Carrara, Fabian Riz, Lussia Duanis, Stefano Moratto e Paolo Cantarutti).
Perché a Trieste ciò non accade? La poesia in dialetto triestino, anche nelle sue vette, è stata prodotta da autori isolati, originalissimi ma disinteressati ad un progetto di comunità linguistica da difendere, come invece è accaduto in Friuli; d’altronde il triestino è un dialetto giovane sorto per ragioni commerciali, per “editto”, non dalla terra, e quelle ragioni economiche che ne hanno guidato la formazione oramai non esistono più. Andrebbe tuttavia visto anche il rovescio della medaglia: alla graniticità terrestre dell’identità friulana fa da contraltare un rischio di chiusura e di provincialismo; dall’altra parte la precarietà marina dell’identità triestina si accompagna ad una potenzialità, per dirla con Calvino, di leggerezza.
Non dovendo preservare e tramandare nessun sistema di valori primario, nessuna identità “quadrata”, «si può invece pensare che dove l’italiano non basti come filtro contro l’inglese, il dialetto offre un differenziale massimo di opacità, fornendo anticorpi, anche per banale distorsione fonetica, per intaccare la lingua standard dell’impero »[63]. Intraprendere una via del genere significherebbe però assegnare al dialetto una funzione spaesante, terreno di sperimentazione fonica aperto alla creolizzazione, con il rischio evidenziato da Brevini: «non finisce forse anche il dialetto per appiattirsi a confondersi nel fragore polifonico — anzi cacofonico — dei linguaggi contemporanei?»[64].
Non credo che Trieste, città ontologicamente avversa ai formalismi letterari, potrà cedere alle lusinghe del fragore contemporaneo. Una strada mediana potrebbe essere vincente, ma dovrebbe lastricarsi da sé, non essere una colata d’asfalto calata dall’alto. Se le nuove generazioni di poeti triestini riusciranno a trovare un senso nel dialetto, a riconoscere in esso delle radici, seppur debolissime e ramificate, a trovarvi dentro l’umanità di Slataper per ripartire non come gamberi, ma aperti alla contaminazione di ciò che verrà, forse non tutte le speranze saranno perdute. In questo senso, vorrei chiudere con un’analisi lucida di Grisancich, perché mi pare in fondo venata da un moderato ottimismo:
 Se scomparirà il dialetto, e forse, chissà, anche la lingua italiana, non ci dobbiamo tuttavia meravigliare. In fondo è naturale che vi siano delle continue trasformazioni. Pensiamo al dialetto triestino, è un linguaggio nuovo, una lingua franca nata nel 1749 con l’Editto di Maria Teresa. Un linguaggio nato per caso e che potrebbe altrettanto casualmente morire, senza traumi, con il continuo calare demografico per esempio. Ma così è anche per la lingua italiana, chissà quale sarà la lingua che parleremo fra cento anni, e chissà quale sarà la lingua nazionale, e quale allora la poesia scritta, o magari non ce ne sarà più bisogno, vi sarà una poesia visiva o multimediale. È inutile quindi arroccarsi a difesa spietata di una lingua o di un linguaggio. La storia e le conseguenti trasformazioni devono fare il suo corso. Nel frattempo io continuo a scrivere in dialetto, in questo momento c’è, è ancora una lingua che può dare qualcosa. Può darsi che tra alcuni anni io mi riconosca di più nell’italiano o su ciò che il futuro riserverà ai poeti”[65].
Se scomparirà il dialetto, e forse, chissà, anche la lingua italiana, non ci dobbiamo tuttavia meravigliare. In fondo è naturale che vi siano delle continue trasformazioni. Pensiamo al dialetto triestino, è un linguaggio nuovo, una lingua franca nata nel 1749 con l’Editto di Maria Teresa. Un linguaggio nato per caso e che potrebbe altrettanto casualmente morire, senza traumi, con il continuo calare demografico per esempio. Ma così è anche per la lingua italiana, chissà quale sarà la lingua che parleremo fra cento anni, e chissà quale sarà la lingua nazionale, e quale allora la poesia scritta, o magari non ce ne sarà più bisogno, vi sarà una poesia visiva o multimediale. È inutile quindi arroccarsi a difesa spietata di una lingua o di un linguaggio. La storia e le conseguenti trasformazioni devono fare il suo corso. Nel frattempo io continuo a scrivere in dialetto, in questo momento c’è, è ancora una lingua che può dare qualcosa. Può darsi che tra alcuni anni io mi riconosca di più nell’italiano o su ciò che il futuro riserverà ai poeti”[65].
[1] ROBERTO DAMIANI – CLAUDIO GRISANCICH, La poesia in dialetto a Trieste, Trieste, Italo Svevo, 1989, pp. 37-38.
[2] LUIGI NACCI, Trieste allo specchio. Indagine sulla poesia triestina del secondo Novecento, Trieste, Battello stampatore, 2006.
[3] Vi è poi un’altra nutrita schiera di “giovani” non nati a Trieste ma ivi residenti: Umberto Mangani (Ascoli Piceno), Mary Barbara Tolusso (Pordenone), legati all’inizio degli anni ’90 in un sodalizio di cui facevano parte anche Lisa Deiuri e Gaetano Longo; quindi Kenka Lekovich (Fiume), LucaVisentini (Udine), Patrick Karlsen (Genova) e altri autori e autrici che hanno fatto parte del gruppo “Gli Ammutinati”: Angelo Claut (Treviso), Xenia Docio Altuna (Spagna), Davide Pettarini (Pordenone), Furio Pillan (Roma), Francesca Spessot (Udine), Ambra Zorat (Udine).
[4] Anche nell’edizione recente di un concorso localistico come “Una poesia per il ghetto” l’italiano batte il dialetto: su 44 poesie ammesse, 23 sono in lingua (in lingua anche i primi tre classificati): cfr. Una poesia per il ghetto, Trieste, Comune di Trieste, 2005.
[5] Tutti i dati statistici e le risposte del questionario utilizzati in questo saggio si trovano in LUIGI NACCI, Trieste allo specchio, op. cit., pp. 39-47 e pp. 196-201. Al questionario, costituito da 34 domande che inquadrano il rapporto tra poeta, scrittura, ambiente della poesia e Trieste, hanno risposto 110 autori (75% con almeno un volume edito; 59% maschi).
[6] Cfr. MARIA CORTI, Metodi e fantasmi, Milano, Feltrinelli, 1969, p. 116.
[7] ROBERTO DAMIANI, Poeti dialettali triestini. Profilo storico-critico (1875-1980), Trieste, Lafanicola-Svevo, 1981, p. 150.
[8] Cfr. KATIA PIZZI, A city in search of an author. The literary identity of Trieste, London-New York, Sheffield Academic Press, 2001, p. 140.
[9] Cfr. FRANCO SCATAGLINI, Questionario per i poeti in dialetto, in “Diverse lingue”, anno I, n. 5, Dicembre 1988.
[10] Cfr. le conclusioni di LUIGI NACCI, Trieste allo specchio, op. cit., pp. 221-222: «la poesia triestina del secondo Novecento è tendenzialmente di stampo memorialistico, autobiografico, intimistico; non ama la forma del poema o del poemetto, le strutture narrativo-discorsive, bensì preferisce la brevitas caratteristica del filone ermetico e post-ermetico; non è una poesia impegnata, politica, né sperimentale, o di avanguardia; le lingue di cui si giova sono pressoché esclusivamente l’italiano e il dialetto triestino, a cui si affiancano lo sloveno (solo nel caso in cui l’autore sia di madrelingua slovena) e in misura ancora minore la varietà dei dialetti istriani (nel caso in cui l’autore provenga dall’Istria). I modelli a cui la poesia triestina fa riferimento non sono da ricercare in queste zone, né all’interno del bacino mitteleuropeo, ma piuttosto in Italia, in Francia, in Spagna, negli Stati Uniti e nel Sudamerica; è una poesia che si prende molto, moltissimo sul serio, poco disposta all’autoironia, alla messa in discussione del proprio valore o del proprio statuto (per dirla in due parole, poco postmoderna […]; una poesia, inoltre, disinteressata a cantare paesaggi metropolitani, e quindi poco influenzata – secondo i parametri indicati da Benussi – dalla “cultura di città”, poco o per nulla desiderosa di registrare l’avanzamento della modernità e gli effetti che essa provoca sull’uomo; una poesia che ha come primo interlocutore, nel bene e nel male, Trieste, una città contemplata al di fuori della storia, simbolo di qualcosa che non esiste più, somma esponenziale di stereotipi e luoghi comuni, città-cartolina».
[11] Cfr. FRANCO BREVINI, Le parole perdute. Dialetti e poesia nel nostro secolo, Torino, Einaudi, 1990, pp. 27-29.
[12] ERNESTO CALZAVARA, e. Parole mate, Parole pòvare, Milano, Scheiwiller, 1966.
[13] Altri autori potrebbero essere ricordati inoltre, se lo spazio lo consentisse: Sergio Pirnetti, allievo di Giani Stuparich, prolifico scrittore e poeta in lingua e in dialetto; Marcello Fraulini, caparbio presidente della Società Artistico Letteraria, direttore della collana “Il Timavo” e curatore dei “Quaderni” degli Scrittori giuliani, editi da Svevo dal 1953 al 1985; Dino Brezza, alias Sergio penco, cantastorie della saga di Toio Bertoldo; Giovanni Cossutta e la sua parodia de I promessi sposi, dell’Iliade e dell’Odissea; Ezio Giust, che ha pubblicato appena nel 2006, nonostante l’età adulta, la sua prima raccolta di versi in dialetto (Se); oppure poetesse come Laura Borghi Mestroni e Nella Buttiro Bison (queste ultime due nella scia del filone comico-macchittistico che, dipanatosi da Giglio Padovan-Polifemo Acca e Giulio Piazza-Macièta, ha toccato il suo apice nel ventennio fascista con le 101 macchiette-satire-commenti-ricordi del comico popolare triestino Angelo Cecchelin), o Graziella Semacchi Gliubich e Liliana Bamboschek, o altre e altri ancora.
[14] Dal saggio La lingua della poesia in PIER PAOLO PASOLINI, Passione e ideologia, Milano, Garzanti, 1960, p. 281.
[15] GIANFRANCO CONTINI (a cura di), Letteratura dell’Italia unita 1860-1968, Firenze, Sansoni, 1968, p. 1039.
[16] Cfr. PIER ANTONIO QUARANTOTTI GAMBINI, Il poeta innamorato. Ricordi, Pordenone, Studio Tesi, 1984, p. 70.
[17] Cfr. ROBERTO DAMIANI, Poeti dialettali triestini. Profilo storico-critico (1875-1980), op. cit., p. 137.
[18] MARIO DORIA, Storia del dialetto triestino, Trieste, Italo Svevo, 1978, p. 104. Bruno Maier scrive che il dialetto di Giotti non è di tipo popolare, come è in Giglio Padovan, Guido Sambo e altri, bensì molto personale, arcaicizzante, e sottoposto ad un consapevole processo di selezione e depuramento (cfr. BRUNO MAIER, La poesia in dialetto triestino di Virgilio Giotti: dalla realtà al simbolo, in La letteratura triestina del Novecento, Trieste, Lint, 1969, pp. 133-148, p. 144).
[19] Cfr. CLAUDIO MAGRIS, Trieste: malìa e malora del dialetto nei suoi poeti, in “Tuttolibri”, 10, giugno 1978, poi in Dietro le parole, Milano, Garzanti, 201, pp. 173-179 (p. 178).
[20] MAURO CASELLI, La voce bianca su Virgilio Giotti, Udine, Campanotto, 2004, pp. 33-34.
[21] ANITA PITTONI, Fèrmite con mi, Trieste, Edizioni dello Zibaldone, 1962.
[22] ANITA PITTONI, El passèto, Trieste, Edizioni dello Zibaldone, 1966.
[23] ROBERTO DAMIANI – CLAUDIO GRISANCICH, La poesia in dialetto a Trieste, op. cit., pp. 30-31.
[24] Lettera di A.P. a Enrico Emanuelli, 26 luglio 1964 (cit. da SANDRA PARMEGIANI, Far libri. Anita Pittoni e “Lo Zibaldone”, Trieste, Edizioni Parnaso, 1995, p. 146).
[25] GUIDO SAMBO, Òmini e contrade, Roma, La Carovana, 1959.
[26] FABIO TODESCHINI, La poesia di Guido Sambo, in GUIDO SAMBO, Trieste e mi, Trieste, Edizioni C.A.E.S.A.R., 1961, pp. 7-12 (p. 7).
[27] MANLIO MALABOTTA, Diese poesie scrite de novembre, Trieste, s.n., 1947.
[28] MANLIO MALABOTTA, Diese poesie scrite de novembre e qualche altra dopo, Milano, All’Insegna del pesce d’oro, 1968.
[29] LINO CARPINTERI & MARIANO FARAGUNA, L’opera omnia di Druse Mirko, Trieste, La Cittadella, 1954.
[30] LINO CARPINTERI & MARIANO FARAGUNA, Serbidiòla, Milano, All’Insegna del pesce d’oro, 1968.
[31] MANLIO MALABOTTA, Tutte le poesie in dialetto triestino, a cura di Diana De Rosa, prefazione di Vittorio Sereni, con due scritti di Paolo Bernobini, Milano, All’Insegna del pesce d’oro, 1990.
[32] Entrambe le citazioni sono tratte da due articoli di PAOLO BERNOBINI apparsi su «Il Piccolo» rispettivamente l’11 ottobre 1968 e l’11 maggio 1970 e cit. da M. Malabotta, ivi, pp. 183-189.
[33] MANLIO MALABOTTA, Commemorazioni (in memoria di Paolo Bernobini), vv. 1-10, ivi, p. 123.
[34] PIER PAOLO PASOLINI, Carolus L. Cergoly, Inter pocula, poesie segrete triestine, in Saggi sulla letteratura e sull’arte, Milano, Meridiani Mondadori, 2003 (I vol.), p. 2109.
[35] Cfr. ROBERTO DAMIANI, Poeti dialettali triestini. Profilo storico-critico (1875-1980), op. cit., pp. 140-141.
[36] Dal risvolto di copertina di CAROLUS LUIGI CERGOLY, Latitudine nord. Tutte le poesie mitteleuropee in lessico triestino, Milano, Mondadori, 1980.
[37] Cfr. FRANCO BREVINI, Le parole perdute. Dialetti e poesia nel nostro secolo, op. cit., pp. 308-309.
[38] FERY FÖLKEL, Monàde. 33 poesie del Giudeo, Trieste, Il Ramo d’Oro Editore, 2002, p. 33.
[39] ROBERTO DEDENARO, Note per monàde, in Una sera con Fery. Omaggio a Ferruccio Fölkel, a cura di Cristina Benussi, Trieste, Hammerle Editori, 2003, pp. 33-36 (p. 35).
[40] ROBERTO DAMIANI, Poeti dialettali triestini. Profilo storico-critico (1875-1980), op. cit., p. 149.
[41] Dalla breve prefazione di STELIO CRISE a LINO CARPINTERI & MARIANO FARAGUNA, Serbidiòla, op. cit., p. 9.
[42] Cfr. LUIGI NACCI, Trieste allo specchio, op. cit., p. 128.
[43] FABIO DOPLICHER, La poesia, il volto, la lingua in La poesia, il volto, la lingua. Atti in preparazione del convegno sull’opera di Fabio Doplicher, a cura di Gabrio Vitali, Bergamo, Edizioni Grafital, 1999, p. 79.
[44] REMO PAGNANELLI, Fabio Doplicher, Latina, Di Mambro Editore, 1985, p. 14.
[45] FABIO DOPLICHER, Il girochiuso, Roma, Trevi, 1970.
[46] FABIO DOPLICHER, La poesia, il volto, la lingua, cit., p. 66.
[47] Cfr. ibidem.
[48] Cfr. GIORGIO CAPRONI, Fabio Doplicher, in AA.VV., Letture in Versilia, Roma, Quaderni di Stilb, 1984, p. 42.
[49] Cfr. FABIO DOPLICHER (a cura di), Poesia della metamorfosi. Antologia e proposte critche, Roma, Quaderni di Stilb, 1984.
[50] Cfr. FRANCO BREVINI, Le parole perdute. Dialetti e poesia nel nostro secolo, op. cit., p. 293.
[51] CLAUDIO GRISANCICH, Noi vegnaremo, Trieste, Edizioni dello Zibaldone, 1966.
[52] CLAUDIO GRISANCICH, Dona de pugnai, Trieste, Italo Svevo-Lafanicola, 1972.
[53] FRANCO BREVINI, Introduzione, in CLAUDIO GRISANCICH, Crature del pianzer. Crature del rider, Trieste, Edizioni “e”, 1989, pp. I-XX (p. II).
[54] La poesia in dialetto a Trieste, op. cit., p. 34.
[55] Di durezza a proposito del suo dialetto, accomunandolo a quello di Malabotta, parla anche MARIO DORIA in Storia del dialetto triestino, op. cit., p. 181.
[56] Cfr. la prima sezione di UGO PIERRI, Aiku locali, Milano, Terziaria, 1996 (pp. 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 37).
[57] Secondo lo studioso si distinguono nel dialetto triestino 5 varietà: il “triestin patoco” (o standard); il triestino venezianeggiante (scomparso tra la prima e la seconda guerra mondiale); il “negron” (aperto ai gerghi e agli stranierismi); una varietà intermedia tra “negron” e “patoco”; infine il triestino “slavazzado” o “annacquato”. Negli anni dopo la seconda guerra lo “standard” scivola verso lo “slavazzado”, parallelamente il negron subisce un forte regresso.
[58] Cfr. anche Mamie blu (solo un’annotazione: i due autori hanno voluto mescolare le proprie poesie, di conseguenza non è possibile dire con certezza – è lecito solo il sospetto – a chi appartengano le une e le altre): «i conta del paradiso / ma i pianzi el morto per ciavàr el vivo» (p. 44), «remengar le stagioni xe come bestemàr» (p. 46), «capitalista benefator / e pio / porco xe el tuo dio / no el mio» (p. 49; poi in italiano e in inglese in Steel Away, traduz. di Jack Hirschman, Berkeley, Marimbo, 2004), «i bechini-alcolisti» (p. 52), «mati imbriagoni» (p. 54), «l’usèl el se giustava ne le braghe» (p. 55), «andè a cagàr / magneme ‘l cul / in mona de vostra mare / no steme romper i cojoni / xe un dio per tuti / specie per’mbriagoni» (. 57), «quei mone senza dio» (p. 60), » (p. 60), merde de contrati» (p. 68), «a su pare malà che se cagava ‘dosso» (p. 69), «spudade de rancori» (p. 71), «la corte iera ‘na piria / de spuze e de barufe» (p. 72), «un fiol de troja carigo de bori» (p. 74), «e nei cessi palpade de culate» (p. 75), «ch’l spirito santo fossi colomba / fora de la boca de un vecio dio / su la testa de un povero cristo» (p. 76), etc.
[59] Adesso che ti ga fumà la mela / Bala, orcodogio! che te vegni un colpo. / No. No balo par via che no go folpo. / Ara su in palco: là xe mia sorela.
[60] A titolo di esempio: «coss’ te pica l’usel» (Grisancich, Inventario) ; «“co’ Dio” / ga dito mio pare, / che mai’l bestemiava» (Malabotta, Juni ‘Vierzehn) o «’stamatina / go visto / pindolar ‘n t-una graia / ‘n goldon.» (Malabotta, Primavera).
[61] Cfr, GIAN MARIO VILLALTA, “Cambiare voce”. Poesia e autotraduzione nell’esperienza neodialettale, in Tradursi; l’autotraduzione nei poeti dialettali, Atti del Convegno di Cremona, 8 aprile 2003, a cura di Vittorio Cozzoli, Cremona, Comitato Angelo Monteverdi per gli studi del dialetto e folclore cremonese, 2003, pp. 5-9.
[62] VINCENZO BAGNOLI, La lingua dell’altro. La recente poesia in dialetto dell’Emilia Romagna, in “Autografo”, n. 43, luglio-dicembre 2001, pp. 65-78 (p. 67).
[63] FABIO ZINELLI, Dialetto e post-dialetto, in Parola plurale. Sessantaquattro poeti italiani fra due secoli, a cura di Giancarlo Alfano, Alessandro Baldacci, Cecilia Bello Minciacchi, Andrea Cortellessa, Massimiliano Manganelli, Raffaele Scarpa, Fabio Zinelli e Paolo Zublena, Roma, Luca Sossella Editore, 2005, pp. 799-811, p. 805.
[64] Cfr. FRANCO BREVINI, Le parole perdute, op. cit., p. 417.
[65] MARY BARBARA TOLUSSO, Ritratti: Claudio Grisancich, intervista pubblicata il 2 gennaio 2004 nel sito dell’editore Liecolle.














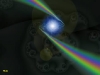


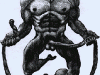



















Bello essere citati come parte di un esempio po siti i di espressione culturale … grazie. Raff B. Lazzara
Di raff bb | 4 Giugno 2013, 16:50