La mia prima intervista con Phillip Lopate, qui di seguito riportata, risale all’inizio di ottobre 2008 ed è stata condotta nella sua casa di Brooklyn, a New York. Più che di una “intervista” vera e propria si tratta piuttosto di una conversazione, di un incontro dai tratti informali, in sintonia con l’idea di Lopate secondo la quale è attraverso la retorica del dialogo che si può davvero conoscere l’Altro.
Da questa prima occasione, dunque, che pure ha seguito lo schema classico della domanda-risposta, non ci si deve aspettare un eccessivo rigore: vi è una sovrapposizione di argomenti, alcune domande sono state riprese e riformulate, altre tralasciate. Il tutto per arrivare a indagare fino in fondo quei nodi della riflessione sulla critica e sul cinema che stavano particolarmente a cuore all’autore.
Stefano Calzati (SC): Phillip, ti sei cimentato praticamente con ogni forma letteraria: romanzi, fiction, poesia, scritti teatrali, critica cinematografica. Qual è la definizione che più ti rispecchia: poeta, romanziere, saggista? O più semplicemente scrittore?
Phillip Lopate (PL): La definizione di scrittore è sicuramente la più ampia e forse quella che meglio racchiude tutta la mia produzione, ma è anche un po’ troppo vaga. Mi considero principalmente un saggista. Certo, la critica cinematografica ricopre sicuramente uno dei campi più prolifici del mio essere saggista, ma non è l’unico. Scrivere saggi, per me, significa disquisire su qualsiasi argomento: dal cinema, alla vita di coppia, da episodi autobiografici della mia infanzia, fino ai piccoli problemi quotidiani. Il saggio per me è in qualche modo terapeutico: è l’arte di intrattenere il lettore lungo un percorso di riflessione che sia prima di tutto personale. Non a caso amo molto cimentarmi con la tradizione del saggio autobiografico.
SC: Focalizziamoci sul cinema, la passione di una vita. Quando è nata? E come è cresciuta negli anni?
PL: È nata quando ero adolescente, verso i 16 anni. Vivevo a Williamsburgh, il quartiere ebraico di Brooklyn, i miei genitori non erano ricchi, ma ci mandavano al cinema tutti i sabati (Lopate ha un fratello e una sorella maggiori e una sorella minore, ndr), forse anche nel tentativo di liberarsi un po’ di noi. Di conseguenza ho iniziato ad appassionarmi a questa arte, di cui apprezzavo il fatto che avesse una storia relativamente recente e in continua evoluzione. Negli anni alla Columbia University, infine, sono riuscito, pur con i pochi soldi che avevo, a coltivare questo interesse e soprattutto a maturarlo: bisogna considerare che all’epoca non c’erano corsi ad hoc o seminari di formazione sul cinema. Ero un cinefilo autodidatta, ma questo non mi scoraggiava ed anzi, insieme a pochi altri compagni, riuscimmo pure a organizzare una rassegna cinematografica che ottenne un certo clamore in città.
SC: Nei tuoi saggi affermi più volte che da giovane amavi quasi tutti i film che andavi a vedere, ne ricordi qualcuno in particolare?
PL: Mi sono subito interessato ai film neorealisti italiani: Roma città aperta [1], Ladri di Biciclette [2], L’Avventura, Umberto D [3] e tanti altri; ma anche ai film americani, soprattutto le pellicole western. Ad ogni modo, c’era una sorta di sentire comune del tutto inspiegabile tra me e il genere neorealista: amavo la ricerca di consolazione che la macchina da presa – e il regista attraverso di essa – cercava nel paesaggio. Una tragicità che è venuta meno quando è mancato il “materiale umano” in grado di trasmetterla, ovverosia le classi più povere. Con l’avvento della classe media in Italia si è persa quell’idea melodrammatica (non senza lampi di ironia) che aveva caratterizzato i migliori anni del neorealismo. Lo stesso, ad esempio, è successo in Giappone. Una cosa però devo ammettere: all’epoca andavo a vedere questi film imbevuto di teorie cinematografiche che mi provenivano dalla lettura dei Cahiers du Cinéma (sia in francese che in inglese), per cui il mio giudizio era in qualche modo già influenzato a priori positivamente. Ora, pur amando ancora molti di questi film, la mia visione è differente: col tempo, i grandi affreschi neorealisti hanno iniziato a non essere più sufficienti per me, avevo bisogno di ritrovare nei film ulteriori livelli di lettura, per questo ho iniziato ad apprezzare autori come Risi – Il sorpasso [4] in particolare – Lattuada, Zurlini, che facevano della commedia amara il loro punto di forza: pellicole in cui il tragico si mischiava al ridicolo, il patetico al grottesco. O, parallelamente, ho iniziato ha riscoprire i film hollywoodiani più genuini e popolari: a un certo momento ho avuto bisogno di cercare qualcosa di diverso, di “nuovo”.
SC: Parliamo dunque dei Cahiers du Cinéma, che sono stati così importanti per la tua formazione.
PL: I Cahiers du Cinéma sono stati indubbiamente importanti per me, prima ancora che come critico, soprattutto come cinefilo. Già nei primi anni alla Columbia ne leggevo pagine e pagine e mi riempivo la testa con concetti come “profondità di campo”, “piano sequenza”, “realismo” e “ontologia del reale”, anche se difficilmente terminavo un pezzo sicuro di averne capito fino in fondo il senso. Ad ogni modo ero affascinato dagli scritti di Truffaut e soci, ma soprattutto dal loro mentore André Bazin: introducevano un modo nuovo, più tecnico e più professionale, di fare critica; esaltavano l’idea di autorialità del film, celebrando registi e pellicole il cui valore fino ad allora, almeno in America, non era unanimemente riconosciuto (il caso di Hitchcock è emblematico); e soprattutto quando diversi critici passarono dalla teoria alla pratica mostrarono davvero di avere uno sguardo innovatore sul cinema. I Cahiers mi hanno aiutato, in sostanza, a capire e a definire meglio i miei gusti e mi hanno indicato dove cercare quei film e quegli autori che rispondevano al mio senso estetico. Parallelamente, però, in America la teoria dei Cahiers ha trovato difficoltà ad affermarsi: se si esclude Andrew Sarris che per alcuni anni ha tradotto i Cahiers in inglese, molti critici erano contro la politique des auteurs. Non dimentichiamoci che qui abbiamo Hollywood: una vera e propria macchina commerciale che, soprattutto nell’epoca d’oro degli Studio, esercitava un’influenza molto forte sull’opinione pubblica e sugli stessi critici.
SC: Cosa ne pensi dell’idea di Bazin secondo cui il cinema, più di ogni altra forma d’arte, riuscirebbe a cogliere “l’ontologia del reale”, idea poi criticata dal decostruzionismo degli anni ’70-’80?
PL: Indubbiamente si tratta di un punto di vista sofisticato e forse, a posteriori, un po’ ingenuo. Niente può catturare a pieno la realtà, ma di certo il cinema, meglio di altre discipline, riesce a suggerire il senso del reale, soprattutto ad un livello emozionale. Non a caso Godard ha affermato che tutti i film sono in un certo senso dei documentari.
 SC: Nel primo saggio della raccolta Totally, Tenderly, Tragically (Anticipation of La Notte: the “heroic” age of moviegoing) parli di come la tua passione ti portò a diciannove anni ad isolarti a tal punto da tentare il suicidio. Dunque, una passione anche rischiosa per certi versi. Ora come consideri il tuo amore per il cinema, un fatto positivo o negativo?
SC: Nel primo saggio della raccolta Totally, Tenderly, Tragically (Anticipation of La Notte: the “heroic” age of moviegoing) parli di come la tua passione ti portò a diciannove anni ad isolarti a tal punto da tentare il suicidio. Dunque, una passione anche rischiosa per certi versi. Ora come consideri il tuo amore per il cinema, un fatto positivo o negativo?
PL: I film, e il cinema in generale, racchiudono sempre per me qualcosa di onirico, un meccanismo ipnotico e di estraniazione che, in fondo, è ciò che ci fa amare questa arte così misteriosa. Si tratta di una passione che va gestita: da ragazzo ne sono stato completamente travolto perché vedevo esclusivamente il bello del cinema. La passione che avevo da adolescente nei primi anni alla Columbia era più una sorta di vgaenerazione che non un avvicinamento critico a questo mondo. Solo in seguito ho imparato a prendere le distanze da ciò che vedevo: se vogliamo, possiamo dire che, come in tutti gli amori, la luna di miele ad un certo punto è terminata. Ho perso il coinvolgimento travolgente dei primi anni per guadagnare in senso critico e capacità di giudizio. Certo anche ora amo il cinema, ma in un modo diverso, di sicuro più maturo e consapevole.
SC: Nell’introduzione al libro American Movie Critics, parli della volontà di “celebrare la critica cinematografica” come una parte delle “lettere americane”. Possiamo quindi parlare della critica cinematografica come di una branca della letteratura americana vera e propria?
PL: Certamente. Il senso dell’affermazione è proprio questo. Io sono fermamente convinto che fare critica cinematografica (e, ben inteso, anche critica teatrale o artistica) significhi fare letteratura. La critica spesso non viene considerata tale in quanto costantemente costretta a pagare il dazio della propria subordinazione. Dal momento che la critica si sviluppa necessariamente come forma di esercizio a posteriori su qualcosa che è già stato scritto, messo in scena o prodotto, spesso questa forma letteraria viene considerata alla stregua di una sorella minore, sempre in debito e mai definitivamente autonoma. Ora credo che questa visione debba essere superata: anche la critica militante, la buona critica militante (così come ci può essere un buon romanzo e un cattivo romanzo, un bel film o un brutto film), deve essere considerata letteratura in tutto e per tutto. I critici di professione non devono avere nulla da invidiare nella loro quotidiana messa in forma del giudizio e del gusto alle opere su cui si cimentano. Anche il loro è un gesto creativo. Allo stesso tempo, però, devo ammettere che oggi è sempre più difficile trovare un buon critico e in tal senso i problemi maggiori nel curare l’antologia li ho avuti a proposito della selezione dei critici contemporanei. Non c’è una scelta abbondante soprattutto perché in qualche modo si è perso il senso profondo e ideologico del fare critica.
SC: È possibile individuare un momento, “una rivoluzione copernicana”, nel quale la critica cinematografica, in specifico, ha fatto il salto di qualità, ottenendo lo status di forma letteraria?
PL: Credo sia difficile individuare un momento preciso. Da sempre, ovverosia da quando esiste il cinema, si è fatta la critica cinematografica. E quindi, almeno per quanto mi riguarda, la critica cinematografica è fin dalla nascita una parte della letteratura. Cinema e critica sono due aspetti della stessa realtà che si richiedono a vicenda. Se poi si pone la questione in termini qualitativi, come dicevo in precedenza è ovvio che esiste la buona critica cinematografica e la cattiva critica cinematografica (e non mi riferisco al valore dei giudizi espressi, che sono insindacabili, ma soprattutto ai problemi stilistici, retorici e argomentativi). Se però la domanda si riferiva al momento in cui la critica cinematografica è stata sdoganata da un certo ambiente elitario e da un certo atteggiamento amatoriale, dato anche dal fatto che il cinema è un’arte recente, allora credo sicuramente che in America ci siano stati alcuni autori che più di altri – James Agee, Andrew Sarris, Pauline Kael – hanno contribuito in maniera decisiva a diffondere, soprattutto nel pubblico, la fama e la reputazione della critica cinematografica come vera e propria forma letteraria e non solo come il vezzo di pochi appassionati. Certamente ad incentivare questo meccanismo ha aiutato anche un certo stravolgimento storico-culturale – neoavanguardie, sperimentalismo – esploso nel secondo dopoguerra e arrivato fino alla fine degli anni ’70. Diciamo che si è trattato di un insieme di concause: più fattori che hanno permesso negli anni ’60 e ’70 di attirare l’attenzione sul mondo del cinema.
SC: Qual è la situazione attuale della critica cinematografica in America?
PL: Purtroppo la critica cinematografica, ma oserei dire la critica militante in generale, non gode di buona salute, qui come altrove, per svariate ragioni. Innanzitutto gli spazi che vengono destinati al critico e al suo articolo sono sempre più limitati (indagare le ragioni di questo soffocamento sarebbe un puro esercizio contabile nelle tasche dei giornali e delle riviste, ma è innegabile che i motivi siano prima di tutto economici). Ormai il critico si trova a lavorare su un massimo di due colonne senza dunque la possibilità di sviluppare un discorso logico e retorico forte. Ciò che ne consegue è la crisi dell’autorialità: una crisi che, se inizialmente ha colpito il mondo del cinema con l’affievolirsi, ad esempio, della politique des auteurs o di altre correnti, ora ha coinvolto inevitabilmente anche i critici e la critica. Tra i motivi c’è appunto la costante riduzione degli spazi dedicati alla critica e l’evolversi delle nuove tecnologie come internet che riducono, minimizzano e anestetizzano anche le autorialità più forti nel mondo della critica militante. Sul web spesso si è costretti a ricostruire le proprie credenziali dal principio. Il critico che nel mondo reale si è costruito col tempo un’ampia cerchia di fedeli lettori a cui si rivolge periodicamente, nel mondo virtuale si trova in qualche modo costretto a rimettersi in gioco. Questa è la vera sfida del critico di oggi: come preservare e imporre la propria autorialità in nuovi contesti, tra cui soprattutto il web. Infine, c’è il problema legato al fatto che spesso la critica e i critici sembrano non voler più (o non essere più capaci di) affondare il colpo: la critica si dissolve sempre più spesso in recensione o, ancora peggio, in recensioni a pagamento che si riducono ad encomi scontati senza alcun valore. Il confine tra criticism e review è sottile, ma esiste ed è una questione squisitamente di metodo, di approccio critico-teorico. Sempre più, però, la recensione subentra alla critica per questioni ancora una volta economiche. Sia ben chiaro, tuttavia, che a me non interessa sapere dove e come vengono investiti i soldi: il problema che voglio porre è soprattutto di impostazione, in quanto ciò che sta venendo meno è in primo luogo la capacità di tramandare la tradizione della buona critica fondata su padronanza di stile e argomentazioni forti.
SC: Quali sono storicamente e attualmente le riviste che hanno saputo dare maggiore spazio alla critica cinematografica in America?
PL: Senza ombra di dubbio The Nation, The New Republic, The Village Voice e The New Yorker. Ve ne sono anche altre, ma se dovessi restringere la cerchia, queste sono le riviste che più di tutte hanno saputo sostenere i critici e la critica cinematografica nel Novecento.
SC: Nell’introduzione a Totally, Tenderly, Tragically parli della tua posizione ambigua rispetto al mondo del cinema in quanto ti definisci sia un outsider sia un insider. Puoi spiegare meglio questa affermazione?
PL: Ciò che intendo dire è che nei confronti del cinema mi pongo in una duplice maniera: in quanto appassionato (con al suo attivo anche un ricco passato da autodidatta) mi sento un outsider, al quale non è richiesto il rigore o la sistematicità dell’addetto ai lavori; in quanto studioso del cinema e per diversi anni anche membro della giuria del New York Film Festival, mi ritengo un insider, cioè una persona che ha avuto l’onore e il privilegio di potersi spingere oltre la propria passione e dare una sbirciata dietro le quinte. Ma solo per un istante, in quanto rimango troppo geloso della mia indipendenza. Io, ad esempio, pur scrivendo decine di saggi e di recensioni in materia, non ho mai avuto una rubrica fissa di cinema su una qualche rivista: fatto, questo, che mi ha permesso negli anni di continuare a parlare di cinema con i tempi e i modi che più desideravo, collegando questa passione a tante altre che possiedo. Credo che se fossi entrato troppo all’interno della macchina-cinema avrei sovraccaricato troppo la mia passione e perso il piacere di andare a vedere un bel film.
SC: Uno degli aspetti che affronti nell’introduzione di American Movie Critics e che sembra starti particolarmente a cuore è il proposito di delineare un percorso cronologico di quella che consideri la “buona critica cinematografica”.
 PL: Esattamente. La raccolta antologica di saggi critici che propongo ha anche questo scopo: il definire, de facto, senza per una volta perdersi in inutili teorie astratte, la buona critica cinematografica e distinguerla da ciò che invece non lo è, si tratti di cattiva critica o di recensioni. Una cosa tengo a precisare: la buona critica è sempre esistita e sempre esisterà, a mio modo di vedere. Il problema è che essa viene sempre più relegata in spazi limitati o minacciata di falsificazione da una concorrenza in-stile-recensione del tutto scorretta. Personalmente, ritengo che un buon critico debba essere: acculturato, aperto, consapevole dei propri gusti (autocritico), intelligente e un buon scrittore. Non sempre oggi è facile ritrovare queste caratteristiche tutte insieme, a prescindere poi dai gusti personali. Ben inteso, però, anche questa antologia è, in primis, una forma di metacritica, cioè di critica della critica, e quindi muove necessariamente da gusti personali: l’importante è che essi siano sempre motivati.
PL: Esattamente. La raccolta antologica di saggi critici che propongo ha anche questo scopo: il definire, de facto, senza per una volta perdersi in inutili teorie astratte, la buona critica cinematografica e distinguerla da ciò che invece non lo è, si tratti di cattiva critica o di recensioni. Una cosa tengo a precisare: la buona critica è sempre esistita e sempre esisterà, a mio modo di vedere. Il problema è che essa viene sempre più relegata in spazi limitati o minacciata di falsificazione da una concorrenza in-stile-recensione del tutto scorretta. Personalmente, ritengo che un buon critico debba essere: acculturato, aperto, consapevole dei propri gusti (autocritico), intelligente e un buon scrittore. Non sempre oggi è facile ritrovare queste caratteristiche tutte insieme, a prescindere poi dai gusti personali. Ben inteso, però, anche questa antologia è, in primis, una forma di metacritica, cioè di critica della critica, e quindi muove necessariamente da gusti personali: l’importante è che essi siano sempre motivati.
SC: Il gusto, l’essenza della critica.
PL: Per me sì. La critica è soprattutto una questione retorica e stilistica. Spesso autobiografica. Fare buona critica non significa solo dare giudizi: in questo magari posso sembrare atipico, ma ci tengo a ribadire che per me un buon pezzo di critica deve innanzitutto dare piacere al lettore. E il piacere viene veicolato attraverso lo stile e la capacità del critico di illustrare il proprio punto di vista. È in questo senso che parlo della critica come di una parte della mia produzione saggistica. La critica è argomentazione logica, conversazione, dialogo con il lettore con cui bisogna essere capaci di costruire un legame di fiducia forte. Solo così si può ribadire la propria autorialità. La critica, dunque, come esercizio del gusto e come intrattenimento del lettore o, detto altrimenti, la critica come arte in se stessa e non come un mezzo per condurre ad astratte teorie sul cinema, né per rispondere a logiche commerciali.
SC: Nella tua antologia sono raccolti critici con approcci diversissimi tra loro (psicologico, sociologico, di genere), tu con quale di questi ti senti più a tuo agio?
PL: Credo che un buon saggio di critica cinematografica dovrebbe affrontare il film in questione integrando più livelli di analisi. Tuttavia, questo spesso non è possibile per mancanza di competenze e di spazio. Io mi ritengo soprattutto un critico formalista: amo affrontare gli aspetti soggiacenti alla messa in scena e allo stile del regista che per me è e rimarrà sempre un autore.
SC: Per te la critica si può insegnare?
PL: È difficile insegnarla. Io credo che la si possa incoraggiare alimentando la consapevolezza nei giovani che oggi più che mai vi è un grande bisogno di critica militante, intesa soprattutto come senso critico, come capacità di discernimento. La critica in realtà è un percorso personale, una predisposizione estetica ed etica alla vita che ci accompagna in ogni circostanza del quotidiano – da cui il mio amore per il saggio autobiografico. La critica, dunque, come forma terapeutica per ognuno di noi, inteso come essere umano. Ciò che si può insegnare, invece, è il retroterra storico e culturale che ha dato vita ai migliori film e alla miglior critica. Non bisogna dimenticare le proprie radici e non si deve mai mancare di evidenziare la mutua necessità che l’arte, il cinema, la letteratura e il teatro hanno nei confronti della critica, così come la critica necessita di queste discipline.
SC: Non a caso nei tuoi corsi all’Università ti soffermi soprattutto ad illustrare quelli che ritieni i grandi critici cinematografici americani e i loro lavori più interessanti.
PL: Esatto. Come in tutte le cose è dai buoni esempi che bisogna partire. Persone come Sarris, Kael, Agee hanno fatto la storia della critica cinematografica americana ed è a loro che bisogna volgere lo sguardo. La lettura di questi maestri: ecco cosa è possibile e necessario insegnare ai ragazzi. Oltre a queste lezioni, però, ho anche tenuto vari corsi di sceneggiatura, nonostante io sia il primo a non aver avuto molta fortuna con il genere.
SC: Come mai?
PL: Ho iniziato a scrivere sceneggiature troppo tardi quando il mio stile saggistico era già troppo definito. Ho scritto tre sceneggiature, ma alla fine nessuna delle tre è mai entrata in produzione. Devo ammettere che ho avuto una certa difficoltà a cimentarmi con il genere: ciò che mi piace di più della scrittura, ovvero l’opportunità di instaurare un ipotetico dialogo con i lettori, nella sceneggiatura non è possibile. La sceneggiatura è una struttura che sfugge sempre: è un sospiro, non una conversazione ad alta voce.
SC: Grazie mille, Phillip.
PL: È stato un piacere.
Per le immagini a casa di Phillip Lopate ringraziamo per la disponibilità e cortesia Liz Arnold, che ha un bellissimo blog e un sito web.
Note
[1] Roberto Rossellini, Roma città aperta, Italia, 1945
[2] Vittorio De Sica, Ladri di biciclette, Italia, 1948
[3] Vittorio De Sica, Umberto D., Italia, 1952
[4] Dino Risi, Il sorpasso, Italia, 1962
Biografia
Phillip Lopate, classe 1943, è uno scrittore, critico e saggista americano, la cui attività attraversa e reinterpreta la letteratura e la saggistica in modo del tutto atipico. Nonostante una posizione defilata all’interno del panorama intellettuale del suo paese, l’acutezza delle riflessioni di Lopate, accompagnate da una prosa sofisticata, ma sempre godibile, non sono passate inosservate in America e hanno consentito all’autore di conquistare una crescente notorietà tra il pubblico.
La sua più che trentennale produzione (l’esordio risale al 1972) spazia dalla narrativa alla poesia, dalla critica alla memorialistica; numerosi suoi contributi sono apparsi su The New York Times, Vogue, Esquire e diversi altri quotidiani e riviste specializzate di cinema tra cui American Film, Film Comment e Film Quarterly. (il suo sito internet è www.philliplopate.com.
















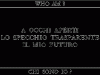























Commenti
Trackbacks/Pingbacks
[…] Phillip Lopate una seconda volta a metà novembre 2008, dunque circa un mese e mezzo dopo il primo incontro. In questa seconda circostanza, l’intervista ha seguito una struttura molto più metodica e […]
[…] del tutto inspiegabile tra me e il genere Neorealista”, mi ha spiegato nel corso della nostra prima intervista, “amavo la ricerca di consolazione che la macchina da presa – e il regista attraverso di essa […]