La scrittura e il cinema: il racconto della creazione.
 Joel ed Ethan Coen, registi di Barton Fink, sono profondamente americani, funamboli dell’insensato, definiti filosofi della pellicola, sicuramente creatori di enigmatiche e cervellotiche storie, ma anche, e in questo risiede parte del loro fascino, ideatori di semplici accostamenti immaginifici, di suggestioni prodotte con abilità attraverso un modo di fare cinema visionario e “superficiale”. È infatti la “superficie” ad interessare i due fratelli, quell’impatto emotivo che possono avere le icone indimenticabili dei loro film: il cappello da gangster in mezzo al bosco in Miller’s crossing, il cerchio dell’hula hoop in The Hudsucker proxy, o la palla da bowling di The big Lebowski, le distese infinite di neve in Fargo, le scatole di brillantina in Brother, where are thou?, il quadro di una donna che osserva il mare sopra la scrivania di uno scrittore in Barton Fink.
Joel ed Ethan Coen, registi di Barton Fink, sono profondamente americani, funamboli dell’insensato, definiti filosofi della pellicola, sicuramente creatori di enigmatiche e cervellotiche storie, ma anche, e in questo risiede parte del loro fascino, ideatori di semplici accostamenti immaginifici, di suggestioni prodotte con abilità attraverso un modo di fare cinema visionario e “superficiale”. È infatti la “superficie” ad interessare i due fratelli, quell’impatto emotivo che possono avere le icone indimenticabili dei loro film: il cappello da gangster in mezzo al bosco in Miller’s crossing, il cerchio dell’hula hoop in The Hudsucker proxy, o la palla da bowling di The big Lebowski, le distese infinite di neve in Fargo, le scatole di brillantina in Brother, where are thou?, il quadro di una donna che osserva il mare sopra la scrivania di uno scrittore in Barton Fink.
Dall’altra parte, Naked Lunch di David Cronenberg, canadese, problematico e difficile, interessato al tema del corpo, con le sue mutazioni e percezioni del reale (ma soprattutto del sintetico) che gli sta attorno. Anche il suo cinema è fatto di immagini indelebili, come la libellula di M. Butterfly, le cicatrici di Crash, gli strumenti chirurgici e corporei dei fratelli Mantle in Dead Ringers, le bioporte in eXistenZ, le labbra carnose di Videodrome, i vermi falliformi in The Parasite Murders, fino alle celle uterine di The Fly e alle macchine da scrivere di Nacked Lunch.
Questi due film, generati da stili e intenti differenti, sono accomunati dalla medesima atmosfera onirica e irreale, dall’impossibilità di ricercarvi un senso compiuto e chiaro. La storia di due scrittori alle prese con la loro opera d’arte si configura per i registi come una lotta tra l’esterno e l’interno di sé, come un’azione straniante che ha il potere di annullare le facoltà percettive, razionali e relazionali dei protagonisti, per portarli all’interno di un mondo altro: il cunicolo nascosto in loro stessi, dove le paure e la solitudine inventiva sembrano essere l’unico luogo adatto alla creazione.
È davvero la sensazione di essere o di voler essere in un altra dimensione che l’affascinante e sfuggente viso di John Turturro conferisce a Barton Fink: quell’espressione di perenne disagio e inadeguatezza che fa del film dei fratelli Coen una continua ricerca del momento della verità. Un desiderio perennemente frustrato, perché l’essenza della storia risiede anche nella sua inspiegabilità, nel suo modo di essere ambigua e difficilmente interpretabile in maniera univoca. Così è anche per William Lee di Naked Lunch, che si incarna nella recitazione straniante di Peter Weller, un volto appuntito e sfuggente, che si nasconde allo sguardo dello spettatore e al senso stesso del racconto.
Entrambi gli scrittori dunque, appaiono come vittime di se stessi, prigionieri della loro capacità (o incapacità) di creare: i Coen rappresentano questa gabbia attraverso il luogo/cervello dell’Hotel Earle (spazio del “sentire”, del senso uditivo), colorato di tinte polverose, verdi ammuffiti e gialli collosi, discendente dell’altro celebre albergo “dannato”, il kubrikiano Overlook Hotel (regno della vista e del “vedere oltre”).
 Da parte sua, Cronenberg, seguendo i fili sconnessi delle pagine del Pasto Nudo di William Burroughs (1959), crea Interzone, uno spazio anch’esso grigio, fuligginoso e giallognolo, labirintico quanto basta perché il protagonista vi si perda senza possibilità di salvezza. I luoghi di entrambi i film si integrano, forse si confondono nella luce sporca che li illumina e li oscura, e in entrambi il senso di irrealtà, una mezza veglia che inebetisce, imbriglia i protagonisti (e soprattutto gli spettatori) in una sorta di continuo transito tra una visione ad occhi aperti e una ad occhi chiusi.
Da parte sua, Cronenberg, seguendo i fili sconnessi delle pagine del Pasto Nudo di William Burroughs (1959), crea Interzone, uno spazio anch’esso grigio, fuligginoso e giallognolo, labirintico quanto basta perché il protagonista vi si perda senza possibilità di salvezza. I luoghi di entrambi i film si integrano, forse si confondono nella luce sporca che li illumina e li oscura, e in entrambi il senso di irrealtà, una mezza veglia che inebetisce, imbriglia i protagonisti (e soprattutto gli spettatori) in una sorta di continuo transito tra una visione ad occhi aperti e una ad occhi chiusi.
Solo due film usciti nello stesso anno (1991), che però accostati riecheggiano, creando una eco sottile. Due film gemellari, che si intrecciano in alcuni punti, si dividono in altri, che parlano attraverso due linguaggi diversi e complementari, attraverso molteplici immagini che ricorrono. Barton Fink, infatti, può essere considerato un film di suoni, in cui la dimensione corporea e visiva sembra farsi sempre più labile per lasciare spazio a sensazioni uditive, inquietanti ed evocative. Contrariamente, Naked Lunch indossa una solida dimensione corporale, dove i modi di sentire si articolano attraverso il contatto, mani su altre mani, corpi dentro altri corpi. Sebbene l’evanescenza che connota tutta la storia sia indiscutibile, la concretezza fisica rimane sia come cifra cronenberghiana, sia come necessità di rappresentare la creatività che si fa arte, “cosa” visibile. Un bisogno tutto cinematografico dunque, di un cinema che deve farsi immagine concreta per rappresentare mondi di idee.
In entrambi i film lo sguardo non è più testimone, non garantisce più la comprensione: il lavoro della mente crea spazi alternativi che si ibridano con la realtà esterna fino a confondersi, fino a che gli occhi non sono più in grado di distinguere il vero dall’invenzione.
Ma è alla fine che si arriva ad un cortocircuito destabilizzante: l’Audrey di Barton e la Joan di William (due figure femminili centrali in entrambe le narrazioni) prendono le fattezze di un’unica attrice, Judy Davis, ed ecco che lì, forse, due lavori filmici diventano uno solo, fusi insieme in modo profondo dalla presenza di un corpo comune. Un blackout momentaneo, nel quale i visi e le storie si confondono, in cui l’uccisione della donna acquista un significato più ampio, come se andasse a coinvolgere l’essenza stessa del cinema. Ancora, il cinema che crea storie diverse, film lontani tra loro, che per uno strano congiungimento si ritrovano affiancati. Come per un’esile magia, l’attore e il personaggio si uniscono, la storia, il libro, la produzione e il montaggio diventano una sola creatura. Pure coincidenze, o forse no, che contribuiscono a creare una rete di immagini in viaggio al di sopra della volontà dei loro creatori e di chi le osserva.
Le storie sembrano allora generarsi da sole, sembrano creare fili indipendenti dalla volontà di registi, produttori e attori, sembrano ripetersi sempre uguali e sempre diversi da se stessi, come in un cerchio di rappresentazioni senza inizio e senza fine, un ritorno continuo alle porte di una città mai visitata, ma già conosciuta, come un quadro appeso ad una parete già visto in passato, nel quale poi ci ritroviamo a vivere inconsapevolmente.
La creatività è allora davvero una forza pericolosa, perché è fuori da ogni controllo, generandosi direttamente dall’uomo per poi prenderne possesso in modo totale. È questo strano invasore che il cinema indaga, sul quale sperimenta la propria volontà di mettersi in scena, senza pretendere di dare delle risposte, ma sempre pronto a gettarsi oltre il confine di un realismo che ha cessato di rappresentare il nostro tempo.
Un cinema che parla di sé mentre mostra il lavoro di due scrittori e che sente propria la difficoltà di gestire la materia creata, cerca di rappresentare le proprie debolezze, l’impossibilità di tracciare una linea divisoria chiara tra il dentro e il fuori della creazione. E proprio in questo, paradossalmente, il cinema ci offre alcune delle migliori prove della sua creatività.
Spazio. Barton Fink, di Joel ed Ethan Coen. Hotel Earle, “A day or a lifetime”
Un Hotel dimenticato, uno spazio infinito e labirintico, fatto di polvere e di ombre, di muri ovunque, di colori sbiaditi, vivaci un tempo. Uno spazio chiuso in sé, che non lascia entrare e uscire niente e nessuno: le finestre sono incastrate, la facciata dell’albergo non viene mai inquadrata, l’arrivo o la partenza degli ospiti, la zona in cui l’edificio è stato eretto sono un totale fuori campo. Sembra quasi che sia un luogo indescrivibile, senza spazio, al quale si può solo alludere: sussurri, rumori, scricchiolii e ronzii che corrono nelle sue pareti, qualche impronta di presenze vive, come le scarpe fuori dalle stanze che sono reperti cimiteriali, tracce di una vita conclusa. Un luogo di profondità nascoste, tra dimensioni verticali e sprofondamenti, dall’emersione verso un’improbabile cavità del portiere Chet, all’inquietante movimento della macchina da presa che si immerge interamente nello scarico del lavandino nel bagno di Barton.

Sicuramente un luogo di assenze: assenza di vitalità, di concretezza, di verosimiglianza, di aria. In ogni angolo delle camere i ventilatori si muovono, a garantire quel circolo minimale di ossigeno che permetta all’hotel stesso di respirare. O meglio, che permetta alla storia di durare fino alla fine. L’Earle è un luogo in punto di morte, con le pareti in agonia, la carta da parati che si stacca come una pelle che si squama e che sanguina colla. È un corpo abitato, che sopravvive perché la storia può svolgersi solo al suo interno, che può accogliere gli ospiti “solo per un giorno o per tutta la vita”. Una prigione scelta consapevolmente o che si può visitare brevemente per trovare qualcosa: Barton forse voleva cercare l’isolamento, la fecondità creativa, il lampo geniale, la coscienza della verità, ma cosa ha scoperto tra i muri della sua stanza? Forse se stesso, forse nulla.
Lo straniamento dello sceneggiatore Fink, la lontananza che lo divide dalle parole giuste dell’opera perfetta, si innesta nell’atmosfera di tutto quanto l’albergo, incarnandosi nelle sue strutture fisiche: l’immenso atrio, la piccola stanza, il lungo corridoio sono tutti spazi vuoti, ma profondi, nei quali è possibile perdere se stessi, abbandonare la realtà della vita per immergere il proprio corpo/mente nel vortice della creazione letteraria. E forse questo significa lasciare qualsiasi visione razionale della propria identità di scrittore.
In effetti, fuori da se stesso Turturro/Barton si smarrisce: l’esterno è un luogo straniero, del quale non può prendere possesso, ma che può solo osservare con incredulità. Non è in grado di stabilire quale delle due zone (fuori e dentro l’Earle) sia quella della veglia, della realtà e quale quella del sonno, dell’invenzione.

Durante il primo colloquio con Lipnick, il suo produttore, il protagonista sceneggiatore entra e poi lascia l’ufficio con due carrelli in soggettiva, rispettivamente in avanti e in dietro. Punti di vista estremamente passivi e amorfi, che riconducono la visione all’indefinibile senso onirico di cui tutto il film si nutre. L’ufficio del magnate di Hollywood è come un set che si allontana, sembra sprofondare in una parte della mente dello scrittore, oppure da lì staccarsi per lasciare posto alla visione successiva.
Un “fuori” totalmente altro rispetto al luogo dell’albergo, zona in un’altra dimensione, priva di inquadrature che facciano transitare la visione e i personaggi dall’interno all’esterno, tra il desiderio utopico di Barton di creare una storia esemplare dell’uomo comune e le richieste produttive del cinema hollywoodiano, con le quali lui non è in grado di confrontarsi.
La stanza in cui si svolgono la gestazione e la nascita della sceneggiatura sembra essere una cella claustrofobica scelta consapevolmente dallo scrittore per poter creare; dall’altra parte però, è anche un luogo ostile, che osserva il suo ospite in modo insistente, con punti di vista a piombo roteanti, con zoom ravvicinati e disturbanti sul suo viso. Se prima il set era esterno, ora Barton vi è totalmente avvolto: è il protagonista, suo malgrado, delle quattro mura della sua stanza. Il calore soffocante e i colori che sembrano ammuffiti sono emblema dell’aridità creativa in cui è caduto o che forse lo ha sempre accompagnato.
Spazio. Nacked Lunch, di David Cronenberg. Interzone
Da New York all’Interzona la distanza è molto breve: solo il tempo di ammazzare una donna, di sostituirla con una macchina da scrivere e lo scrittore è pronto per il viaggio.
Interzona: una sorta di Mecca dell’immaginario, una Tangeri della mente, un luogo/non luogo fatto di stradine e sporcizia, di devianze e di deviati, di mercati della droga, di drogati, ma soprattutto di scrittori: l’unico posto fatto su misura per uno scrittore o che uno scrittore è obbligato a costruirsi.
Definire cos’è l’Interzone rischia di diventare un tentativo senza speranza di ingabbiare dentro le parole l’indefinibile: l’Interzona è indefinibile, è l’Indefinibile che può essere visto e vissuto, ma mai raccontato. Un po’ come Matrix, entità inspiegabile a parole, della quale si può avere un’idea solo vedendola con i propri occhi.
Sono proprio gli occhi e tutto il corpo di Bill Lee a vedere e vivere questo spazio, misterioso sicuramente, perché appare sullo schermo come un miraggio ombroso, una zona limite tra la veglia e il sonno. È proprio questo aspetto di inconsistenza, di verosimiglianza obnubilata a svelare l’essenza di Interzone, come luogo/metafora del lavoro intellettuale e anche fisico di colui che crea mondi alternativi a quello reale: lo scrittore.

Ora, cercare di definire quale sia il mondo reale e quale quello della mente, cercare di tracciare una linea separatoria tra l’allucinazione, la distorsione visiva e la percezione razionale degli eventi, il vissuto concreto della vicenda, è un’operazione di poco interesse. Questo perché esiste nel film un livello tale di indecifrabilità che è da considerarsi come il fondamento stesso del racconto, il suo sfuggente nocciolo semantico: per Bill non esiste un luogo dove vivere separato dal luogo della creazione, ma lo scrittore in quanto tale non può esistere al di fuori del mondo da lui creato. L’ambito dell’invenzione diventa l’unica realtà che egli può conoscere.
Questa infiltrazione tra creato e vissuto è resa fisicamente, come piace al regista, nelle rappresentazioni di New York e di Interzone: entrambe colorate delle stesse tinte polverose e ferrigne, dove medesimo è il senso di spazio chiuso e soffocante. Attraversate dagli stessi personaggi, dalle stesse vicende, come in un anello inscindibile che si stringe attorno alla sua vittima e creatore, le due città sono l’una lo specchio dell’altra.
Così, l’appartamento che Lee divide con la moglie Joan è un vero e proprio luogo/incubo: un antro di sporcizia e sudore, abbandonato, dove le persone sembrano esistere come ombre, proiezioni di corpi che risiedono altrove, che riempiono lo spazio come gli oggetti disordinati lasciati su tavoli e scaffali. I corpi tendono a con-formarsi, prendere la forma dell’intorno spaziale che li rinchiude: la fuliggine li restituisce quasi impalpabili, il buio li nasconde, rendendoli sfuggenti e inafferrabili alla vista e alla comprensione. Così è anche la stanza nell’Interzone dove Bill scrive i suoi rapporti, dove lo scrittore parla con la sua macchina da scrivere, dove tocca il suo corpo erotizzato. Un luogo di inconsistenza e indefinibilità, dove nelle inquadrature della camera perennemente fosca si riesce a vedere più di una volta una finestra aperta sull’esterno. E questo fuori si delinea come un biancore accecante, un riflesso di strutture architettoniche azzurrate, in totale contrasto con l’interno, talmente rarefatto e stilizzato, senza profondità, da sembrare un set cinematografico di cartone.
Ecco il secondo piano, la profondità che manca a buona parte delle inquadrature del film: la realtà si appiattisce contro la finzione facendo corpo unico, annullando la distanza tra l’una e l’altra. Oltre questa dimensione ibrida non esiste nient’altro, o meglio, esiste un ulteriore livello di illusione (cinematografica?) che non può essere penetrato, uno sfondo asettico e privo di significato che ha il solo compito di reggere in primo piano i luoghi della creazione. Una stratificazione di apparenze dunque, di innesti tra la creazione letteraria, la vita dell’artista William Borroughs e l’invenzione cinematografica di Cronenberg, dove il cinema si dichiara come spazio più finzionale della finzione, più inafferrabile dell’onirico, ma sempre come profondità fondativa che tenta di gettare luce sull’ambiguità dell’esistere e del creare.
Se poi la luce si trasforma in ombra e l’ambiguità si ingigantisce invece che diradarsi, significa forse che non è più possibile riconoscere l’esterno e l’interno di una finzione, che il nostro mondo, come quello di uno scrittore, è composto da livelli differenti di immaginazione.
Percezione di realtà/irrealtà. Barton Fink, di Joel ed Ethan Coen
“Tu sei solo di passaggio, ma io ci vivo qui…
E tu arrivi e ti lamenti, perché io faccio rumore”.
I rumori disturbano il lavoro di Barton e il suo sonno. Non si può addormentare, perché altrimenti il viaggio che ha iniziato andrebbe perso. Tutto il film è pervaso da un’atmosfera sognante da incubo, forse da uno strato di follia, come un avvertimento: quello che state vedendo non è reale.

Partendo allora dal presupposto che il viaggio di Barton sia un percorso cerebrale all’interno della sua mente, diventa plausibile pensare alla figura di Charlie (Goodman) come doppio di Fink (Turturro) (e, d’altra parte, è interessante considerare che entrambi gli attori si chiamino John, compreso la figura autorevole e paterna dello scrittore W.P. Mayhew interpretato da John Mahoney). Forse una sorta di parte inconscia, un accumulo corporeo di frustrazioni e desideri repressi, quell’uomo medio/mediocre che Barton ricerca e insegue senza accorgersi di averlo dentro di sé. Non a caso, l’uomo suda come l’albergo si liquefa: lui lì ci abita ed è Turturro ad essere l’ospite temporaneo, ma sembra non capirlo, sembra essere lontano dalla verità. Anche se la macchina da presa cerca in ogni modo di indagarlo, allontanandosi e avvicinandosi a lui in un continuo tentativo di penetrazione, ispezionandolo dall’alto e girandogli sopra la testa, rimane svanito e inconsapevole di ciò che esiste nella sua mente.
L’Earle è dunque il luogo di Charlie, dove lui vive, dove è stato dimenticato e rinchiuso, da dove vuole tornare per emergere, compiendo tutte le azioni che l’inconscio di Barton desidera mettere in atto: uccidere Mayhew, padre putativo e traditore; uccidere i poliziotti, razzisti e insensibili (disprezzano Fink perché ebreo e non lo considerano un artista); uccidere Audrey, forse simbolo materno dell’impulso creativo, che Barton possiede (fisicamente e mentalmente, in uno spazio che è concretizzazione di un’idea), ma che deve poi annullare, perché non è parte di lui, perché non può accettare che l’ispirazione gli venga dall’esterno di sé. Anche qui l’ascolto rimane disatteso, l’incontro fruttifico con l’altro non si compie. È così che, preso dal furore dell’illuminazione, si tappa le orecchie con un paio di batuffoli di cotone, togliendoseli solo a lavoro ultimato: il manoscritto sistemato sul tavolo con l’ovatta appoggiata ai lati del titolo.
Lo scrittore è talmente immerso nel suo lavoro, così sordo verso il mondo fuori, da non riconoscere una realtà altra dalla sua creazione, da non riuscire più a vedere, o meglio, ad ascoltare, quel principio di realtà da cui si è completamente allontanato. I registi raccontano la perdita di ogni contatto con il mondo attraverso alcune soggettive di Barton: all’inizio lo scrittore è padrone del suo intorno sociale e agisce nella realtà che lo circonda attraverso un punto di vista ancorato al vero, leggermente supponente, avvicinandosi al tavolo di un bar dove lo attendono alcuni amici. Ma quando il luogo cambia, anche la percezione visiva dello scrittore si deforma: egli “osserva” seduto sul letto i rumori dei passi di Charlie, che si sta avvicinando minaccioso alla sua camera. “Osserva i rumori”, perché gli occhi sono vittime di una distorsione, non più abili a inquadrare chiaramente la realtà, ma supportati dall’udito. Alla fine, Fink è totalmente perso nel suo delirio di onnipotenza: caduto a terra nella sala da ballo, si allunga attraverso uno sguardo che vola tra le gambe delle persone, si arrotola su se stesso senza più avere la possibilità di focalizzare e di collocare il punto di vista. È ormai un panorama scopico senza controllo, che si infila tra gli oggetti privo di un senso compiuto, come uno strumento libero da qualsiasi condizionamento di tipo conoscitivo e interpretativo sul mondo. Sprofonda all’interno di una tromba che suona, lasciando sullo schermo il nero della visione, riempito solamente dal suo suono invasivo.
Percezione di realtà/irrealtà. Nacked Lunch, di David Cronenberg
“Diciamo che Bill ha il controllo di un certo…
unico principio di realtà”

Sembra impossibile svegliarsi dalla lettura di un libro. Fino a che non si è arrivati all’ultima pagina, si continua a rimanere lì, in quel mondo, in quella realtà incompiuta. Questo vale ancora di più per lo scrittore, così avvinto alla storia che sta raccontando da non rendersi conto nemmeno di raccontare una storia: inquadra troppo da vicino il suo oggetto, tanto da lasciare fuoricampo i suoi confini.
William Lee è uno scrittore, o forse uno sterminatore di scarafaggi. Meglio ancora, uno sterminatore letterario, vale a dire, essenza ossimorica di un atto che è creativo e distruttivo nello stesso istante. Lo sterminio investe in modo totale quel principio di realtà di cui lo scrittore è (o forse non lo è mai stato) padrone: in Interzone, Bill è al di sopra di tutto perché crea ogni cosa vivendola, mentre con la stessa forza è vissuto dalle sue creazioni. E non potrebbe essere altrimenti, in un film dove esistenza e letteratura si intrecciano fino a fondersi: la vita di William Burroughs, (scrittore, amico di Kerouac e Ginsberg, sperimentatore per quindici anni di ogni droga possibile, che per dimostrare la propria abilità con le armi da fuoco mirò con la pistola a un bicchiere collocato sulla testa della moglie, uccidendola, per poi lasciare subito il Messico alla volta di Tangeri, dove iniziò a scrivere le pagine che sarebbero confluite nella raccolta The Naked Lunch) si confonde con le vicende narrate nel suo stesso libro e vissute in un film titolato Naked Lunch, da un personaggio che porta come nome lo pseudonimo ch’egli utilizzò per firmare il suo primo libro.
Svegliarsi e ritrovare il filo di Arianna per uscire dal labirinto non è più possibile. Per due volte, le uniche due volte, Lee si ritrova addormentato per strada, senza una motivazione o senza un collegamento logico con la scena precedente. Ed entrambe le volte al risveglio non ricorda quello che era successo in precedenza: nessuna memoria della festa con i ragazzi dell’Interzona e, quel che più conta, nessuna memoria del libro. The Naked Lunch fa il suo ingresso solo verso la fine del film, prima di questo momento non abbiamo mai visto Bill scrivere un romanzo. Anzi, egli viene trovato dagli amici riverso sul marciapiede, con un sacchetto tra le mani che dovrebbe contenere i resti della sua macchina da scrivere, ma è pieno soltanto di flaconi e siringhe. Nessuna traccia dunque della scrittura, forse perché veramente non c’è mai stato un racconto, o meglio, il racconto c’è stato ma è ormai consumato, divorato, vissuto dallo scrittore come fosse una realtà. Rimane solo la droga, l’allucinazione, che permette la permanenza nell’altro mondo, ormai l’unico possibile. È questo il momento rivelatore per gli spettatori e per i personaggi, che capiscono come Bill possieda il controllo sul principio di realtà ad Interzona: annullando tutti i pensieri razionali, come egli stesso dice all’inizio del film, lo scrittore ha la possibilità di sperimentare a fondo il mondo da lui creato, di fondersi con esso per sentirlo con il corpo.
Anche se forse è un’esperienza vissuta con dolore, con lacerazione, in una grande solitudine, come ci lascia capire il suo pianto dopo aver lasciato andare i suoi soli due amici, è anche l’unico modo di vivere che lo scrittore possa conoscere.
La donna. Barton Fink, di Joel ed Ethan Coen
“Are you in the pictures?”

L’immagine di una ragazza che osserva il mare. Un particolare atipico che possiede una forza suggestiva impressionante. Più volte Barton rimane letteralmente impigliato con gli occhi nell’immagine e con le orecchie nello sciacquio delle onde, fino quasi ad immergersi in esso. Ogni volta però viene disturbato da qualcosa che interrompe la magia, allo stesso modo in cui quando perde la coscienza, addormentandosi o svenendo, viene destato dal rumore di una zanzara (anche se a Los Angeles, nel deserto, le zanzare non ci sono) o dagli schiaffi di Charlie.
Questo piccolo quadro appeso alla parete sembra avere la potenzialità di portare Fink fuori dalla stanza, come se fosse una via di fuga, un percorso fulmineo per arrivare alla fine della storia. In effetti, sulla stessa scena si conclude il film, con Barton protagonista del quadro che aveva osservato. Forse nella sua mente esiste già l’impronta del finale della sua vicenda: dopotutto i Coen, prima di iniziare il film, sapevano già come concluderlo.
“Lei lavora nel cinema?”, chiede lo scrittore alla ragazza, in un gioco di parole che significa anche: “È lei la ragazza del quadro?”. Un punto di fuga, abbiamo detto, o anche di arrivo, uno spiraglio dopo l’afa dell’hotel/cervello, dello spossante tentativo di creare con le orecchie tappate, di cercare le parole giuste senza ascoltare. Dentro di sé, Barton guardava una ragazza che forse osservava a sua volta un oceano di immagini, una moltitudine di storie, come è il cinema. Il mare, scrutato una volta e una volta ancora, il mare che si infrange contro un grande scoglio, come segno dell’ingresso e dell’uscita di Barton da sé.
Ma prima della donna osservata, è apparsa nella vita dello scrittore la donna desiderata, con la quale ha compiuto un edipico incesto: l’algida Audrey, dura nel suo dolore, ingabbiata in una vita con un uomo che non potrà mai amarla. Totalmente priva di qualsiasi possibilità generativa sul piano umano e sentimentale, non può essere veramente donna, perché le sono preclusi i due fondamentali atti fecondi per eccellenza: l’amore come incontro tra due esseri che si modificano a vicenda creando un solo corpo, e la maternità come creazione completa di vita.
Eppure, sia Mayhew che Barton hanno bisogno di lei per scrivere. È infatti proprio lei la loro Musa, colei che sacrifica la sua fecondità per donarla totalmente ai due scrittori: lei che scrive per il vecchio, sempre lei che offre la sua comprensione al giovane in crisi, dandogli la possibilità di riempire la pagina bianca. Un sacrificio necessario per il bene dello scrittore, che forse compie l’ultimo disperato tentativo di liberarsi dall’ossessione per l’opera letteraria.
Barton è disposto a tutto per scrivere qualcosa di veramente grande, ma non si rende conto che rimanendo chiuso nella propria individualità non riuscirà mai a esprimersi completamente. E la libertà che continua a presagire attraverso la serenità del quadro rimane un miraggio fino alla fine.
Alla fine c’è calma sulla spiaggia, come se davvero Fink avesse preso consapevolezza del suo profondo essere, come se alla fine la Musa e la Madre fossero rinate nell’immagine di una donna che osserva. Allora Audrey può essere davvero l’ispirazione poetica sacrificale, e la donna che osserva è forse l’idea libera, una di quelle icone inspiegabili che i Coen conoscono così bene. Una donna che sembra esistere, ma che forse è solo l’immaginazione di uno scrittore desideroso di ritrovarsi al sicuro, di liberarsi dalla claustrofobia di una stanza infruttuosa per lasciare il suo corpo sciolto dalla sua mente, per abbandonare se stesso accanto alle sue più profonde e naturali immaginazioni.
Osservare una realtà incorniciata, osservare chi osserva e vive oltre noi, non è forse la condizione di chi guarda il cinema? E se prima la condanna dello scrittore sordo era quella di non appartenere a Hollywood, di non riuscire a scrivere la sua sceneggiatura, di essere ingabbiato nella sua egoistica solitudine, ora egli può vivere nella consapevolezza che non esiste un lavoro perfetto, che la sua mente non è quella del genio, ma è merce della Capital Pictures (forse rinchiusa in una scatola di cartone imballata), che lo statuto di creatore è relativo, che lui è un uomo e un artista mediocre.
L’albergo va in fiamme, ma sopravvive l’idea libera, l’intuizione del mare, che Barton può vivere senza angoscia. Il fuoco purifica e l’acqua battezza: lo scrittore inizia a vivere solo ora.
La donna. Nacked Lunch, di David Cronenberg
“Credo sia arrivata l’ora del nostro Guglielmo Tell”
Un rito di passaggio. L’unico modo per entrare nell’altro mondo. Uccidere la donna, forse amata, forse no, ma comunque ucciderla, per poter iniziare il proprio viaggio. Il senso di un personaggio come Joan si rivela tutto nella sua morte, come se il suo apparire avesse un senso solo in relazione alla sua scomparsa. E al suo ritorno.

La prima Joan, moglie di Lee come di Burroughs, è una donna completamente assuefatta, alle droghe, certamente, ma ancora di più all’irrealtà che la circonda, a quel modo di vivere al di sopra delle righe, o forse proprio dentro le parole di un libro. Iniettarsi polvere gialla è come fare un viaggio letterario, dice, è come trasformarsi nell’insetto kafkiano. Lei forse, più ancora di Bill, ha la consapevolezza che Niente è vero, tutto è permesso, che la metamorfosi del corpo è solo un fatto mentale, guidato dall’immaginazione e dalla fantasia di sperimentare modi alternativi di essere. Dopotutto, le stesse macchine da scrivere sono corpi ibridi, una specie nuova tra l’inorganico e l’organico, tra il ferro e la carne di scarafaggio. E come lo scrittore distrugge la sua prima macchina da scrivere, così distrugge anche il suo primo oggetto del desiderio. Così sarà anche nell’altro mondo, quello di Interzone, in cui il massacro di uno scarafaggio-macchina verrà seguito dall’iterazione dell’omicidio della donna.
Per due volte Cronenberg ci mette davanti agli occhi l’inconcepibile gesto di Bill: con la coscienza confusa dalla droga (una coscienza perennemente assente e volatile) egli compie l’unico gesto possibile per penetrare nell’Interzone. La pistola viene scambiata con una macchina da scrivere, come a dire che lo strappo, il buco creato dalla scomparsa della donna può essere riempito solo con l’impegno della scrittura. Ma forse, Joan e la macchina sono la stessa cosa: entrambe in grado di cambiare forma per diventare insetti, entrambe permettono a Bill di compiere il suo personale viaggio letterario.

Tuttavia, la doppia presenza di questa Musa mostruosa all’interno della diegesi filmica appare come una sterile rigenerazione di se stessa: ogni rapporto d’amore le è negato, il coito non avviene mai, non è contemplata nella sua vita la presenza o il progetto di un figlio, anzi, le figure dei ragazzi di Interzona, gli unici che potrebbero connotarsi come suoi discendenti simbolici, sembrano ribadire, con la loro omosessualità e bisessualità e con i loro atteggiamenti potenzialmente incestuosi, la totale mancanza di qualsiasi gesto generativo. Il ritorno di Joan nella dimensione di Interzona è utile solamente a ribadire la necessità della sua morte, l’esigenza per lo scrittore di dichiararsi attraverso quel gesto violento che allontana qualsiasi legame sentimentale. Quando i poliziotti alla frontiera di Annexia chiedono a Lee di dimostrare di essere uno scrittore, egli mostra loro la penna. Ma questo strumento non è indicativo in un mondo in cui la scrittura a mano equivale ad uno scempio, in cui scrivere è sinonimo di alterazione mentale e perdita della coscienza; il rapporto con la macchina da scrivere è talmente esclusivo che è lei ha dettare le parole, è lei ha farsi corpo, immagine concreta del pensiero.
Scrivere con la penna in mano è sinonimo di un potere creativo che allo scrittore è negato. Per provare la sua identità, Bill gioca al Guglielmo Tell con la sua Musa, ancora una volta gioca con lei, in una sorta di rito ludico che si ripete all’infinito, che permette di entrare in un’altra città, un’altra zona della mente, Annexia, identica ad Interzone o completamente diversa. Alla fine, importa solo la ripetitività del gesto, vissuta come la condanna al perenne migrare da una storia all’altra, da un’immagine a quella successiva, in un continuo girotondo senza inizio e senza fine, nel quale lo scrittore si trova a giocare, ancora una volta, da solo.
Barton Fink (Barton Fink – È successo a Hollywood) è il quarto film dei fratelli Joel ed Ethan Coen, nati a Minneapolis rispettivamente nel 1954 e nel 1957. Barton Fink, girato nel 1991 e scritto durante la difficile lavorazione di Miller’s Crossing (Crocevia della morte, 1990), consacra John Turturro e John Goodman tra i loro attori feticcio. Uno dei film più criptici della loro storia cinematografica è ispirato alla personaggio dello scrittore Clifford Odets, drammaturgo americano degli anni Trenta.
Nacked Lunch (Il pasto nudo) del regista canadese David Cronenberg è uscito lo stesso anno del precedente, il 1991. Ispirato all’omonimo libro di William Burroughs del 1959, che il regista aveva letto all’età di vent’anni, è un testo-limite, come definito da Gianni Canova, estremista nelle forme e nei contenuti tanto da precipitare nell’incomprensibilità. Il film fu approvato dallo scrittore stesso, a cui Cronenberg sottopose la sceneggiatura, e girato interamente in Canada.
















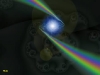




















Commenti
Non ci sono ancora commenti