Prosegue da Il via vai della filosofia
Il Palacio del Segundo Cabo, in Plaza de Armas, costituì il centro governativo del colonialismo spagnolo a Cuba, ed è qui che approda l’arca degli scrittori italiani invitati a partecipare, a L’Avana, alla feria mundial del libro che inaugura il nuovo millennio.

Assicurata per benino alle apposite bitte, il prezioso carico, scende in passerella, mettendo in mostra i suoi gioielli, di fronte a una sparuta manciata di cubani. Nel grande salone delle conferenze viene annunciato il dibattito previsto dal programma: “il concetto di patria insito nella letteratura”. In teoria, l’incontro dovrebbe avvenire tra scrittori italiani, quelli cubani e il pubblico della capital. Ma di cubani non se ne scorge l’ombra, realtà che trasforma l’evento, sin dall’inizio, come qualcosa di virtuosamente inesistente. Seduto in una platea deserta affianco ad Elvira, mi chiedo dove sia Damian, o perché lo scrittore di cui mi ha parlato, Pedro Juan Gutiérrez, non sia stato invitato al confronto, quale rappresentante perfetto della vita di L’Avana, e non solo della sua letteratura. Di fronte ai miei occhi, scorrere così la rappresentazione di un’opera buffa: da una parte gli scrittori italiani, provenienti da una terra di poeti, santi e naviganti, mal abituati al senso patrio; da sempre poco più che un concetto, come insegnò Montanelli affermando: il miglior italiano è l’anti italiano.
Dall’altra, poche manciate di naufraghi a rappresentare l’intero popolo di un’isola zattera abbandonata ben oltre la deriva, lontana dalla patria come Ulisse lo fu da Itaca, per quarant’anni peregrini. Mi chiedo come si incontreranno le due parti, su un argomento, quello patrio, alieno su entrambi i lati. Solo un linguaggio letterario d’alto livello salverà capra e cavoli? Ho la sensazione che difficilmente gli interlocutori apprenderanno l’uno dell’altro. Gianni Minà fa gli onori di casa, accomodandosi nell’ampio tavolo antico messo al centro del salone, di fronte alla platea vuota. Alla sua destra Dacia Maraini e Maurizio Maggiani, sulla sinistra uno sconosciuto saggio del sinedrio e Lopez Hernandez, un fuoriuscito uruguaiano che da vent’anni riscuote onori alla corte di Castro. In pratica, non c’è nessun cubano presente all’evento.
Decido di aprire il mio Moleskine e concentrarmi sui discorsi che sbarcheranno dall’arca italiana. Minà, voce fluida e pastosa, assicura che l’espaliano da lui sfoderato, costituisce il tentativo meglio riuscito di una sua personale approssimazione allo spagnolo, nonostante i moltissimi anni passati in America Latina. Se ne scusa, sia con gli italiani, sia con Cuba. Il vecchio telecronista, dichiarandosi commosso nell’accogliere gli insigni connazionali in un’isola che considera una seconda patria, si augura che l’intellighenzia presente possa simboleggiare l’inizio d’un maggior rafforzamento dei rapporti italo — cubani. Loda le doti della segunda jente suya, capace d’un livello di scolarizzazione pari a quello italiano, d’assistenza sanitaria con media pro capite tra le più alte al mondo.
Puntualizza la presenza d’un fermento artistico teso all’esportazione nel mondo dell’anima musicale cubana, come mai era accaduto, dimostrazione del modo in cui l’isola sia riuscita a eludere il blocco vergognoso imposto a Castro, e alla sua gente, dagli Stati Uniti per oltre quarant’anni. Buena Vista Social Club è solo la punta d’iceberg di un intero movimento. Accomodandosi al centro della scrivania, lo sconosciuto saggio del sinedrio si preoccupa di dare inizio all’incontro con un rapido volo pindarico dedicato al panorama della recente letteratura italiana.
Sostiene, infatti, che per vent’anni, il genere romanzesco ha conosciuto un vero e proprio periodo di glaciazione, conseguenza dei movimenti intellettuali sessantottini che avendo interposto nella cultura, la politica alla letteratura, decretando la fine dell’IO rispetto alla valenza del NOI, ha puntato più sul calcolo dei programmi lavorativi comuni, piuttosto che sul genio effervescente dell’individualità creativa. Successivamente alla caduta dei vincoli ideologici che elessero a cavallo di battaglia il genere saggistico, fu ripresa la via del ritorno al romanzo. Il segnale più importante in questo senso venne tracciato dal Il nome della rosa, un testo che nonostante le sue astuzie, non si è vietato il piacere di narrare.
Eco pubblicò Il nome della rosa nel 1979, lo stesso anno, Italo Calvino, diede alle stampe Se una notte d’inverno un viaggiatore, romanzo ambiguo ma dotato d’ ineludibile capacità auto-contaminativa, rinnovando il corso della sua stessa narrazione. Il saggio del Sinedrio, nonostante il ritmo pacato, sfodera un linguaggio affabulatorio. Mi chiedo, però, quanto di quel parlar forbito in italiano, rimarrà nei ricordi della sparuta schiera di cubani che assiste a questo incontro mondiale, Italia — Cuba. Il saggio del Sinedrio parla bene: con Italo Calvino si è aperto, in Italia, il filone di una prosa esatta e cruda, non certo amena da virtù di leggerezza.

Da Calvino in poi potremmo enumerare circa un’ottantina di talenti (il giro del mondo letterario in ottanta talenti) che hanno avuto il merito d’arricchire un filone, quello della narrativa, in grado di recuperare le radici del romanzo storico, contemporaneamente a una coscienziale immersione nel fantastico, ma senza perdere di vista, d’altro canto, l’ironia ben ancorata alle strutture d’una lingua in estinzione (fine del viaggio in mongolfiera). Trova notevole fortuna il romanzo poliziesco, e varrebbe davvero la pena indagare le motivazioni d’un tale successo.
Le storie del commissario Montalbano, personaggio centrale dell’inventiva di Camilleri, che non del tutto casualmente richiama a memoria il cognome dello spagnolo Montalban, similmente a quanto avviene nelle vicende imbastite dal novelliere catalano, permettono, attraverso l’architettura del poliziesco, di recuperare il materiale magmatico, apparentemente perso, del realismo verista, se è vero che ogni particolare sguardo nasconde un potenziale omicidio. Degli ipotetici ottanta talenti, oggi, ne sono presenti una fitta rappresentanza; da un lato, perché incarnano la geniale creatività del talento puro, dall’altro, perché con opere e stili, identificano completamente gli svariati panorami che si sono susseguiti lungo la via del romanzo italiano, dalla “glaciazione” in poi.
Prima le donne, dunque: con Dacia Maraini e il suo La lunga Vita di Marianna Ucrìa possiamo considerare rappresentato il femminismo italiano. Gina Lagorio, autrice di Autobiografia e memoria di paese, Il bastardo e Tra le mura stellate, è riuscita a sfumare il panorama femminino con una profonda e clemente saggezza, mentre, chi ha sorpreso tutti, è Simona Vinci, un’esordiente capace di stimolare la riflessione, raccontando e affrontando la realtà di situazioni difficili, quanto scomode, riguardanti un mondo particolare come quello Dei bambini non si sa niente.
Terminiamo con Irina Baijini, italoamericana, che seguendo un’ispirazione appassionata per l’esoterico caraibico, supportato da studi di letteratura spagnola, si dedica da anni al tema della Santeria. Gli uomini: Marcello Fois, autentico intellettuale che non disdegna l’impiego del dialettale sardo, radice dell’isola natia, per amalgamare storie dove si evince una determinata quanto raffinata cultura narrativa. E che dire degli artigiani del giallo? Massimo Carlotto, ardito autore de La verità dell’alligatore e Carlo Lucarelli che usa i tipici arnesi del poliziesco per far esplodere situazioni deflagranti in contesti sociali e storici ad alta intensità evocativa? Luther Blisset, sono — perché sono in quattro — l’originale scommessa d’un progetto avanguardista proteso al recupero del genere “epico medioevale”.
Scelto un filone o un argomento ad ampio respiro, si sguinzagliano sull’impianto storico, dedicandosi ognuno alle singole parti d’un romanzo che verrà alla fine imbastito “d’ensemble”. Q è il loro ultimo titolo ed entusiasmante lavoro. Ambientato negli oscuri tempi e lande nordiche della controriforma, delinea lo scontro — misterioso e avvincente — tra un cacciatore d’eretici della Santa Inquisizione e un fervente sostenitore della ribellione Luterana. Maggiani non abbisogna certamente di presentazioni, vincitore del premio Strega con Il coraggio del pettirosso, e autore d’ Una regina disadorna, è uno che ha praticato mille mestieri prima d’approdare alla prosa, tra gli altri, maestro per bambini ciechi, aiuto regista, fotografo, impiegato comunale.

È uno che riconosce quanto lo scrittore sia il mestiere più bello al mondo, perché poco faticoso e redditizio! Uno che capisce molto bene, insomma, quanti aspirino al parnaso. A queste parole, non posso esimermi, dal girarmi e osservare Elvira nel suo intento di comprendere o afferrare almeno qualcosa di quanto viene detto, qui, a casa sua. Di colpo, la sua vita, i suoi tentativi di realizzarsi come poeta, mi appaiono come la lotta eroica di un individuo dotato di una forza di volontà straordinaria, e un sentimento di tenerezza mi spinge a cingerle le spalle con il braccio. Uno che ha fatti suoi i precetti “maggianiani” è sicuramente l’elegante Silvio Mignano.

Sostituto dell’ultima ora di Stefano Benni — costretto alla defezione — è già di casa. Ha vissuto a L’Avana per anni, e a tal punto, da accompagnarsi — quest’oggi — con la bellissima moglie di Miramar. Un matrimonio a tutto tondo con la capitale che viene suggellato, proprio in occasione della fiera mondiale, dall’uscita del suo ultimo lavoro: Una lezione sull’amore. Nico Orengo fa parte d’una particolare corrente minimalista. Il suo raccontare, defilato tra piccoli borghi della Liguria, terra di Calvino, sorprende per i bizzarri personaggi; figure raffinate e marginali che dichiarano “sottovoce” la loro indifferenza per la vita del lettore contemporaneo, banale nel fragore della comunicazione di massa, spinto sempre più in là da acceleratori ben pigiati, pressato da un coro d’alte voci modulate spesso su volumi esagerati.
Nei libri di Tiziano Scarpa si gode l’alta tecnologia del racconto, esito d’un accurato e cesellino studio, tipico della scuola architettonica veneziana. “Il Tiziano”, esegue spesso un impianto letterario evocatore dell’“orror più truce”; sapiente miscela tra sfrenato surrealismo e ironia contagiosa. Già il titolo del suo ultimo divertissement, Occhi sulla Graticola, né da testimonianza. Stefano Tassinari, invece, è scrittore molto accorto nei riguardi dei tempi e dei ritmi generazionali. L’interesse lo spinge a una riflessione profonda nei riguardi della convivenza tra padri e figli, e Assalto al cielo costituisce l’apoteosi letteraria di un tale sforzo analitico.
Un via vai di filosofia
Di fronte all’Arca degli scrittori italiani approdati a L’Avana, e materializzatisi alla presenza d’una sparuta manciata di cubani, il socratico fauno assopito in me, al risveglio, sghignazza segretamente trattenendosi a fatica. Cosa possono aver capito, Elvira e i pochi habaneros seduti in sala, del brodo primordiale versato loro addosso in italiano, con indubbia abilità accademica, dal saggio del sinedrio?
Un commento di Borges, sembra echeggiare da lontano: M’interessano moltissimo le parole perché mangio piuttosto bene! I cubani presenti, potevano affermare la stessa cosa? L’incontro si presentava davvero impari, sin dalla manovra d’approdo di quell’Arca battente bandiera italiana, timonata, nel preludio iniziale, dal saggio del sinedrio, e giunta con gran destrezza all’attracco, ormeggiandosi sin dentro i saloni coloniali del Palacio del Segundo Cabo. Un’esecuzione perfetta, che non ha nemmeno dato il tempo ai cubani presenti di sventolare fazzoletti bianchi, né di benvenuto, né per manifesta e palese inferiorità numerica. Lopez Hernandez prende la parola, ereditando dal desaparecido Gianni Minà, la conduzione “patria” del dibattito dalla parte di Cuba. Il primo è un italiano, il secondo un uruguayano; mi chiedo che senso abbia tutto questo.

Dando il benvenuto agli illustri ospiti italiani, vorrei citare brevemente — visto l’argomento che verrà trattato in questa tavola rotonda — le parole del paladino più illustre che Cuba abbia avuto in tal senso. Il padre della patria, il suo apostolo principe: José Martì. L’apostolo dichiarava spesso d’aver due patrie, Cuba e la notte, cosa che lo spinse a vivere nella continua dualità tra luce e ombra. Dove andava a parare l’uruguaiano? Perché in una riunione intellettuale così importante per l’isola, non ne trattava semplicemente la vita attuale, fatta di essenze e di assenze? Al contrario, Lopez resuscitava il massimo esponente del suo passato secolare. Biascicando in spagnolo gli aspetti più banali della “materia patria”, si tramutava in uno sbilenco messia, che i pochi cubani presenti seguivano con occhi melliflui, seduti ai margini della tavola rotonda, come dal resto del mondo.
Ciò che meraviglia l’apostolo è la costanza che riserva in sé il vitale, l’indiscutibile affermazione d’“Essere di fronte al Niente!”. La mia vita, in ugual misura, se ne sta tra luoghi reali e immaginari. A volte, sono talmente incosciente dell’impalpabile confine che esiste tra l’uno e l’altro, da non riuscire a riconoscerli e a ricordarli. La mia volontà spesso non riesce a decidere da che parte stare. Nel reale o nell’immaginario? In Uruguay, dove sono nato, o a Cuba, dove vivo da vent’anni? Vista contemporaneamente da questi due antipodi, però, la patria immaginaria mi lancia richiami suadenti, sorta d’universo dalle molteplici sfaccettature, geografia talmente profonda, che potrei immaginare e raccontare per ore intere. Dacia Maraini, trovando poetico l’appoggio della sua mano destra sotto il mento, arresa a catino, e resa in dolce posa grazie all’avambraccio piegato a sostegno, guarda Lopez con soavità quasi materna. Nel suo volto rivedo l’identica beatitudine colta un attimo prima su quello di Elvira, ammaliata dal parnaso, pur comprendendo poco.
Io taglio di sghembo la riunione perdendomi nelle mie riflessioni, conseguenza del preambolo introdotto da Lopez e per colpa dei trattati filosofici comperati, proprio qui di fronte, in Plaza de Armas, nella bancarella di Damian: Martì considerava la vita uno sforzo perpetuo, che nella radice più remota coincide con ciò che il filosofo olandese Spinoza definisce conatus esse preservandi. Vivere, di conseguenza, è il minimale e continuo disvivere, un infinitesimale togliersi la vita, rimontando la corrente di quel fiume che sfocerà nel mare del morire, ossia il Niente. La vita, quindi — tutta la vita — è pura contingenza, azzardo, e poco importa fino a che punto si possa seguire il cammino da lei stessa tracciato. Il cammino, infatti, è costituito da ostacoli e difficoltà, e uno qualsiasi di questi potrebbe interrompere il processo vitale. Si potrebbe quasi affermare che l’intera vita è l’incredibile equilibrio d’un vastissimo repertorio di disequilibri, tra i quali, resta in agguato il Niente.
 Di tanto in tanto, riaffiorava sulla mia superficie cosciente, il continum di Lopez: I tratti della patria reale, ad esempio, la trovo ben presente in cucina, dove ne distinguo apprezzabili qualità. Ancora una eco borgesiana, quell’interessarsi alle parole, per il solo fatto di mangiare piuttosto bene? Vivere per Martì è un cammino ascensionale che non può smettere d’essere così, pena l’auto-annullamento. Di conseguenza, la vita si fa con tutti gli avanzi fuoriusciti da ciò che potrebbe costituire il conflitto con se stessa. Non è che la vita debba superare qualcosa di alieno alla propria realtà, però, potrebbe darsi, che quel qualcosa si trovi ben al di là della vita stessa. La vita è il costante impegno ed impiego, l’opera permanente, il trionfo eterno! È per questo che la vita s’impone soprattutto sull’uomo, essere vivo per eccellenza. In nessuna maniera propone facilitazioni, men che meno oziosità, all’essere vivo! Scopro, così, quanto aderente e riflettente la realtà vitale della Cuba odierna sia il pensiero puro di Josè Martì.
Di tanto in tanto, riaffiorava sulla mia superficie cosciente, il continum di Lopez: I tratti della patria reale, ad esempio, la trovo ben presente in cucina, dove ne distinguo apprezzabili qualità. Ancora una eco borgesiana, quell’interessarsi alle parole, per il solo fatto di mangiare piuttosto bene? Vivere per Martì è un cammino ascensionale che non può smettere d’essere così, pena l’auto-annullamento. Di conseguenza, la vita si fa con tutti gli avanzi fuoriusciti da ciò che potrebbe costituire il conflitto con se stessa. Non è che la vita debba superare qualcosa di alieno alla propria realtà, però, potrebbe darsi, che quel qualcosa si trovi ben al di là della vita stessa. La vita è il costante impegno ed impiego, l’opera permanente, il trionfo eterno! È per questo che la vita s’impone soprattutto sull’uomo, essere vivo per eccellenza. In nessuna maniera propone facilitazioni, men che meno oziosità, all’essere vivo! Scopro, così, quanto aderente e riflettente la realtà vitale della Cuba odierna sia il pensiero puro di Josè Martì.
“Ritorno” nel Palacio del Segundo Cabo, proprio nel momento in cui Maggiani riconduce l’incontro sul binario del tema patrio, insufflando sull’argomento un equilibrio di raffinata poesia: Sono nato difettoso, e per questo, romanziere. Ho il difetto d’una nostalgia che provai a sei anni nel buio d’un cinema che dava un film di Luchino Visconti. La colonna sonora, riducendomi alle lacrime, richiamava qualcosa che non potevo ricordare; un bimbo non ha memoria — ancora — eppure quel ricordo indefinito mi colmava di malinconia. Oggi credo di scrivere a causa di quel difetto malinconico, il racconto è la tensione che mi spinge a riconoscere quelle note in un viaggio creativo, cerco un paesaggio che non ho mai visto, che non incontrerò mai, di cui non ho alcuna traccia, ma che rappresenta esattamente quella nostalgia. Per credermi italiano, però, devo fare uno sforzo intellettuale: rammento dove sono nato, le facce della mia famiglia, le sfaccettature della lingua. La patria per me si riassume in un’immagine precisa che non necessita d’altro: una terra tenuta a battesimo da un re montanaro, incoronato dal suo popolo marinaresco, eppure, noi liguri, non siamo mai appartenuti a quel re, come succede alle onde del mare che nulla sanno delle montagne. Quando scrivo invento paesaggi inseguendo una nostalgia, così accompagno il lettore dentro la mia patria immaginaria.
La patria immaginaria! Ecco dove potevano trovare un punto d’incontro due alieni universi venuti a contatto. I cubani, quanto gli scrittori italiani, non potevano che comprendere una patria immaginaria. Cos’altro attendersi, d’altro canto, da quelle reali? Lopez, colse immediatamente l’attimo per mettersi in bocca il filo d’un altro “fuori tema” da servire ai naufraghi cubani presenti: lo scrittore pesca nel territorio dell’infanzia. Terra innocente, come sostenevano Pascoli e Pavese. Luogo del ritorno dove cogliere sentimenti puri ed inalienabili. Quel ritorno all’infanzia sapeva di controsenso! Certo che era il luogo sacro dei sentimenti puri ed inalienabili, peccato che Cuba fosse luogo d’uomini costretti, dall’infanzia in poi, a far passare il tempo corrompendo valori, svendendo anime, mentre l’infanzia di Lopez rimaneva insabbiata sulla sponda, più vicina a Cuba, del Rio de la Plata. Carlo Lucarelli si dimostrò molto sensibile nel suo contributo alla disquisizione, concentrandosi sui disguidi quotidiani comportati dal concetto di patria. Motivo di fondamentale crescita per l’inesistente pubblico cubano del Segundo Cabo: i carabinieri mi fermano spesso per controlli lungo le strade emiliane. Guido un’automobile immatricolata nella piccola repubblica di San Marino, mentre porto un cognome che non è uguale a quello di mio padre. Le prefazioni dei libri che scrivo affermano che sono di Parma, quando invece vivo a Bologna. A dir la verità, mi riesce di sentirmi italiano soltanto quando mi capita di trovarmi in sintonia, o d’identificarmi, con la parte buona dell’Italia. Per il solo fatto d’essere buono, calmo, colto, generoso — insomma — quando faccio parte di quella folta schiera che in Italia si dice ancora Brava Gente.
La vita abbassa, non ci rimane nient’altro da fare che elevarla, mi convinco. Abbassa — certo — causa l’indifferenza di cui essa stessa consiste. Indifferenza che solo l’uomo è capace di scoprire, stanare e contrastare, sostituendola con un significato determinato! Questo colse chiaramente nell’antichità lo stoico greco, che propose di vivere secundum natura, seguendo sì il corso della vita, ma rendendolo degno, alienando l’apatia.

Dacia Maraini prende la parola, interrompendo il filo dei miei pensieri: io sono fermamente convinta che il concetto di patria viene creato attraverso un fitto intreccio di costrizioni. Quando tali costrizioni risultano assenti, sorge un po’ di diffidenza nei confronti del concetto patrio. Sul momento, spero tanto che la Maraini si riferisca a Cuba, e che il suo preambolo costituisca una mitica arringa di critica all’idealismo ottuso imperante sull’isola. Per me il luogo della patria si trova dove mi è facile incontrare persone che conosco, che mi sono care, posti che mi piacciono, dove vivono personaggi d’una letteratura in grado di rappresentare una geografia mentale che distinguo facilmente.
Quando mi reco in posti che hanno costituito le scenografie d’un racconto letto e amato, ad esempio, finisco per cercare e riconoscere in quella geografia reale gli stessi particolari letterari. Meditando su quanto mi accade, sorge nei pensieri il dubbio spontaneo che esista in me, come in qualsiasi altro uomo, una sottile corrispondenza tra due mondi paralleli in grado di sussurrarsi e influenzarsi a vicenda, come in un mistero che trasbordi continuamente tra reale e immaginario. Riflettendo in questo modo, giungo spesso all’immancabile conclusione che sia occultata in me, una coscienza capace d’arrivare prima, in grado d’anticipare la realtà oggettiva, di riconoscere i tratti d’una famiglia affettiva. Lì, sospetto che risieda la patria più vera e pura.
Ed invece, deluso, proseguo nella mia meditazione parallela: esiste nell’uomo una dualità tra interiore ed esteriore, giammai potrebbe darsi il caso d’un essere umano vivo senza mondo, senza contorno, sia quel che sia. Nel corso della storia umana è intervenuta, però, la civilizzazione (ben differente dalla civiltà), vero paradigma del mondo esterno. Togliendo spontaneità al singolo individuo ha finito per trasformarlo — come sostiene Bergson — in utensile per fabbricare nuovi utensili. La civilizzazione del mondo esteriore ha esposto e sottomesso l’uomo all’indifferenza per la sua stessa vita interiore. Sono davvero così rare le volte che a un uomo capiti d’osservarla direttamente, troppo spesso si accontenta soltanto d’ombre oblique. Conseguenza? Abortisce le proprie idee, e così, sempre più frequentemente, le idee individuali vengono sostituite da quelle civili: le idee delle idee.
Fuoriuscire da questa continua cecità e indifferenza, per Martì, significa ricongiungersi in un tutt’uno con il tutto — energicamente — con la vita in quanto tale. Come se la vita d’ognuno potesse ritornare a se stessa, confondendosi in un unico fluire e confluire di luce, eludendo la morte, grazie a ludici, doppi, tripli, salti mortali, per schivare le ombre oblique fuoriuscite dalla degradante fucina d’utensili.
Il viatico che conduce verso la mia dolce patria, è senza dubbio l’uso della lingua. Ascoltare, leggere o adoperare la lingua italiana dei nostri padri, mi conduce a lacrime di commozione. Ai dialetti, molto più sensuali e carnali, riconosco un’inventiva e capacità evolutiva molto più spiccata della stessa lingua nazionale, eppure, è l’italico più puro che riconosco quanto padre e pittore impressionista. Nonostante sia consapevole di quanto sia forte in me tale dicotomia, propendo per la difesa del puro nella lingua madre. L’invasamento nei dialetti, comporta senza dubbio una mortalità della purezza originaria, proprio di questi tempi, in cui la malattia della lingua è questione molto sentita in materia di linguistica generale. Esiste sicuramente un disamore per la propria lingua da parte degli italiani. Il fatto, che mi rammarica molto, riesce a tramutarsi di fronte ai miei occhi come un conseguente e riflesso disamore per l’italianità stessa. La cosa è palpabile, divenendo evidentissima, quando mi capita d’incontrare le comunità italiane all’estero. Nella Buenos Aires argentina, l’80% della popolazione è d’origine italiana, eppure v’è un’estraneità totale nei riguardi della conversazione in lingua madre. A New York, va’ anche peggio! Quando, presso l’Università più famosa della città, si propose l’avvio d’un corso di studi, e di conseguenza, la creazione d’una facoltà d’italiano, furono proprio gli italiani d’origine ad opporsi.
Il poliziesco Lucarelli, decide d’interrompere il monologo daciaiano in italiano, per affermare come sia normale, invece, lo “sporcarsi” delle lingue. Di più: quanto il “sintomo” costituisca un segnale di salute linguistica, di vitalità, di forza innovativa. Il Lopez uruguayano, coglie al volo il tema e lo innesta sull’identità dell’isola: Lezama Lima amava affermare che la cultura cubana, e in particolar modo quella popolare, riuscisse a nutrirsi con tutto ciò che le capitasse a tiro. Secondo il mio punto di vista, tale predisposizione è divenuta eredità anche del mondo culturale cubano moderno, capace, nonostante chiusure ed embarghi, a dimostrare capacità d’assimilazione insospettate e insospettabili.
Nico Orengo scende nel simposio, scocca la mossa successiva sulla scacchiera italica e fa avanzare i pedoni del proprio ragionamento: lo scrittore è uno senza patria, non può aderire ad alcuna concezione di patria poiché è insito nella sua stessa natura inventare forme nuove, diverse, tese ad abbattere paletti, sfondando canoni specifici. Lo scrittore non risiede in patria, né in quella reale, né tanto meno in quella immaginaria, vista la propria indole al vagabondaggio. Lo scrittore è un vagabondo, un nomade.

E Mauri, subito dietro, a controbattere: io mi chiedo come si possa imbarcarsi in certi discorsi, quando viviamo in una continua contraddizione. Proprio non lo so. Un’analisi logica in questo senso risulta davvero difficoltosa. È vero! Siamo nostalgici d’un mondo mai esistito che ci induce a nutrire mille timori nei confronti della globalizzazione, eppure, mai e poi mai il mondo è stato un posto tranquillo, mai le lingue hanno conservato purezza, da sempre sono cambiate, influenzandosi, modificandosi. Di cosa dovremmo preoccuparci se il 98% delle parole che parliamo e scriviamo, erano già in Dante? Perché tanta preoccupazione?
Da un lato, nutriamo un certo fastidio per la globalizzazione, temendo che sia in grado di eroderci le consolidate certezze sulle quali ciascuno vive, come se potesse minacciare le sacrosante e intime consapevolezze che ci permettono di considerarci individui unici, irripetibili — tutto sommato — patria! Dall’altro, la stessa globalizzazione, costituisce una sorta di rassicurazione collettiva alla normalità, al branco. In Iran ci si sente più normali -“nel mondo”- bevendo coca cola piuttosto che acqua! Negli italiani, poi, il senso patrio è vivo soprattutto quando siamo all’estero, come oggi, ad esempio.
Ci troviamo a L’Avana perché dovremmo confrontarci, e tessere un dialogo, con uno sconosciuto universo caraibico, e invece non facciamo altro — esprimendoci in italiano — che correre dietro alle nostre cosucce. Senza tradire la benché minima incertezza, senza chiederci se gli interlocutori riunitisi attorno alla tavola rotonda, capiscano molto delle nostre discussioni. Di cosa siamo patrioti? Da bravi italiani — brava gente — il nostro patriottismo lo sguinzagliamo puntualmente, e con gran talento, quando siamo all’estero, quando ci troviamo “in lotta” con il nemico straniero. Allora sì che la globalizzazione diviene una minaccia. Eppure facciamo parte, in particolar modo noi scrittori, d’una razza privilegiata, speciale, coloro che nutrono e sono nutriti dalla grande anima del mondo, sottile ed infinita. Non dovrebbe già questo essere motivo di propensione al nuovo? La letteratura, in fin dei conti, produce realtà: l’intento dello scrittore, infatti, come in ogni artista, è quello di creare qualcosa di nuovo, qualcosa che prima non c’era, l’invenzione d’una realtà che a poco a poco prende anima e forme proprie in una progressione spontanea e diretta.
Quali patrie e confini — quindi — dovremmo considerare? L’atto del creare è di per sé sconfinamento divino nel divino. Il confine, quindi — sempre che esista — è confine più mentale che geografico. Il solo fatto d’essere artista dovrebbe aver già di per sé provveduto a sciogliere l’intera e retrostante zavorra palliativa, non vi pare? In geografia esistono soltanto confini naturali, ai quali la stessa natura non bada. Gli altri confini, dagli storici ai virtuali, costituiscono le chiusure dell’uomo poco spirituale, materialista, egoisticamente cieco. Un cieco capace di scorgere confini patri che nella realtà si limitano a meri concetti, l’uno derivante dall’altro e viceversa.
 A ben guardare, confini e patrie esistono soltanto perché determinati dalla paura del diverso, “del chi sta là fuori”, sia a livello mentale sia in quello geografico, dove si “pensa”, si è sicuri, e si dà per certo, che “quello la fuori” proceda armato fino ai denti, e possa sferrare l’attacco da un momento all’altro, come nel Deserto dei Tartari di Buzzati. In questo modo di “vedere” il rischio è quello di passare la vita intera simili ad infinitesimali tenentini Frodo appollaiati sugli spalti, arroccati sui confini patri scrutando impassibili un vuoto orizzonte polveroso, fin sull’orlo d’un’assurda speranza, quella di voler almeno vederlo arrivare il nemico, armato sino ai denti …inutilmente sin sulle soglie della vecchiaia e della morte.
A ben guardare, confini e patrie esistono soltanto perché determinati dalla paura del diverso, “del chi sta là fuori”, sia a livello mentale sia in quello geografico, dove si “pensa”, si è sicuri, e si dà per certo, che “quello la fuori” proceda armato fino ai denti, e possa sferrare l’attacco da un momento all’altro, come nel Deserto dei Tartari di Buzzati. In questo modo di “vedere” il rischio è quello di passare la vita intera simili ad infinitesimali tenentini Frodo appollaiati sugli spalti, arroccati sui confini patri scrutando impassibili un vuoto orizzonte polveroso, fin sull’orlo d’un’assurda speranza, quella di voler almeno vederlo arrivare il nemico, armato sino ai denti …inutilmente sin sulle soglie della vecchiaia e della morte.
Segue con Fame del libro a L’Avana










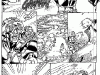




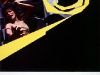





















Commenti
Non ci sono ancora commenti