 Sergio Penco è senza dubbio uno dei poeti più interessanti del secondo novecento triestino, un autore che a nostro giudizio, se avesse sgomitato di più nella “buona società della cultura”, avrebbe potuto ottenere quella visibilità e quella notorietà che altri poeti hanno ottenuto in città come Milano o Roma. Tuttavia è stato forse anche grazie a questo suo atteggiamento schivo nei confronti del teatrino della letteratura che egli ha potuto preservare la sua poesia da pericolose ricadute, mantenendola saldamente all’interno di una weltanschaung coerente e originale.
Sergio Penco è senza dubbio uno dei poeti più interessanti del secondo novecento triestino, un autore che a nostro giudizio, se avesse sgomitato di più nella “buona società della cultura”, avrebbe potuto ottenere quella visibilità e quella notorietà che altri poeti hanno ottenuto in città come Milano o Roma. Tuttavia è stato forse anche grazie a questo suo atteggiamento schivo nei confronti del teatrino della letteratura che egli ha potuto preservare la sua poesia da pericolose ricadute, mantenendola saldamente all’interno di una weltanschaung coerente e originale.
I modelli letterari di Penco, come egli stesso ci ha raccontato, sono i cantautori degli anni ’60, a cui si affiancano i vari Ungaretti, Caproni, Vinicius De Moraes e il Giulio Cesare di Shakespeare. C’è un filo sottile che congiunge questi modelli, o no? Vediamolo subito: l’orditura più intricata, e più strana di primo acchito, annoda assieme Ungaretti, De Moraes e i cantautori degli anni ’60. È del 1969 difatti l’uscita del disco La vita, amico, è l’arte dell’incontro (Edizioni Cetra), frutto della collaborazione tra Sergio Endrigo (istriano di Pola, città cara per motivi familiari anche a Penco) (1), De Moraes, Toquinho (cantautore brasiliano) e Giuseppe Ungaretti. Nel disco Ungaretti recitava le poesie di De Moraes — che aveva scoperto in Brasile, aveva tradotto e poi fatto conoscere al grande pubblico italiano — mentre Endrigo le cantava. Il cantautore istriano, che non era nuovo a questo genere di collaborazioni — aveva stilato testi insieme a Rodari e Pasolini — bussava alle porte dell’ambiente letterario per scardinare lo statuto classico della canzone italiana degli anni ’50. In un’intervista del 1995 dice: «Non so da dove venisse l’ispirazione delle mie canzoni […], io credo che affondassero nella mia malinconia austro-ungarica che ha qualcosa in comune con la saudade brasiliana: la consapevolezza della perdita dentro l’intensità di un’emozione» (2). Ecco dove volevamo arrivare: quel sentimento di malinconia e nostalgia in cui si amalgamano assieme il sorriso caustico dell’uomo mitteleuropeo e il canto di abbandono dell’uomo sudamericano convivono l’uno accanto all’altro nella poesia di Penco. Cosa c’entrano Caproni e il Giulio Cesare shakespeariano con tutto ciò? Molto. Si è parlato a lungo dell’antinovecentismo di Caproni e spesse volte non si è mancata l’occasione di accostare il poeta livornese a Saba; e se questo suo sfuggire alle classificazioni è già un primo elemento di corrispondenza con Penco, l’altro — più forte — risiede nei temi fondamentali della sua poesia, individuati da Raboni nella triade città-viaggio-madre (3): la città eletta di Caproni è Genova, quella di Penco Trieste; il viaggio esistenziale, realistico, espressionistico del primo (come in Stanze della funicolare, in cui sono le stazioni della funicolare genovese a segnare le tappe dall’alba al tramonto), contro il viaggio esistenziale, realistico e surrealistico dell’altro (come in Ballate dal Mary Celeste, in cui si narra dell’imbarco, della traversata e della deriva del brigantino Mary Celeste, salpato «alla volta di [casualità!] Genova con un carico di 177 barili di alcool») (4); la madre di Caproni, non solo quella reale (a cui dedica Il seme del piangere), ma soprattutto quella simbolica (il leit-motiv del mare quasi onnipresente), contro al mare-Grande Madre di Penco in cui «ogni cosa prima o poi viene risucchiata» (5). Non solo, il Nostro condivide con Caproni anche l’orrore per i giochi puramente sintattici o concettuali, per una poesia astratta dalla realtà in cui «non si nota nemmeno un bicchiere o una stringa» (6). E il Giulio Cesare? Non è Bruto il personaggio centrale della tragedia? E cosa rappresenta Bruto se non il cattivo per antonomasia, il traditore, il Giuda che si riscatta per la purezza dei suoi ideali? Bruto rivive in uno dei tanti «gatti neri come il carbone / sempre arrabbiati senza ragione» (7) che affollano le poesie di Penco, gatti che «bestemmiano e fanno a botte» (8), gatti malavitosi, ma liberi, che rispondono ad un altro principio di giustizia, quello degli emarginati, dei cristi da cunicoli, iellati da sette generazioni, che non hanno altro potere se non quello di tirare i sassi (9); e Bruto si maschera anche sotto i panni di Cucciolo, il nano che «passa le sue giornate / ad aspettare i treni alla stazione / oppure vicino al mare», «il solo, di noi, rimasto / a sorvegliare la polveriera» (10), ovvero colui che, al pari di Bruto, si sacrifica non per il proprio interesse personale, ma per il bene della comunità.
 Penco rappresenta a nostro giudizio un originale punto di svolta nella linea della poesia triestina del novecento. Assume in sé il riso sarcastico di Malabotta, ma non la sua predisposizione al verso contratto, all’elisione; da Cergoly la capacità di ridere dei fatti più tragici della Storia (il massimo esempio lo dà nei Canti clandestini), ma non il richiamo sistematico alla Mitteleuropa; da Carpinteri & Faraguna il modo di caricaturare i piccoli personaggi del quotidiano (Serbidiòla non è altro che una Spoon River nostrana), ma trasformandoli da semplici caratteri, bozzetti, a veri personaggi a tutto tondo di universo chiuso. I gatti, gli uccelli (la cui assidua presenza ci fa pensare a Saba), i pesci (in particolare i delfini), i personaggi presi a man bassa dall’immaginario collettivo (dal fumetto, dalla televisione, dalle favole e dalle leggende) che riempiono ogni spazio della poesia di Penco, sono tutti attori con una propria parte da recitare all’interno di un mondo con leggi ferree governato dal Dio-Mare, in cui il destino presenta due sole sbocchi:
Penco rappresenta a nostro giudizio un originale punto di svolta nella linea della poesia triestina del novecento. Assume in sé il riso sarcastico di Malabotta, ma non la sua predisposizione al verso contratto, all’elisione; da Cergoly la capacità di ridere dei fatti più tragici della Storia (il massimo esempio lo dà nei Canti clandestini), ma non il richiamo sistematico alla Mitteleuropa; da Carpinteri & Faraguna il modo di caricaturare i piccoli personaggi del quotidiano (Serbidiòla non è altro che una Spoon River nostrana), ma trasformandoli da semplici caratteri, bozzetti, a veri personaggi a tutto tondo di universo chiuso. I gatti, gli uccelli (la cui assidua presenza ci fa pensare a Saba), i pesci (in particolare i delfini), i personaggi presi a man bassa dall’immaginario collettivo (dal fumetto, dalla televisione, dalle favole e dalle leggende) che riempiono ogni spazio della poesia di Penco, sono tutti attori con una propria parte da recitare all’interno di un mondo con leggi ferree governato dal Dio-Mare, in cui il destino presenta due sole sbocchi:
Ma i poeti tramontano in mare
Come i pirati e i delfini,
e ravvivano il buio e diventano acqua salata. (11)
Oppure:
E prima che la forca ci spenda, marinai disertori e poeti,
ci accadrà di scorgere l’isola, un mattino,
e sbarcheremo schiamazzando con i coltelli e i picconi,
sfatti ubriachi, e scaveremo, e troveremo i dobloni
del capitano Flint. (12)
Tuttavia ci accorgiamo che il secondo sbocco, l’approdo stevensoniano alla fantomatica isola del tesoro, non è che un passaggio obbligato per la trasformazione in “qualcos’altro”, in un processo che Penco ci mostra linearmente:
Ricordiamo tutti gli uomini che pesano piuma
E nel corso degli anni diventano isole e poi poeti (13)
L’itinerario è chiaro: gli uomini diventano isole, le isole diventano poeti, e poi?
Poi, farsi mare (14)
 La figura dominante nella poetica penchiana è quella della metamorfosi. Se Kafka sa che la transitorietà, la caratteristica fondante del mondo moderno, può essere combattuta solo con la transitorietà, e che la sensazione dell’uomo moderno sta nel fatto di avere il mal di mare in terra ferma, ad un diverso grado anche Penco crea un mondo in cui l’unica certezza — paradossalmente — è la metamorfosi in acqua marina, e per evitare quel sentimento di spaesamento fa imbarcare tutti i suoi personaggi, affinché il mal di mare lo abbiano davvero, e affinché navighino con una sola certezza:
La figura dominante nella poetica penchiana è quella della metamorfosi. Se Kafka sa che la transitorietà, la caratteristica fondante del mondo moderno, può essere combattuta solo con la transitorietà, e che la sensazione dell’uomo moderno sta nel fatto di avere il mal di mare in terra ferma, ad un diverso grado anche Penco crea un mondo in cui l’unica certezza — paradossalmente — è la metamorfosi in acqua marina, e per evitare quel sentimento di spaesamento fa imbarcare tutti i suoi personaggi, affinché il mal di mare lo abbiano davvero, e affinché navighino con una sola certezza:
E puoi salvarti solamente
Se viene il gorgo. (15)
Se la cultura mitteleuropea è contraddistinta dalla sfiducia nella storia, dal rifiuto di risolvere le contraddizioni, dalla poetica del frammento e dalla conseguente non-riduzione della vita a sistema, Penco rappresenta il superamento di tale cultura, dal momento che egli rifiuta il frammento, rifiuta l’autobiografia come possibilità di circoscrizione di un’identità, risolve le contraddizioni organizzando forzati viaggi in mare e, pur mantenendo un esasperato pessimismo storico, tenta di aggirare il problema creando un progetto nuovo, di gruppo, un mito nuovo fatto di piccole storie perdenti che si sostituisca alla Grande Storia. Soprattutto rifiuta la cultura danubiana così come Magris l’ha raffigurata: «una fortezza che offre grande rifugio quando ci si sente minacciati dal mondo, aggrediti dalla vita […] sicché ci si chiude in casa, dietro le carte e i protocolli dell’ufficio» (16); anche gli uomini di Penco sono spesso frustrati impiegati (17), con la panciera trapassata di frecce, controfigure borghesi e fallite del generale Custer (18), ma non resteranno tutta la vita dietro una scrivania, essi prima o poi andranno sulla cima del Molo Audace e diventeranno rondini, e raggiungeranno finalmente la meta agognata, perché sia chiaro a tutti:
chi vuole un verso, chi una poesia,
ce n’è per tutti, solo un po’ di calma,
per cortesia.
Però Guadalajara
È roba mia. (19)
 Il sogno è Guadalajara, non Budapest, Praga o Vienna.
Il sogno è Guadalajara, non Budapest, Praga o Vienna.
Egli carica nella stiva l’umanità del marinaio Ungaretti, abituato ad avvistare porti sepolti e miraggi africani; i semi delle ginestre leopardiane e gli ossi di seppia tornati a riva di Montale; disegna sulle bocche dei suoi pirati le risate sardoniche di Cergoly, Malabotta, Carpinteri, Faraguna; invoca con preghiere buzzatiane l’arrivo del colombre; insegna alla ciurma i canti di De Andrè e di Vecchioni per i giorni di piatta, e tutti quanti li traghetta verso il sole del Sudamerica, verso Neruda, De Moraes, nelle vesti del mitico capitano Achab, con un solo interrogativo:
Dove sarà, di me, la miglior parte
quando sarò sbarcato dal Pequod? (20)
1. Cfr. S. Penco, Pola, in Ballate dal Mary Celeste, Gorizia-Trieste, Istituto giuliano di storia, cultura e documentazione, 1998, p. 33.
2. www.latinamusicaoggi.it/endrigo.htm.
3. Cfr. la prefazione di G. Raboni a G. Caproni, La scatola nera, Milano, Garzanti, 1996. Oppure, in una prospettiva allargata, P. V. Mengaldo, Per la poesia di Giorgio Caproni, in G. Caproni, L’opera in versi, Milano, Mondatori, 1998, p. XII: «Il viaggio, il congedo, l’esilio e simili, suoi temi dominanti».
4. S. Penco, Ballate dal Mary Celeste, op. cit., p. 13.
5. S. Penco, Dal mare, v. 3, in Ballate di Cane Nero, Caltanissetta, Salvatore Sciascia Editore, 2002, p. 12.
6. Cfr. l’intervista a Caproni in F. Camon, Il mestiere di poeta, Milano, Lèrici, 1965, p. 130.
7. S. Penco, Gatti, vv. 15-16, in Guadalajara, Venezia, Rebellato, 1978, p. 15.
8. S. Penco, I gatti neri, v. 5, in Ballate dal Mary Celeste, op. cit., p. 20.
9. Cfr. S. Penco, Persona seria, in Guadalajara, op. cit., p. 26.
10. S. Penco, Amici di gioventù, in Ballate dal Mary Celeste, op. cit., p. 43.
11. S. Penco, Come i delfini, vv. 12-14, in Ballate dal Mary Celeste, op. cit., p. 40.
12. S. Penco, L’isola, vv. 15-19, in Ballate di Cane Nero, op. cit., p. 36.
13. S. Penco, Poesia degli uomini di anima gobba (solidarietà), vv. 14-15, in Ballate di Cane Nero, op. cit., p. 22.
14. S. Penco, Farsi mare, v. 19, in Ballate dal Mary Celeste, op. cit., p. 67.
15. S. Penco, Trenta cannibali, vv. 23-24, in Ballate dal Mary Celeste, op. cit., p. 17.
16. C. Magris, Danubio, Garzanti, Milano, 1986, p. 163.
17. Cfr. Sergio Penco, Amici di gioventù, cit., pp. 42-43.
18. Cfr. Sergio Penco, La vera storia del generale Custer 3, in Guadalajara, op. cit., p. 34.
19. S. Penco, Spettacolo, vv. 14-18, ivi, p. 57.
20. S. Penco, La miglior parte, vv. 19-20, in Ballate di Cane Nero, op. cit., p. 19.
Il saggio su Sergio Penco è tratto dal libro di Luigi Nacci, Trieste allo specchio. Indagine sulla poesia triestina del secondo novecento, di prossima pubblicazione per le Edizioni Ibiskos. Attraverso un dialogo con gli autori e con i testi, il lavoro ricostruisce le linee forti e deboli della poesia triestina sviluppatasi dopo la scomparsa, nel 1957, di Saba e Giotti, due maestri indiscussi del primo novecento giuliano (per informazioni relative al libro è possibile contattare la casa editrice – www.ibiskos.it – oppure l’autore alla mail luiginacci@libero.it).
















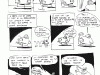



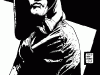
















Commenti
Non ci sono ancora commenti